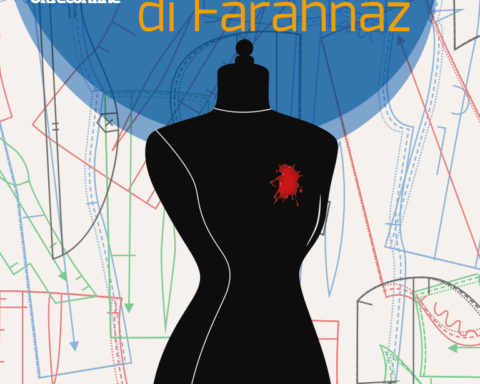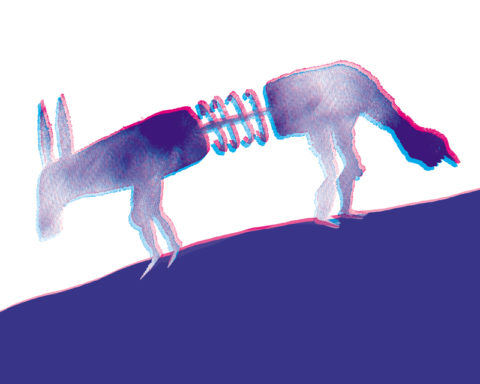Un racconto di Kemal Varol
Come in tutto il paese anche ad Arkanya subito prima del colpo di stato correvano brutti giorni. Ma lì la situazione era un po’ diversa. Invece che scontri tra destra e sinistra, ad Arkanya avevano corso scontri all’interno della stessa sinistra. Gli scontri principali non erano tra strutture diametralmente opposte tra loro ma tra fazioni divise in mille gruppuscoli. Quello spara a questo, l’altro cancella la scritta sul muro di qualcun’altro per scrivere la propria, quello tira nella sua cricca gli uomini di questo, una parola di tizio basta e avanza a far scoppiare il finimondo. Come successo per lo sciopero nella fabbrica di rakı, talvolta un pericolo comune placava quegli scontri, per qualche giorno era tutto rose e fiori, poi ogni cosa ricominciava tale e quale.
Il paese allora non era diverso da quello di adesso. Tre o quattro alberi, cinque o sei caffè, e una decina di botteghe che nemmeno loro sapevano cosa vendevano. Ogni cosa cambiava lenta lenta senza che nessuno se ne accorgesse. Ma poiché questo cambiamento richiedeva anni, nessuno ne era al corrente. Cambiavano i matti, le case, gli uffici pubblici, le donne. Ma il Giardino da Tè dell’Educazione Popolare era sempre al suo posto. Nessuno si ricordava di quando fosse stato costruito. Persino i più anziani del paese non sapevano stabilire una data. Come se appena fondata la Repubblica, a qualcuno fosse venuto in mente di costruire il Giardino da Tè dell’Educazione Popolare in quesl paese e ci avesse messo dentro il çaycı Şefik, perché garantisse l’ordine e servisse ai clienti il tè di contrabbando altrimenti detto “sangue di coniglio”. Con il Giardino da Tè Comunale adiacente si facevano concorrenza. Ma mai neppure una volta tra loro era scoppiato un battibecco.
Il çaycı Şefik, come tutti i çaycı, era un uomo pacato. Non si intrometteva nei discorsi dei clienti, non raccontava a altri i segreti degli uni, non se ne stava in mezzo come il prezzemolo. Non si sedeva accanto a nessuno, non drizzava le orecchie a quel che si diceva, ogni quindici minuti con il vassoio in mano gridava “Çaaaayçen!” cercando soltanto di far arrivare il tè ai clienti. Su una sola questione era molto sensibile. Appena lasciava i bicchieri sul tavolo estraeva la penna blu da dietro l’orecchio e scriveva quanti tè avesse portato a quale tavolo. Così sin dal principio si premuniva dai battibecchi che potevano nascere al momento di pagare il conto.
Conosceva da vicino tutti i clienti. Sapeva meglio della polizia chi era figlio di chi, chi la pensava come, che lavoro faceva. Secondo i clienti più avveduti del Giardino da Tè , dietro alle ricevute su cui faceva crocette di continuo era tracciato anche l’albero genealogico di quelli che sedevano al tavolo. Ma su nessun cliente faceva commenti con un altro. Distribuiva tè, faceva raccogliere i vuoti ai garzoni, inviava immediatamente le comande di soda, ayran e oralet, incassava il conto e allungava il resto, poi infilando le mani nella tasca del grembiule faceva tintinnare le monete Şefik.
Il Giardino da Tè dell’Educazione Popolare così come Il Giardino da Tè Comunale a quei tempi era diviso non in quattro, ma in mille parti. Ad ogni angolo sedevano gli uomini di una fazione diversa. I posti restanti erano assegnati agli uomini dei villaggi vicini venuti a vendere formaggio in paese e ai pensionati. Talvolta c’erano andirivieni e liti tra questo gruppo e quello, questo gruppo cercava di trovare il punto debole di quello. Sparpagliando sgabelli a destra e sinistra sotto gli alberi di gelso e di acacia un po’ parlavano tra loro, un po’ tenevano d’occhio gli altri gruppi. Tuttavia il luogo più prestigioso del Giardino da Tè dell’Educazione Popolare era senza dubbio la fontana decorativa vicina ai fornelli del tè. Sedersi su quella fontana non era cosa da tutti. Attorno alla fontana si radunavano gli uomini del gruppo più forte, oppure il gruppo che aveva messo la firma all’azione più impensabile acquisiva il diritto di sedersi lì per un periodo. Di tanto in tanto affondavano i piedi che avevano consumato le strade per tutto il giorno nel caldo dell’estate nella fontana ricoperta di foglie d’acacia oppure allungavano la mano fino alle gocce d’acqua spruzzate dagli zampilli proprio al centro della vasca. Poi le orecchie si tendevano alla radio che çaycı Şefik accendeva a ogni ora e quando si mettevano in ascolto dei fatti del paese i cucchiaini da tè avevano smesso di girare da un pezzo.
Davut Alacalı e i suoi sei amici quel giorno si erano appena seduti al Giardino da Tè dell’Educazione Popolare. Il gruppo più piccolo del paese era il loro. Ma erano tutti uomini coraggiosi. Non rivendicavano le loro azioni ma tutti sapevano bene che molti degli avvenimenti in paese erano opera loro. Soltanto loro ad esempio erano stai capaci di scrivere il nome del gruppo sul grande pannello su cui troneggiava la scritta “Benvenuti a Arkanya” e che poggiava un piede nel giardino del stazione della gendarmeria all’entrata del paese. Si diceva anche che erano stati loro a sparare al direttore della fabbrica di rakı che aveva provato a licenziare i lavoratori aderenti al sindacato.
Davut Alacalı e i suoi amici appena seduti sugli sgabelli avevano bevuto il loro primo tè e si erano messi immediatamente a parlare delle prossime azioni. Prima di dieci, quindici minuti un tipo arrivò di corsa dicendo fitto fitto qualcosa all’orecchio di Alacalı e scomparendo subito dopo. C’era un’aria di pericolo in giro. Çaycı Şefik si era accorto della situazione e guardava preoccupato a destra e sinistra.
Stando a quanto si raccontava dopo, Davut Alacalı e i suoi avevano ricevuto la notizia da qualcuno che la polizia avrebbe fatto incursione al giardino da tè e li avrebbe arrestati tutti. E davvero dopo poco la polizia con quattro o cinque auto fece incursione nel giardino da tè. Ma di Davut Alacalı e dei suoi amici non era rimasta traccia. Ci furono incursioni nelle abitazioni, i parenti furono torturati, vennero appese fotografie qui e là. Non si trovarono. Alla fine mentre gli altri sei dopo un certo tempo vennero arrestati e portati in prigione, di Alacalı nessuno trovò più traccia. Qualcuno diceva che era stato ucciso, qualcun altro giurava che fosse in prigionie in Siria. Neppure suo padre e sua madre seppero che fine avesse fatto loro figlio. Alla fine se ne andarono entrambi con questo dolore.
Quando venti anni dopo Alacalı comparve di nuovo, barba e capelli si erano ingrigiti. Avendo vissuto nei paesi del nord che non vedono il sole la pelle era bianchissima. Indossava un completo grigio sopra una lacoste bianca. L’Alacalı eccitato e pronto a scaldarsi per un niente di un tempo adesso appariva come un tipo calmo e pacato.
Tornato dopo anni nella sua terra da cittadino svedese ormai niente era più come prima. La piccola Arkanya di un tempo era cresciuta con i migranti ed era irriconoscibile. Addirittura c’era da dubitare del fatto che quell’uomo un tempo avesse vissuto lì mettendo la firma ad azioni di ogni tipo. Guardò con tristezza le scritte di un tempo cancellate sui muri.
Per prima cosa fece visita alla tomba di suo padre e sua madre morti mentre era in esilio. Poi con le mani intrecciate dietro la schiena scese nella piazza di paese. In centro chiacchierò un po’ con quelli che vagamente si ricordavano di lui. Chiese dei suoi vecchi compagni. Qualcuno si era sposato e aveva messo su famiglia qualcuno era impazzito per le torture subite dentro altri erano migrati a ovest. Senz’altra scelta continuò a camminare lento in centro.
Com’era giunta la notizia che la polizia sarebbe venuta a prenderli, Alacalı era corso a nascondersi nel villaggio di un amico. A dire il vero avevano preso diverse precauzioni per questo genere di eventualità. Se avessero subito un’incursione il gruppo si sarebbe disciolto immediatamente, ognuno si sarebbe prima nascosto nel punto stabilito e non si sarebbe mai messo in contatto con gli altri. Mentre gli amici in breve tempo erano stati scovati Alacalı si era mostrato abile. Dopo un po’ di tempo era andato a Nusaybin e da lì, grazie a un amico camionista, durante una notte era passato dall’altra parte del confine. Dopo essere rimasto nascosto a lungo in Siria, alla fine di un lungo viaggio durato giorni aveva richiesto asilo in Svezia con un passaporto falso.
Al contrario di ciò che si può credere Alacalı aveva avuto molte difficoltà laggiù. Non conoscendo la lingua non aveva parlato con nessuno per un certo tempo, all’inizio, bruciando di nostalgia per il proprio paese non aveva saputo cosa fare. Aveva tirato avanti con i tre spiccioli che gli dava il governo. Più tardi in Svezia erano cominciati a fluire rifugiati politici a fiotti. Tra loro c’era anche qualche conoscente. Era entrato a lavorare in fabbrica. Rispetto a qui, laggiù riceveva uno stipendio degno di nota. La sera frequentava le associazioni fondate da quelli che erano venuti dal paese, aiutava a stampare riviste che venivano fatte entrare di nascosto in patria. I fine settimana partecipava alle manifestazioni. I primi tempi aveva pensato che così facendo avrebbe potuto zittire il senso di colpa che gli cresceva dentro per essere scappato dal paese lasciando tutto sottosopra. Non fu così. Non era riuscito a zittirlo in nessun modo. Era stato in visita da diversi psicologi ma non sapendo la lingua come si deve non era riuscito a spiegare la sua pena. Per rimediare all’insonnia da cui non era riuscito a liberarsi sin dal giorno in cui aveva messo piede in Svezia, aveva preso medicinali. Ogni volta che era montato su un treno in Svezia, con il cuore in mano gli era venuto a mente quel treno che rallentava ai confini di Nusaybin e la notte in cui era fuggito. Per anni e anni il tempo che aveva lasciato indietro era venuto a sbattergli contro la testa come una pallina di gomma.
Eppure, se non erano stati gli amici venuti dopo aver lasciato il paese, la natura della Svezia gli aveva fatto bene. La pelle scura aveva cambiato colore diventando rosa come quella dei salmoni. Quando non aveva niente da fare si era perso nei boschi. E mentre camminava aveva pensato continuamente a Arkanya e alla vergogna di essere sopravvissuto. Col tempo si era separato anche dagli amici di questo paese del nord.
Alacalı dopo qualche tempo aveva conosciuto una donna svedese. Dice che fosse una donna bella tra le belle. Aveva i capelli biondissimi. Dice che la donna lo aveva amato molto. Lo aveva aiutato a curare le sue ferite. Dice che avevano avuto un figlio e una figlia dai capelli riccissimi. Alla più grande aveva dato il nome della ragazza alla quale non aveva mai aperto il suo cuore quando era in paese. Dice che aveva una casa a tre piani a sette chilometri a est di Stoccolma ma non si poteva definire ricco. Messi insieme due stipendi erano riusciti a comprare una casa simile. Dice che tutti lì avevano case simili. Dice che i figli di Alacalı per tutto il giorno giocavano correndo in giardino. Dice che gli piaceva molto passare il tempo con loro. Di tanto in tanto i figli gli chiedevano la sua storia. Dice Alacalı che non aveva potuto raccontare niente. Gli aveva detto soltanto che veniva da un paese lontano, da un villaggio incantato di quel paese lontano. Dice che raccontava ai figli favole infinite. Ma della sua vita aveva sempre taciuto. Dice che quello che aveva vissuto, quello che aveva lasciato indietro lo raccontava soltanto al cuscino. Dice che quando con sua moglie spegnevano la luce e poggiavano la testa sul cuscino ogni notte tutta la sua vita gli scorreva davanti agli occhi come una pellicola riavvolta.
Venti anni dopo ogni causa aperta contro Alacalı era caduta una dopo l’altra. Aveva preso un avvocato e gli aveva chiesto di fare qualche indagine. Dice che non ci fosse più alcun ostacolo a rientrare. Dice che aveva comunque esitato molto a venire. Alla fine, mettendo in conto ogni cosa, era montato su un aereo e era tornato. Come si aspettava era stato arrestato all’aeroporto. Al processo aveva saputo una volta in più che le cause contro di lui erano cadute in prescrizione. Poi per vedere meglio il paese aveva preso un autobus al posto dell’aereo. Non aveva creduto possibile che un paese potesse cambiare tanto in così poco tempo. Durante il viaggio non era riuscito a dormire dall’emozione. Fuori scorrevano montagne, pianure, anni. Tirando fuori la boccetta del cognac l’aveva buttato giù di nascosto. Neppure lui si era reso conto quando si era appisolato. Verso mattino uno degli assistenti di viaggio l’aveva pungolato, “Oh sveglia, siamo arrivati a Arkanya!” gli aveva detto.
Mentre girava in centro guardando a destra e sinistra con sguardo vuoto l’ho riconosciuto all’istante ma non lui. Quando dopo molto tempo si è ricordato ha gridato “Fazıl Abi!” e mi si è gettato al collo. Aveva un brutto aspetto. Nel paese dove era arrivato dopo venti anni ogni cosa ricordata sembrava infilarsi in lui come un coltello. Essendo andato direttamente al cimitero una volta uscito dalla stazione non aveva mangiato niente. Nonostante abbia molto insistito non si è voluto fermare a far colazione. Invece di mangiare voleva tornare il prima possibile all’ultimo giorno che aveva vissuto in questo paese. Capito il suo desiderio ho lasciato il negozio agli aiutanti e ci siamo incamminati insieme verso il Giardino da Tè dell’Educazione Popolare. E lungo la strada mi ha raccontato la sua storia.
L’unico luogo del paese e non essere cambiato era forse il Giardino da Tè dell’Educazione Popolare. Sotto gli stessi alberi c’erano gli stessi sgabelli. Persino le carte da gioco sui tavoli erano le stesse a sentir lui. I giovani giocavano a domino e a okey in un angolo. Altri giovani seduti in un altro angolo che di tanto in tanto sollevavano la testa dai giornali guardavano con sospetto quell’uomo ben vestito.“Non è cambiato niente” ha detto accomodandosi in un angolo. Non mi ero allontanato abbastanza dal paese per dire se qualcosa fosse cambiato. Non ho risposto. Poi ha chiesto di qualcuno dei vecchi. Gli ho raccontato la storia di alcuni conoscenti, è rimasto in silenzio, non ha detto niente. Mentre intrecciava le mani restando in silenzio sembrava fare i suoi conti. Forse pensava a che vita avrebbe avuto se non fosse fuggito, se non se ne fosse andato, se fosse rimasto correndo il rischio di subire torture e finire in prigione. Confrontava la sua vita con quella degli altri.
Intanto ho chiesto a quelli che passavano dalla via a fianco al giardino da tè se si ricordavano di lui. Quelli che strizzavano gli occhi fermi a lato del muro non lo riconoscevano. Detto il suo nome, quelli che se ne ricordavano sono corsi a abbracciarlo con nostalgia. Alcuni gli hanno voltato le spalle perché era fuggito, qualcuno è venuto a sedersi con noi. Quando siamo stati un po’ più numerosi ho alzato la mano e ho fatto cenno a çaycı Şefik.
“Şefik è vivo?” ha chiesto.
Con la punta delle dita gli ho indicato Şefik che stava facendo colazione con due poğaça vicino ai fornelli del tè. Da un lato sorseggiava il tè nel bicchiere, dall’altro mordeva velocemente i poğaça poaggiati sul tavolinetto. Era qualcuno da sempre legato al suo lavoro, che lavorava instancabilmente senza posa.
“Gli sono imbiancati i capelli ma appare sempre in salute,” ha detto Alacalı.
In quel momento mi sono accorto per la prima volta del cambiamento di Şefik. Aveva davvero i capelli bianchi. E aveva preso peso. Questo genere di cose le nota chi viene da lontano. Non chi rimane inchiodato al suo posto.
Inghiottendo velocemente il boccone che aveva in bocca Şefik ha fatto il segno di cinque al garzone in un angolo del giardino. Dopo poco ha preso i tè con due mani e dicendo un lungo “Sììììì” si è incamminato verso di noi.
Mentre posava i bicchieri sul nostro tavolo si è fermato per un attimo a guardare attentamente Alacalı. Tra di noi ci eravamo accordati da prima. Non avremmo detto niente di Alacalı, eravamo curiosi di sapere se lo avrebbe riconosciuto. Avevamo pur tutti in testa una pena chiamata tempo. Erano passati anni e anni.
Çaycı Şefik non ha parlato. Dopo aver messo i tè sul tavolo ha tirato fuori la penna blu da dietro l’orecchio e ha fatto due croci e mezzo sul foglio. Per essere sicuro dei conti ha guardato di nuovo i bicchieri di tè. Ha guardato di nuovo Alacalı. Non lo aveva riconosciuto. Sul volto non c’era la minima traccia che lo dimostrava. Eravamo scioccati. Voleva dire che Şefik invecchiava davvero.
Mentre distribuiva i tè Şefik non metteva le zollette di zucchero sul piattino. Tante volte si era preso con i clienti per le zollette inutilizzate che si bagnavano. Dopo aver poggiato sul tavolinetto la zuccheriera presa dal tavolo a fianco, come a voler provare ancora una volta che tutti gli abitanti di Arkanya erano le persone più tirchie del mondo, si è voltato verso Alacalı e gli ha detto “Mi devi sette tè Alacalı!”
Davut Alacalı non ha capito subito di cosa parlava çaycı Şefik. Si è voltato a guardarci con una strana espressione. Ma sentendo di essere in debito come tutti ha portato istintivamente la mano alla tasca.
“Il giorno che la polizia ha fatto incursione nel giardino avevate bevuto sette tè e siete scappati prima di pagare il conto,” ha detto Şefik.
Quanto ai debiti era molto serio. Infilando la mano nella tasca anteriore del grembiule pieno di monete le ha fatte tintinnare a destra e sinistra.
“Se saldi il debito in corone mi fai piacere” ha detto, “perché i soldi non sono gli stessi soldi. È passato così tanto tempo!”
Trad. G. Ansaldo

Corone è un racconto di Kemal Varol pubblicato con il titolo Kron nella raccolta Sahiden Hikaye (La storia davvero) da İletişim nel 2017.
©Diritti riservati per la traduzione italiana, Kaleydoskop, 2018 (su concessione dell’autore tramite İletişim Yayınları).
 Kemal Varol, nato nel 1977 in provincia di Diyarbakir è autore di diverse raccolte di poesie pubblicate nel 2013 con il titolo Bakiye (Il Resto), tre romanzi: Jar (2011), Haw (2014), Ucunda Ölüm Var (Alla fine c’è la morte, 2016), e della raccolta di racconti qui presentata. Il romanzo Haw nel 2014 è stato insignito del premio per il romanzo dedicato a Cevdet Kudret, è stato scelto come miglior romanzo dalla rivista Sabit Fikir (Idea Fissa) e inserito nella lista dei migliori 15 romanzi degli ultimi cinque anni da Milliyet Sanat Dergisi. Per lo stesso romanzo nel 2017 ha ricevuto una borsa del Pen America. La raccolta di racconti Sahiden Hikaye ha vinto nel maggio 2018 il Premio per i racconti dedicato a Sait Faik.
Kemal Varol, nato nel 1977 in provincia di Diyarbakir è autore di diverse raccolte di poesie pubblicate nel 2013 con il titolo Bakiye (Il Resto), tre romanzi: Jar (2011), Haw (2014), Ucunda Ölüm Var (Alla fine c’è la morte, 2016), e della raccolta di racconti qui presentata. Il romanzo Haw nel 2014 è stato insignito del premio per il romanzo dedicato a Cevdet Kudret, è stato scelto come miglior romanzo dalla rivista Sabit Fikir (Idea Fissa) e inserito nella lista dei migliori 15 romanzi degli ultimi cinque anni da Milliyet Sanat Dergisi. Per lo stesso romanzo nel 2017 ha ricevuto una borsa del Pen America. La raccolta di racconti Sahiden Hikaye ha vinto nel maggio 2018 il Premio per i racconti dedicato a Sait Faik.
Illustrazione di copertina di ©Rewhat Arslan.