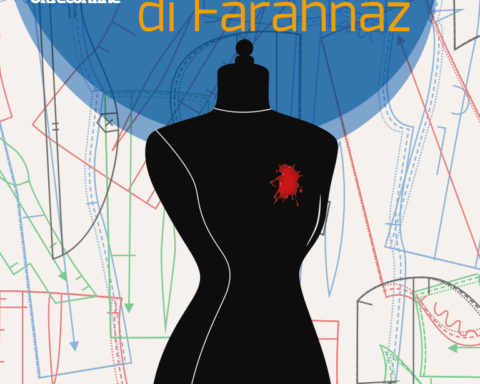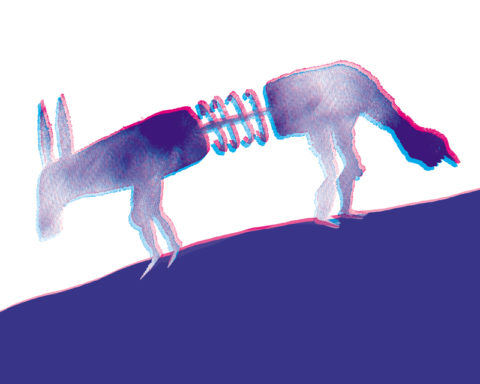Un racconto di Ferit Edgü
Perché sono venuto qui
perché tornare su questa terra
circondata d’acqua su tutti i lati
su quest’isola arida?
Sono venuto
su questo pezzo di terra
di cui non tollero l’aria
dal clima deleterio per la mia salute
e che ad ogni ritorno mi fa pentire
per cosa?
Ho aperto qui i miei occhi. È qui che li chiuderò. Per averlo detto.
Qui. Su quest’isola. In un angolo di quest’isola. Nella mia piccola casa in mezzo al giardino. Per averlo detto. Oppure da qualche parte sulla spiaggia. Nell’anfratto di una roccia. In una grotta nel mare. Come un fuggiasco. O su una collina. Con un proiettile in fronte. Come ho detto.
Ho aperto qui i miei occhi. Non ricordo dove ho aperto gli occhi.
(Non ricorderò neppure dove li chiuderò.)
Morta la donna che mi ha partorito. Morta la mia memoria d’infanzia.
Gli occhi di chi è morto vedono?
Visto che non so se è qui che ho aperto gli occhi perché questo ritorno?
(Dopo quante volte ritorno?)
Questo continuo ritorno?
Non lo so.
Una passione?
Una mania?
La forza di gravità?
Il richiamo del mare?
Non lo so.
Torno senza saperlo.
Sono sceso dalla nave.
Una valigia in mano.
Gli impiegati del molo mi hanno salutato, chiesto notizie, e hanno detto “Benvenuto”. La sera sono entrato nella casa avvolta da ragnatele aprendo la porta con grosse chiavi di ferro.
Ho trovato una candela lasciata sul baule all’ingresso.
Sono entrato in camera da letto. Rifatto. Ma un letto ricoperto di polvere, mi stava aspettando.
Ho sollevato il copriletto, ho aperto la finestra. Poi ho aperto tutte le finestre. Ho spento la candela. Sono uscito. Nella taverna in cui sono andato a riempire lo stomaco, mentre sorseggiavo il vino, mi è venuto vicino un amico d’infanzia di cui ho dimenticato il nome.
– Allora vuol dire che si torna?
– Sì.
– La terra chiama, vero?
– No, non la terra, il mare.
– Stessa cosa.
– Come hai trovato la casa?
– Avvolta da ragnatele.
– Eh, dopo tanto succede!
– Alcuni vetri erano rotti.
– Sono passati così tanti anni.
– Sì.
– Questa volta torni per sempre?
– Non lo so. Si vedrà. Forse.
– Da solo?
– Come sempre.
Si stupì. O forse si impietosì.
– Così c’è da stupirsi?
– Non sono stupito. Ma sai, con l’età… Siamo tutti invecchiati. (Che c’entra l’età con la solitudine?)
– Hai ragione. O vuoi trovarmi qualcuna del villaggio che si prenda cura di me?
– Perché no?
Perché no?
Che mi cuocia il pane. Mi lavi i vestiti. Mi rifaccia il letto. Mi scaldi nelle notti fredde. Che attenda sulla riva che torni dal mare.
Perché no?
Andò così. La trovarono.
La donna migliore sulla faccia della terra.
Non sapeva guardarmi in volto senza arrossire.
Veniva quando le dicevo vieni, andava quando le dicevo vai. Restava in silenzio quando non dicevo niente.
Chiedeva soltanto cosa volessi da mangiare.
Chiedeva soltanto quali fiori volessi vedere in giardino.
Non chiedeva cosa avessi fatto fino a oggi.
Non chiedeva cosa pensavo di fare da oggi in poi.
Ciò che davo prendeva. Ciò che compravo indossava.
Solo un giorno, o meglio una sera, prima di spogliarsi e entrare nel letto, in tutta purezza disse una cosa che mi trapassò il petto che avevo creduto impenetrabile:
-Lo sai, prima di te io qui ero come niente.
Lo so, era più che altro la voce della miseria quella.
Non avevo dato niente a quella donna. Davvero quasi niente.
Una tunica a fiori estiva. Tre misure di flanella perchè veniva l’inverno.
Quando mi andava, una carezza. Diciamo qualcosa di più. Non l’avevo né innalzata al cielo né sprofondata sotterra.
L’avevo fatta vivere così come vivevo io. Silenzio.
Monotonia. Per la prima volta da quando era entrata in casa mia, per la prima volta da quando aveva condiviso il mio letto, sentii il bisogno di dire qualcosa di sensato.
Ma le parole mi si annodarono in gola. Soltanto:
– Ma io non ho fatto niente, riuscii a dire. Poi mi uscì dalla bocca la parola che più mi piaceva, la parola che molte volte avrei voluto dire a molte persone e che non avevo detto:
– Perdonami!
Quella donna che esitava a toccarmi, a dirmi una parola, che esitava a voler essere amata quando ne aveva voglia, non solo a volere, ma persino a renderlo palese, per la prima volta da quando eravamo insieme entrò nel letto prima di me. Si sdraiò sulla schiena, allargò le braccia.
Chiuse gli occhi.
– Perdonami tu e dammi un figlio, disse.
Credetti che l’isola stesse tremando. Credetti che fuori fosse scoppiata una tempesta. Lo disse con una naturalezza tale da sembrare una pianta secca che dotata di parola mi chiedeva acqua. Eppure l’acqua, la vita, il sole era lei. Quando mi sdraiai al suo fianco le dissi di non fidarsi di me, perché in me neppure io avevo fiducia.
– Come sono venuto un giorno me ne vado di nuovo, dissi.
– Lo so, disse. Per questo lo voglio.
Insieme alle piogge autunnali il desiderio di lasciare l’isola si palesò.
Avevo paura di trascorrere qui l’inverno. Qui: un’isola. Circondata dal mare su quattro lati. Seduta sopra il mare. E se le rocce sotto al mare fossero crollate? E se l’isola fosse affondata? Era di questo che avevo paura? Non lo so. Era la paura del vento che avrebbe soffiato d’inverno, delle tempeste che non si sarebbero placate per giorni quella che avevo dentro?
Non lo so.
Un mattino andai al molo. Chiesi un biglietto per la nave che sarebbe partita due giorni dopo. Un biglietto di sola andata.
L’impiegato del molo respinse con la mano i soldi che gli avevo allungato.
– Dove va? Disse. Non sta bene sulla nostra isola?
– Sbrigo degli affari e torno, dissi.
– Quali affari? Chiese. Cosa deve sbrigare? Lasci perdere. Resti dov’è. Guardi, non ci sono più neppure gli stranieri sull’isola.
– Io non le ho chiesto la sua opinione. Voglio un posto sulla prima nave.
– Un posto? Chiese l’impiegato del molo. Sulla prima nave non c’è posto per lei.
– Cioè, la nave è al completo? Chiesi.
– No, disse. Ho detto che non c’è posto per lei.
– E questo cosa significa?
– Questo significa che per lasciare l’isola lei deve richiedere un permesso speciale.
– E a chi?
– All’autorità civile dell’isola, disse.
– Io non chiedo il permesso a nessuno, dissi. Se non mi dà un biglietto salto su una barca di pescatori e me ne vado.
– Questo glielo sconsiglio, può succederle qualcosa.
Poi, come a implorare perché restassi:
– Perché se ne vuole andare? Qui ha la sua casa e il suo posto. Nessuno la importuna. Quest’isola è la sua isola. Il luogo dov’è nato. Il focolare di suo padre. Inoltre adesso ha anche una moglie che aspetta un figlio.
– Ma questa non è la vita che ho scelto, dissi.
– E chi è che sceglie la propria vita, disse l’impiegato del molo. Chi di noi sceglie la vita che desidera?
Mi rimisi i soldi in tasca.
– Quindi non mi dà un biglietto, dissi.
– No, disse lui.
Uscendo dalla sua stanza,
– Si dimentichi delle barche dei pescatori, gliela faranno pagare cara.
– Che facciano, vediamo un po’.
Cosa dovrei pagare?
Chi me la farebbe pagare?
Come me la farebbe pagare?
Per cosa me la farebbe pagare?
Per cosa dovrei pagare?
“Non ho debiti con nessuno, ma se serve pagherò” dissi tra me.
Poi una voce dentro: “Ma ci sono anche cose che non si possono pagare” disse.
“Pagherò con la vita” dissi.
“Ci sono cose che non si pagano neppure con la vita” disse.
Avevo un’esperienza di vita sterile.
La replica a questa domanda, (cos’erano loro?) chiesi, non riuscii a darla.
Tornai sulla spiaggia. La spiaggia ardente. La spiaggia che ormai non ardeva più.
Non c’era nessuno.
Non sapevo dove andare.
Non sapevo perché andare.
Qui, ero tornato per non scrivere, per non scrivere fino alla morte, coltivare fiori in giardino, vivere pescando in mare. Calava il sole.
Due giorni dopo la nave che avevo voluto mi portasse via dall’isola si accostò all’attracco. Era tutta illuminata.
Avrebbe levato l’ancora e io non ci sarei stato.
“Domani è un altro giorno” dissi.
Camminai verso casa.
Aprii il cancello del giardino.
La casa era tutta illuminata.
Mi avvicinai alla finestra del piano terra.
Seduto al tavolo un uomo, fogli sparsi intorno, una sigaretta in bocca, scriveva qualcosa sulla macchina per scrivere che si era tirato davanti.
Mia moglie portò il caffè.
Lui ringraziò sorridendo.
Presi un sorso dal suo caffè.
Poi rimestò i fogli.
Poi cominciò a battere i tasti della macchina per scrivere
come battesse sul grilletto
di una mitragliatrice
rivolta verso il vuoto.
(1972)
Trad. G. Ansaldo
 Ritorno è un racconto di Ferit Edgü pubblicato con il titolo Dönüş nella raccolta Bir Gemide (Sel, 2014 -prima ed. Ada Yay., 1978).
Ritorno è un racconto di Ferit Edgü pubblicato con il titolo Dönüş nella raccolta Bir Gemide (Sel, 2014 -prima ed. Ada Yay., 1978).
© Diritti riservati per la traduzione italiana, Kaleydoskop, 2018 (su concessione della casa editrice Sel).
 FERIT EDGÜ (1936-) è scrittore, poeta, editore, studioso e critico d’arte. Conosciuto all’estero soprattuto per il suo romanzo Un inverno a Hakkari, considerato uno dei primi esempi della “letteratura sociologica” degli anni Sessanta e Settanta, Ferit Edgü è uno dei maggiori novellisti della seconda metà del Novecento in Turchia, capace di coniugare la storia dell’arte alla letteratura. Scrittore soprattutto di racconti, con oltre undici raccolte, e saggi sull’arte in cui traccia lo studio dei maggiori artisti turchi e internazionali, da Van Gogh a Abidin Dino, nel 1979 ha ricevuto il premio letterario Sait Faik Hikaye Armağanı dedicato ai racconti per la raccolta qui presentata, Bir Gemide (Su una nave). Lo stesso anno ha ricevuto il premio dall’Istituto della Lingua Turca Türk Dil Kurumu per la raccolta di saggi Tüm Ders Notları (Tutte le note) e nel 1988 è stato insignito del premio dedicato a Sedat Simavi per il romanzo Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (Uno scritto all’ombra di settembre).
FERIT EDGÜ (1936-) è scrittore, poeta, editore, studioso e critico d’arte. Conosciuto all’estero soprattuto per il suo romanzo Un inverno a Hakkari, considerato uno dei primi esempi della “letteratura sociologica” degli anni Sessanta e Settanta, Ferit Edgü è uno dei maggiori novellisti della seconda metà del Novecento in Turchia, capace di coniugare la storia dell’arte alla letteratura. Scrittore soprattutto di racconti, con oltre undici raccolte, e saggi sull’arte in cui traccia lo studio dei maggiori artisti turchi e internazionali, da Van Gogh a Abidin Dino, nel 1979 ha ricevuto il premio letterario Sait Faik Hikaye Armağanı dedicato ai racconti per la raccolta qui presentata, Bir Gemide (Su una nave). Lo stesso anno ha ricevuto il premio dall’Istituto della Lingua Turca Türk Dil Kurumu per la raccolta di saggi Tüm Ders Notları (Tutte le note) e nel 1988 è stato insignito del premio dedicato a Sedat Simavi per il romanzo Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (Uno scritto all’ombra di settembre).
L’illustrazione di copertina è di © Eren Topçu