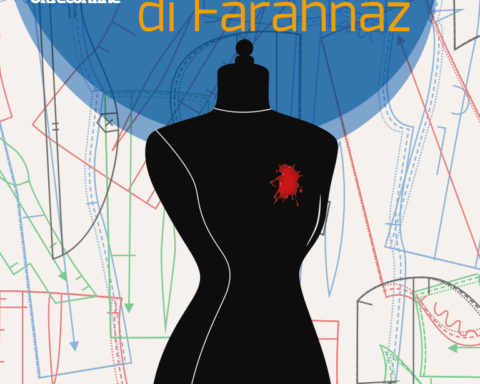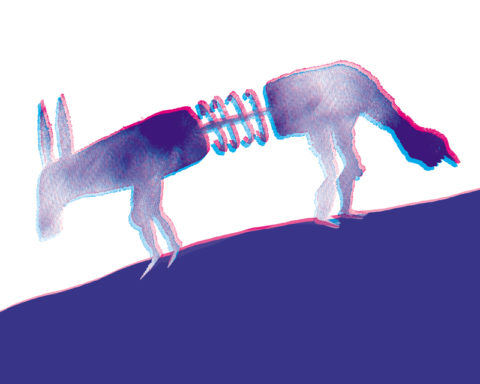Un racconto di Aslı Erdoğan
La porta della stanza si aprì d’un tratto, una testa rossa si sporse all’interno. Si udì la voce affannata e impaziente di Dijana:
«Dai muoviti Felicita! Non possiamo aspettarti tutto il giorno! Alza quel culo dal letto. È dentro che sei morta ragazza mia, dentro!»
La porta si chiuse alla velocità con la quale si era aperta; l’odore di disinfettante del corridoio dell’ospedale, la voce acuta e lo spirito bruciante per quanto superficiale di Dijana rimasero fuori.
Filiz, che con un’ironia ineguagliabile le pazienti di malattie polmonari avevano chiamato “Felicita”, era un tipo pessimista, chiuso, disperato. Con il suo status di rifugiata politica, un dottorato in storia, i voluminosi libri della sua stanza, aveva acquisito agli occhi delle altre pazienti uno status di intellettuale neanche troppo amabile. «Ah, la nostra Felicita…» ripeteva Dijana. «Piuttosto che intraprendere una conversazione con lei è meglio leggere un libro di oncologia. Le si tirano fuori le parole con le pinze.» La nostra scura-dura Felicita! Pare che avesse fatto due anni di galera nel suo paese; senza sollevare la testa dai libri, in dieci anni non era riuscita a imparare a parlare tedesco senza accento Felicita!
Filiz si levò dal letto lentamente. La sua lunga malattia – pneumonia bilaterale e asma cronica – le aveva insegnato a utilizzare parsimoniosamente le proprie forze. Si piegava ai capricci del proprio corpo continuamente dolorante e bisognoso.
Dopo otto mesi sarebbe uscita per la prima volta dall’edificio dell’ospedale.
Nella lista dei nomi delle convalescenti cui il sabato era concesso un permesso di uscita di due ore c’era anche il nome di “Feliz Kumcuoğlu”. Dijana, che aggirando l’infermiera di turno aveva trasformato il furto delle cartelle cliniche di notte nella più grande avventura della vita da ospedale, era a conoscenza di questo sviluppo sin da lunedì. Per lei avevano preparato una “grande sorpresa”. L’AMAZON EXPRESS! Aveva guadagnato il diritto di condividere il segreto delle pazienti del terzo piano, di salire sull’Amazon Express. A dire il vero Filiz non aveva alcun aspettativa. Al massimo, invece dell’unica residenza compresa in una cinta di trenta chilometri, sarebbero andati al villaggio T., avrebbero bevuto uno o due bicchieri. Forse si sarebbero incontrate con i giovani del paese o con i pazienti consunti quanto loro del sanatorio maschile. Cos’altro avrebbero potuto fare in mezzo alla Foresta Nera?
Proprio mentre usciva dalla porta Filiz si ricordò di un racconto ascoltato almeno venti anni prima e riposto in uno degli angoli remoti della memoria. All’inizio del secolo, le malate tisiche del sanatorio di Heybeliada di notte si perdevano nel bosco di nascosto e facevano l’amore con uomini malati di tisi. Donne dalla pelle pallida che camminavano con una torcia in mano, la vestaglia da notte bianca, condannate a morte… Non aveva creduto che la storia potesse essere vera ma l’aveva trovata tragica e poetica. La poesia se n’era andata dalla sua vita da molto tempo e le tragedie personali erano state così numerose che avevano seccato la linfa della sua esistenza come piante parassita.
Esci dalla porta a vetri! Volta le spalle a quell’insegna seria, imbronciata, grigia che recita: “Ospedale di T. Reparto di malattie polmonari”, e cammina veloce senza guardati intorno fino alla linea che segna la fine dell’ombra dell’enorme edificio. Ecco, lì, resta ferma ai confini dell’impero del sole, trattieni il respiro e quel passo, quel solo passo che ti tirerà fuori dall’ombra, compilo lentamente. Cosicché persino lo scialbo sole del nord ti scaldi per un attimo le spalle e tu, convinciti di potere cancellare completamente il tuo passato dalla testa e gettarlo via! Lascia che il sole si diverta tra i tuoi capelli, che si confonda ai colori crudi della foresta, che cancelli i tratti del mondo, la verità si trasformi in luce pura.
Filiz si ricordò di Nadezda che immaginava di poter volare sino in cielo sollevando le braccia, la triste Nadezda nel Il Duello di Cechov. Si sentiva come un personaggio di Cechov. In quel momento avrebbe anche potuto trasformarsi in uccello forse, ma se proprio, in un uccello di legno. Un uccello senza vita, impotente, ridicolo, le cui ali non servivano a volare ma a produrre rumori meccanici. Fu pervasa da un’eccitazione dolorosa. Voleva piangere e ridere nello stesso istante, voleva vivere e voleva morire.
«Su dai Felicita! Te ne stai lì come una mummia. Facciamo tardi.»
A Dijana fece eco la voce da contralto, metallica per le sigarette e la tisi di Gerda: «Così perderai l’Amazon Express!»
Il gruppo riunito davanti al cancello del giardino era composto da sei donne. «Tre straniere, tre tedesche, tre tisiche, tre asmatiche,» enumerò Filiz d’un tratto. «Le tedesche tutte tisiche, noi da terzi mondi invece, asmatiche. Eppure ci si sarebbe potuto aspettare il contrario.» Due tedesche bionde, grandi e grosse, che nonostante la tisi erano riuscite a rimanere forti, Martha e Gerda. (A dire il vero Gerda non era molto alta, non poteva neppure considerarsi bionda, ma agli occhi di Filiz, insensibili alle particolarità fisiche, sembravano uguali, classificate come rappresentanti della classe lavoratrice della piccola società.) Da una parte Filiz aveva un po’ paura delle forza fisica, della grossolanità di quelle donne, della sicurezza con la quale difendevano i propri interessi, dall’altra, sotto sotto le invidiava con benevolenza. La terza tedesca, sottile come un bastone totemico, dalle guance scavate, era una ex eroinomane riservata, la ventenne Beatrice. Con quei capelli castani tagliati cortissimi, gli occhi tristi che sembravano sempre cercare un oggetto perduto, il corpo di adolescente che ricordava un albero secco, intristiva Filiz. C’era la giocosa volpe rossa Dijana, che ne sapeva sempre una più del diavolo. Non le importava niente di niente, non c’era nulla che la facesse arrabbiare. A parte essere chiamata jugoslava invece che croata. E l’argentina Graciella…
Graciella era l’unica paziente del sanatorio emarginata quanto e più di Filiz. Il solo vedere quella donna privilegiata, di buona famiglia, definita all’unanimità con aggettivi quali “distinta, elegante, colta” in mezzo ai malati polmonari, era un esempio dei brutti scherzi della vita. Era alta circa un metro e cinquantotto (più bassa persino di Filiz), minuta e magra, una donna in miniatura. Con i capelli lisci e la frangia, le sopracciglia alla “Marlene Dietrich” che persino in ospedale epilava senza fallo, e gli occhi a mandorla capaci di avere uno sguardo al tempo stesso caloroso e glaciale, si era guadagnata il soprannome di “Evita”. Era la pupilla dei medici e delle infermiere; si comportavano con lei come con un fragile e ineguagliabile vaso antico. D’altronde dava l’impressione che il mondo intero dovesse rivolgersi a lei con cura e gentilezza. Tuttavia Filiz, nelle linee del volto impeccabile che ricordava un soprammobile di porcellana, aveva percepito la durezza. Aveva un sorriso che spaventava Graciella. A Filiz faceva pensare a un’amabile maestra elementare, graziosa e gentile con ogni giorno un foulard al collo, che nel momento in cui entrava in classe si trasformava in una torturatrice di prima categoria.
La prima volta che l’aveva vista l’aveva creduta una visitatrice che per errore era finita alla mensa delle pazienti. Era seduta a un tavolo singolo vicino alla finestra. Aveva indosso una stretta gonna di velluto nero e una camicia con bottoni appariscenti aperta fino alla spaccatura del petto. In mezzo al seno attraente brillava una catenina con un ciondolo a forma di cuore. Completava la tenuta con un paio di scarpe da tango con occhiello e tacchi alti, e calze di nailon. In mezzo alle pazienti che giravano in tuta, ciabatte e capelli unti, appariva anomala come un raro fiore tropicale. Tuttavia un giorno Djiana, gazzettino dell’ospedale, si era infilata in fretta e furia in camera sua e aveva rivelato un segreto:
«Lo sai, quell’argentina… Evita, pare che anche lei sia proprio come te.»
«Che significa “proprio come te”?»
«Rifugiata politica, cioè. Prigione, tortura, cose così. È per quello che ha i polmoni in questo stato. Suo marito era un diplomatico, entrambi molto ricchi, di famiglie nobili, avevano amicizie importanti. Ma ecco, pare che l’uomo avesse pestato i piedi a qualcuno, avevano emesso un mandato di arresto. Nel giro di due ore l’uomo è svanito lasciando lì sua moglie. Hanno provato a far parlare Graciella per due mesi ma non sono riusciti a farle dire dove fosse suo marito. Forse non lo sapeva neanche. Ci puoi credere, quella donnina fragile fragile! Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze.»
Era stato un duro colpo questo per Filiz. Come se le sue pene più grandi fossero state ridicolizzate, come se Filiz K. Fosse stata sminuita, lei e la sua storia. Nel suo ego aveva creato per se stessa un eroe mitologico e soltanto credendo a quell’eroe riusciva a tenersi in vita. I ricordi del suo spaventoso passato erano necessari per provare la propria esistenza ed erano stati relegati in un angolo segreto dell’anima. Ma ora, quella damigella aveva sputato in faccia alle proprie icone. Con che diritto poteva aver condiviso le stesse tragedie della forte, coraggiosa Filiz, che aveva pagato il prezzo per i propri principi e le proprie credenze? (Era così che Filiz si definiva). E per di più in nome dell’amore nei confronti di un uomo ignobile, con la pancia e la doppia amante!
La carovana di donne malate avanzava lungo la stretta strada d’asfalto che scendeva tortuosa verso la valle di T. come un serpente grigio bruno. Già dall’inizio del viaggio si era creata una divisione mitotica.
Il gruppo di testa formato da Dijana e dalle due tedesche robuste era immerso in una conversazione banale. Chiacchiere da sabato che saltavano di palo in frasca su argomenti che non interessavano minimamente Filiz. Una dettagliata valutazione dei medici – le donne venivano prese in considerazione con invidia, i bei dottori con i guanti di velluto – lo spostamento dei cibi della caffetteria in fondo all’angolo del caffè, i programmi televisivi, il confronto tra Banderas e Pitt, e simili… Mentre le tedesche parteggiavano per Banderas, la filo germanica Dijana sosteneva Pitt. Uno o due ricordi del periodo prima dell’ospedale… Nella fabbrica dove Martha lavorava fino a quattro anni prima, una delle donne era stata ritrovata nuda con la gola tagliata. Anche Gerda aveva in serbo qualche storia di assassinio; ne aveva tirata fuori una per scaldarla e offrirla alle altre da un profondo congelatore. Quanto a Dijana, la cui famiglia viveva in Bosnia, non faceva mai parola di orrori, si nascondeva dietro un silenzio che cresceva poco a poco come un grido.
Beatrice non riusciva a decidere da che parte stare, camminava da sola. Faccia a faccia con il proprio mondo interiore. Cercava di sorseggiare senza sprecare neppure una goccia lo straordinario pomeriggio di settembre, la valle verde smeraldo che aveva di fronte, le due ore di libertà. Sembrava felice e quella felicità sul giovane volto devastato era quasi più toccante di un’espressione di dolore.
Filiz era capitata accanto a Graciella, cercava inutilmente di trovare qualcosa di cui parlare. Il silenzio tra loro era lungo e spinoso.
«A dire la verità vederti sull’Amazon Expess è piuttosto sorprendente.»
«Perché?» chiese duramente Graciella. Negli occhi le brillava una fiamma glaciale. Era il riflesso di una rabbia nascosta dentro come un gioiello per anni. «Non ti hanno detto dove andiamo, vero?»
«No, me lo nascondono come fosse un grande segreto.»
«Ed è davvero un grande segreto l’Amazon Express. (Un tono di voce ironico, di sincera contrattazione, un sorriso come una cicatrice.) Ne rimarrai stupita.»
«Andremo in paese probabilmente!»
Graciella portò le dita dalle lunghe unghie rosso ciliegia alle labbra. «Shhh» disse. Come l’infermiera dell’insegna dell’ospedale che diceva “Fate silenzio!”.
A Filiz non era rimasto il coraggio né la voglia di continuare a parlare. Si dedicò a godersi il viaggio. Era fuori dopo otto mesi, camminava in una foresta che sembrava incantata, respirava aria limpida, pura e frizzante come acqua. Un’aria che mentre girava nei suoi polmoni stanchi purificava tutto il grigiore del passato. Un sole amabile, onesto, l’infinità verde che si allungava fino all’orizzonte e la felicità elementare, nuda e magnifica di poter camminare a piacimento… Senza trovarsi davanti porte chiuse… Le porte con le sbarre di ferro della cella, le porte numerate, insonorizzate, dalle cerniere oliate dell’ospedale… Il piacere infinito dato dal poter usare liberamente le proprie gambe, dal riuscire a trasportare il proprio corpo, non poteva essere certo capito da una persona in salute. Filiz percepì l’odore peculiare, ineguagliabile della foresta. Non era come l’odore dolce e domesticato dell’erba tagliata di fresco nel giardino dell’ospedale, era greve e terrestre, da far girare la testa. Forse era anche quello strano silenzio a far girare la testa a Filiz; la valle di T. era distesa davanti a lei come un tappeto verde carezzato spesso, sembrava che le colline si strizzassero l’occhio l’una con l’altra. Nella valle resa più profonda dalla luce dell’autunno, sole e ombra erano entrati nella loro guerra infinita e ingenerata per ricoprire il suolo. “Ogni cosa è luminosa e spensierata da far male,” pensò.
 Beatrice con i pugni colmi di fragole selvatiche si era avvicinata al gruppo delle donne dai capelli neri. Doveva aver superato la crisi d’identità e aver deciso che il suo posto era in mezzo alle “straniere”. Quel tragico legame che attirava l’una all’altra le due ex prigioniere aveva afferrato e inghiottito Beatrice come una velenosa ragnatela. L’eroina le aveva insegnato la solitudine, la disperazione, la rovina e nonostante fosse la più giovane di tutte, era quella che aveva più intimità con la morte. L’aveva portata nel suo corpo di mezza bambina. Le altre si erano sforzate di credere, di tenersi, di partecipare alla vita, ancora si sforzavano di farlo, ma lei la vita l’aveva rifiutata già a sedici anni. Eroina, prostituzione, ittero, tisi… Aveva subito colpi mortali uno dietro l’altro ma ogni volta, prima del gong che segna il K.O., si era rialzata come un boxer al nono round e aveva continuato a prendere colpi.
Beatrice con i pugni colmi di fragole selvatiche si era avvicinata al gruppo delle donne dai capelli neri. Doveva aver superato la crisi d’identità e aver deciso che il suo posto era in mezzo alle “straniere”. Quel tragico legame che attirava l’una all’altra le due ex prigioniere aveva afferrato e inghiottito Beatrice come una velenosa ragnatela. L’eroina le aveva insegnato la solitudine, la disperazione, la rovina e nonostante fosse la più giovane di tutte, era quella che aveva più intimità con la morte. L’aveva portata nel suo corpo di mezza bambina. Le altre si erano sforzate di credere, di tenersi, di partecipare alla vita, ancora si sforzavano di farlo, ma lei la vita l’aveva rifiutata già a sedici anni. Eroina, prostituzione, ittero, tisi… Aveva subito colpi mortali uno dietro l’altro ma ogni volta, prima del gong che segna il K.O., si era rialzata come un boxer al nono round e aveva continuato a prendere colpi.
«Volete una fragola?» (No, nessuna delle due ne voleva)
«Ieri sera in televisione c’era un programma sull’Argentina, l’avete visto?» (No, nessuna delle due lo aveva visto)
«Hanno fatto vedere Buenos Aires. Una città straordinaria. Com’è triste! In parte ricorda Berlino, l’architettura, i caffè… C’era un quartiere pieno di case tutte colorate come un arcobaleno: Elbakar…»
«El Boka» la corresse Graciella. «Significa bocca. È dove è nato il tango.»
«Sì, sì, El Boca. La zona di marginali, artisti, e musicisti.»
«Ormai sembrerebbe ci siano solo borseggiatori e negozi per turisti.»
«Sai ballare il tango?» si precipitò Filiz.
«No, non sono di Buenos Aires, sono di Mendoza.»
(Per qualche ragione ero convinta che questa donna fosse di Buenos Aires e sapesse ballare il tango.)
«Mendoza?»
«Al confine con il Cile. Una città alle pendici dell’Aconcagua.»
«Aconcagua. La montagna più alta dell’America latina!» (Questa gente tedesca per quanto eroinomane è tutta ben istruita!)
Silenzio. La convulsa conversazione finì d’un tratto come tagliata con una lama. Come se le tre donne non avessero niente da dirsi. «Guardate, guardate! Guardate quel cappio appeso a quel ramo basso!» Beatrice non aveva saputo tenere a bada l’emozione della voce; le due donne di mezza età guardarono stupite quel pezzo di corda di alcun interesse. «Deve essersi suicidato un nano qui» continuò Beatrice, con la forza d’immaginazione velenosa data dai suoi vent’anni e dall’eroina. Ma subito le compagne di viaggio ricordarono che erano rimaste troppo indietro. Per fortuna nessuno se la prese .
Quando la carovana deviò dalla strada che scendeva verso la valle per prendere a diritto in direzione delle colline scoscese ricoperte di fitti boschi, Filiz cominciò ad avere qualche dubbio. Voleva dire che non stavano andando al villaggio T. Forse, come bambini di scuola o detenuti, per la libertà del sabato avevano scelto un segreto angolo di paradiso. Ma in quel caso non era necessario guardare l’orologio ogni due per tre e accelerare. Con “Amazon Express” intendevano i boschi della pioggia oppure gli uomini, o le donne leggendarie maestre nella caccia e nella guerra che tagliavano via il loro seno destro?
Ormai non stavano più camminando lungo la via d’asfalto larga e assolata; avanzavano in fila indiana su una strada sterrata ricoperta di radici, arbusti e erbe che non rendevano tanto facile il passaggio. Il vero viaggio nel bosco era cominciato. Persino il sole si era tinto di verde. Era un cammino pieno di cardi che prima mettevano cautamente in allerta le viaggiatrici straniere, poi le assalivano, di rovi, masse di felci, farfalle marroni che si rincorrevano in mezzo ai rami, funghi timidi nascosti negli angoli più reconditi, fiori autunnali. Le perle di pioggia che filtravano dalle foglie, i muschi bagnati e appiccicosi dei tronchi degli alberi, i colori riverberanti della luce del giorno… Ruscelli che tagliavano continuamente la strada, punti vitali del bosco… Sentieri che non rivelavano dove stessero andando, completamente inospitali…
Filiz aveva sempre vissuto in grandi città; non conosceva la foresta. A dire il vero da otto mesi era al sanatorio nel cuore della Foresta Nera, ma anche lì il bosco continuava a essere irraggiungibile, astratto e misterioso. La notte, l’oscurità che si abbatteva alla finestra come un uccello oscuro, i brusii che accompagnavano i suoi incubi, erano come un guardiano imponente, sordo e muto che impediva – per qualche ragione – che lei uscisse e tornasse alla vita reale. Eppure adesso, al suo interno, dentro il cuore della foresta, la vedeva realmente per la prima volta. Era più di una conoscenza quella: un faccia a faccia improvviso tra due esseri ignari dell’esistenza l’uno dell’altra. Perciò ebbe su Filiz un effetto sconvolgente. Aveva davanti un’anima semplice, primordiale, imponente, come l’oceano. L’aveva tirata fuori dal suo mondo polveroso, arido, coriaceo e le faceva sentire tutto un altro timbro dell’esistenza. La foresta aveva un ritmo come di un polso, selvaggio, coloratissimo. Era ricoperta da strane ombre, contraddizioni, fremiti; i suoi segreti erano ricoperti da un velo d’aria tremolante e nebbiosa. Alberi, alberi, alberi… Alberi vecchi, grandiosi, nobili, alti, abbondanti, imperiosi… Imperturbabili come avessero visto ogni miracolo e crimine sulla terra. Più vecchi persino del tempo. Avevano esteso le loro radici nelle profondità, e nei loro viaggi che miravano al cielo, solo al cielo, erano cresciuti tanto da non considerare libertà la dispersione.
Quando rallentarono ai piedi di un pendio scosceso Dijana tirò Filiz da una parte.
«Questo non è il momento a dire il vero.» Si fermò uno o due secondi cercando di riprendere fiato. «Questa sera dobbiamo vederci. La lettera che ho scritto a Hans…»
«L’ultima che ho scritto… quella che abbiamo scritto insieme, l’hai mandata?»
Quando cominciò a parlare Filiz si accorse di quanto fosse sfiatata e assetata. Aveva la bocca così secca che faceva fatica a staccare la lingua dal palato.
«Certo, quel giorno stesso. Non è ancora arrivata nessuna risposta. Aspetta, fammi pensare, sono nove giorni. Può aver fatto ritardo alle poste. E poi Hans è un po’ flemmatico.»
«Credi che risponderà, vero?»
Negli occhi color ambra di Dijana scorse un fulmine. La faccia si coprì di nuvole scure. «Non lo credo, lo intuisco.»
Circa due mesi prima, mentre tornava dalla sala del medico generale aveva visto Dijana in una delle cabine telefoniche al piano terra. Teneva stretto il telefono con tutte e due le mani, da una parte parlava, dall’altra piangeva ininterrottamente. All’inizio pensò che avesse ricevuto un’altra spaventosa notizia dalla Yugoslavia – sua sorella era morta in Bosnia: l’aveva saputo da una voce strozzata all’altro capo della linea che si interrompeva di continuo in una di quelle cabine. Per fortuna questa volta si trattava di altro. L’ultimo amante di Dijana, l’alto e robusto Hans, si era stufato della donna tisica e derelitta, dal respiro crepitante, le borse sotto gli occhi, e delle lugubri visite in ospedale. Avevano scritto insieme cinque lettere a Hans ma neppure la penna sensibile e incisiva di Filiz era servita a niente, non era giunta alcuna risposta.
«Fossi in te lo cancellerei immediatamente dalla mente.»
Filiz era consapevole di comportansi in modo feroce e spietato ma era molto stanca. Ricoperta di sudore, orribilmente assetata; le vene delle gambe eccessivamente affaticate pulsavano. Non le era rimasta la forza di perdersi dietro alle domande di Dijana.
«Ma che cuore di pietra che hai!»
«Certo anche nel mio cuore c’è qualche pietra. Molto bene, proviamo a farlo ingelosire.»
«In mezzo alla foresta? Se dagli alberi cadessero uomini piuttosto che pigne, forse!»
«Possiamo alludere al fatto che c’è stato qualche romantico approccio con uno dei dottori. E ne scegliamo uno con caratteristiche opposte a quelle di Hans. “Magro, con lunghe dita da chirurgo”, “passeggiate nel bosco al chiaro di luna” e simili.»
Dijana sorrise, in un attimo aveva ritrovato la sua naturale allegria. A dire il vero aveva un sorriso ineguagliabile, trasformava completamente la sua faccia sproporzionata. Ampio, sincero e genuino al punto da penetrare il cuore delle persone. Filiz pensò che non aveva mai visto un’altra espressione capace di interpellare la felicità con tanta naturalezza.
«Lo rivoglio.» Il volto stava scurendosi di nuovo.
Nella voce c’era un tremito, una vaga implorazione. Come se provando che voleva davvero indietro Hans, una giustizia divina glielo avrebbe restituito. L’ombra scura nascosta dietro l’indifferenza e la spensierata allegrezza usciva allo scoperto solo in simili circostanze. Dijana nascondeva la sua vera identità in cavità profonde, come un mostro che non dovesse vedere la luce del giorno.
«Sono certa che tornerà,» disse Filiz, con un tono forzato, profondamente scocciata. Non le piaceva dire bugie, né parlare di uomini. Non credeva all’amore: non ricordava più se un tempo, prima di quei trentatré giorni contati in una cella piena di sangue e grida, ci avesse creduto.
«Dijana! Dijana!»
«Sì, che c’è?»
«Facciamo tardi! A quest’andatura non arriveremo mai. Dobbiamo prendere la scorciatoia.»
«Un minuto, arrivo. Fammi vedere.»
Corse verso le tedesche saltellando. D’un tratto Filiz si sentì addosso gli occhi incandescenti di Graciella. Si voltò verso di lei; incontrò uno sguardo doloroso, denso, profondo. Una comunicazione che non si poteva riversare in parole si instaurò d’un tratto tra di loro automaticamente.
«Se in questo mondo vuoi un frammento di felicità, devi trasformarti in una bambina che saltella da una parte all’altra.»
Il volto di Graciella era completamente immobile. Capiva? Senz’altro.
«Hai mai ascoltato il brasiliano Paolinho?»
«No, a dire il vero conosco pochissimo la musica del Sud America, quasi per niente.»
D’un tratto Graciella cominciò a cantare. Era un miracolo quello, una cosa insperata, impressionante, sorprendente, straordinaria… «Vida e bonita…»
Una melodia incredibilmente triste, setosa, che strappava fuori l’anima. Al tempo stesso capace di dare gioia e tristezza; una musica adatta sia alla morte che alla vita. Con gli occhi pieni Filiz inghiottì per non piangere. Se le avessero puntato una pistola alla testa non avrebbe pianto di fronte gli altri, non avrebbe neppure cantato.
«La canzone dice: “La vita è bella, bella, bella… Piena di tristezza e gioia, ma sempre bella… Non vergognarti di voler essere felice…” Paolinho era nato per strada, cresciuto in estrema povertà, morto di tisi a trentatre anni. Il motivo per cui racconto tutto questo è evitare che tu storca il naso per la canzone.»
«Se uno sul bordo del precipizio dice quanto sia bella la vita dobbiamo fermarci ad ascoltare probabilmente. Ma per comprendere davvero questa musica, bisogna aver patito un dolore di altro genere.»
Dijana s’intromise. «Ascolta Felicita, dobbiamo prendere la scorciatoia. Abbiamo pochissimo tempo. Puoi farcela su una via di montagna che dura in tutto venticinque minuti ma di quelle che possono sfiancare una cavalla? Come sono messi i mantici?»
«Ancora non hanno cominciato a lamentarsi, ma non ho capito, facciamo tardi per cosa?»
«È appunto quello il senso di tutto, non sapere dove andiamo finché non arriveremo. Devi decidere adesso se venire o meno, perché non ti possiamo lasciare in mezzo alla montagna. E come puoi immaginare neanche possiamo portarti sulle spalle.»
«Vengo, non torno indietro a metà strada.»
«Forza ragazze, anche Felicita è dei nostri! Battaglione, avanti, marsch!»
Dappertutto si levarono grida, scherzi, incitazioni. «Forza Amazon Express! Arriviamo!» … «Aventa!» … «Morire si può, tornare indietro no!»…
«O santo cielo! Che isteria, che buffonata è mai questa,» pensò Filiz. «Adesso giochiamo pure a fare i soldati. Una carovana di tisiche mezze matte. Ci manca solo un sonaglio! Quelle che faticano a respirare in questo mondo spietato…»
La carovana di donne si infilò nella via di montagna tra strilla e grida mettendo sottosopra i dintorni. Gli abitanti del bosco scapparono, gli uccelli si zittirono; la natura si ritirò in silenzio per aprire la strada a quell’ animale confusionario, inetto ed egoista. Dijana che conosceva bene la strada avanzava in testa spedita come un pellerossa che segue le tracce, definiva la traiettoria, trovava i sentieri. Subito dopo si distinguevano le spalle larghe di Martha e Gerda. Spalle forti, inflessibili, che contavano soltanto su loro stesse… Scalavano le montagne con passi goffi ma sicuri, aprivano la strada come un’unità blindata di testa, spezzando se necessario rami e arbusti, facevano piovere ammonimenti alle altre dietro. Beatrice si arrampicava come un gatto selvatico riuscito a fuggire dalla gabbia. Grazie alle sue agili gambe lunghe e le scarpe da montagna, e più che altro alla sua giovane età, era svelta e pratica come una capra. Addirittura si voltava spesso ad allungare una mano alle amiche dai capelli neri in difficoltà.
Filiz trascorse i venticinque minuti della strada di montagna tra grandi pene, tentando di reggersi ad arbusti spinosi e radici, cercando con agitazione pietre solide su cui poggiare il piede, quasi svenendo dalla paura e dalla preoccupazione. Scivolava ogni due per tre sulle foglie aghiformi, inciampava continuamente nelle radici. Gli arbusti le sfuggivano dalle mani lasciando segni rosa, i rami le assestavano duri colpi. I muscoli molli per non essere utilizzati cominciarono a tremare come un diapason, sembrava avesse due pesanti sacche d’acqua al posto delle gambe. Fremiti sulla schiena sudata che le facevano battere i denti la percorrevano come freddi serpenti. Era completamente bagnata sino alle mutande e non riusciva a togliersi dalla testa che sudare in quel modo per un malato polmonare, per di più un malato che aveva avuto solo quel giorno il permesso di uscire, poteva essere mortale. Inoltre aveva cominciato a farsi sentire quel sibilo spaventoso dai polmoni che nel gergo ospedaliero era chiamato “fischio di guardia”. Si malediceva per aver preso parte a quell’avventura, per aver messo a rischio inutilmente la propria salute riconquistata con mille e più sforzi. Stava per mettersi a piangere di stanchezza, rimorso, disperazione. Tuttavia, rifugiata nel dio personale che ricordava quando non aveva più risorse, lo implorava dal profondo, scandiva preghiere.
Come tutte le cose spaventose, dolori fisici o detenzione, anche quel viaggio finì e Filiz staccò gli occhi dal sentiero e poté vedere dov’era. Durante i venticinque minuti di terrore durante i quali si era domandata se sarebbe morta o sopravvissuta ad ogni passo, sommersa nel proprio corpo e nella propria paura, non si era interessata affatto all’ambiente intorno, ma adesso, affiatata, premendosi il cuore, con gli occhi che le bruciavano, vide che erano arrivate in un posto straordinario.
Erano in cima a un versante ripidissimo avvolto come una gigante rete da pesca da arbusti ad altezza umana, radici e rovi. Quaranta-cinquanta metri più in basso scorreva un fiume furioso che schiumava con rabbia, rombava abbattendosi continuamente sulle pietre frastagliate in ogni insenatura. Prima che il fiume andasse a perdersi in mezzo alle pietre disegnando un arco acuto, un sentiero macchiato di fiori viola simili a grossi chiodi di garofano aveva modellato tutto il versante che appariva screziato in spicchi, come un fine ricamo.
“La via dei sogni viola,” pensò Filiz.
«Scenderemo di qua, Felicita. Devi fare molta attenzione.»
Filiz guardò le compagne di viaggio stupita. Sembravano tutte esauste. Le facce si erano tinte di un colore violaceo, sudate e coperte di fango e graffi. I capelli, le camicie fuoriuscite dai pantaloni erano fradici: I capezzoli evidenti. Tutte erano cadute più volte, si erano tagliate di qua e di là. Qual era il pensiero di queste donne? In nome di cosa tanti sforzi, pericoli, ferite?
«Sentite, non ce la faccio più! Come se non bastasse aver corso come matte in mezzo alla foresta, ora scendiamo lungo un precipizio! Ma cosa succede?»
«Non fare la guastafeste,» sibilò Dijana. «Hai promesso che saresti venuta fino in fondo.»
«Non ho promesso niente io.»
«Lascia che faccia come vuole.» Era Martha questa, no, Gerda.
«Felize per favore stringi i denti ancora un po’. Credi, ne vale la pena.» Questa era Graciella.
«Per favore Filiz.» Beatrice la aveva preso il braccio, la tirava dolcemente.
«Forza ragazze, sono le tre e ventitre! Abbiamo sette minuti!»
Il gruppo in un attimo si dimenticò di Filiz. Si mise in marcia come una pigna che rotola dalla cima del versante. Con l’ultima goccia delle loro forze, agguantandosi a rami, pietre, a qualunque cosa trovassero, scivolando col sedere per la maggior parte del tempo, dandosi la mano per aiutarsi l’un l’altra, le donne scendevano verso il fiume. Un solo passo falso significava rovinare nel precipizio. Anche Filiz era diventata un anello della catena, senza pensarci, senza neppure deciderlo. Aveva piegato il capo alla forza trascendente che la chiamava, aveva preso parte al viaggio ai confini sottili, acuti e scivolosi tra la vita e la morte. Il pericolo l’aveva messa in allerta, tutti i sensi erano acuminati. Era piena di una sensazione simile al piacere sessuale. Così come amava profondamente la vita quel momento, sentiva sin nel midollo la gioia di esistere. Ciò che teneva nel pugno non era un ramo o una pietra, ma il cuore immenso, ferito della foresta, del mondo, della vita. Si trovò davanti un albero curvo al punto di essere parallelo al fiume. Aveva sparso le sue radici tentacolari sulle pietre dure, con ostinazione, determinazione, perseveranza era riuscito a crescere su quel pendio scosceso. L’ombra cadeva sul precipizio. Allungò a Filiz uno dei suoi bracci stanchi; per un attimo, un breve istante prima di continuare nel corso dei rispettivi viaggi precari, delle loro vite, si tennero per mano.
 Dopo una discesa che faceva pensare all’attraversamento da un capo all’altro dell’inferno, arrivarono in tutto un’altro mondo. Alberi gioviali, fiori da sogno, ogni traccia di vita fu cancellata. Lì c’erano solo e soltanto pietre, spaventose, fredde pietre… Erano molto più grandi di quanto non apparissero dall’alto. Si allungavano verso il cielo come luminose sciabole nere. E il frastuono terrificante del fiume, una rabbia irrazionale e immotivata… Credette di essere su un palco Filiz; un gruppo di bambole schizzate fuori dalle molle aveva scelto quel posto per interpretare ruoli sconosciuti.
Dopo una discesa che faceva pensare all’attraversamento da un capo all’altro dell’inferno, arrivarono in tutto un’altro mondo. Alberi gioviali, fiori da sogno, ogni traccia di vita fu cancellata. Lì c’erano solo e soltanto pietre, spaventose, fredde pietre… Erano molto più grandi di quanto non apparissero dall’alto. Si allungavano verso il cielo come luminose sciabole nere. E il frastuono terrificante del fiume, una rabbia irrazionale e immotivata… Credette di essere su un palco Filiz; un gruppo di bambole schizzate fuori dalle molle aveva scelto quel posto per interpretare ruoli sconosciuti.
Davanti agli occhi spalancati di Filiz, Dijana si sedette su una roccia ampia come un letto matrimoniale. Si avvolse in una posa degna di riviste erotiche di terza categoria. Flettendo lievemente le ginocchia divaricò le gambe a V, posò le mani sull’inguine. Sul volto rapito dal piacere, calò un’espressione da “prima dell’orgasmo”. Martha invece si era sdraiata in modo da mostrare il profilo verso il fiume, un ginocchio tirato sul ventre, la testa piegata all’indietro e le mani incrociate sulla nuca. Gerda a carponi mostrava il suo imponente didietro. Beatrice in posizione eretta, aveva poggiato un piede su una pietra, piegata in avanti faceva penzolare le braccia verso terra. Come addossata a un uomo amabile e appassionato, aveva poggiato la guancia al ginocchio, guardava l’acqua con i suoi occhi azzurri, sognanti. Davanti a quelle figure inconcepibili Filiz cercò Graciella come ultima speranza; ma quella da tempo aveva preso parte al gioco. Su una pietra a forma di vela, stava sola, immobile come la statua di una dea. Con la camicia strappata aveva poggiato la mano destra alla vita sporgendo lievemente in avanti il petto. La sua posa richiamava agli occhi di Filiz quella di una colomba; naturale, innocente e fragile. In mezzo ai due capezzoli del colore delle more c’erano lunghe tracce di bruciature che cercava di nascondere dietro il ciondolo d’argento. Gli occhi fissi in un punto nel cielo. Le sottili dita della mano sinistra percorrevano le labbra semiaperte, tese dalla sete. Non parlava, sembrava non riuscisse a pronunciare la sua passione densa e dolorosa. Tutto il suo corpo era assottigliato, allungato, strasformato in una freccia che mirava al cielo. Pronto a schizzare, volare e colpire il bersaglio. Filiz si ritrovò in un sogno inimmaginabile dal quale non era possibile svegliarsi; ma persino i sogni erano più significativi e logici di quello.
«Felicita, su forza, mettiti in posa. Trova qualcosa di comico.»
Filiz continuò a restare immobile come una sfinge. Non riusciva a capacitarsi di niente. L’orologio di Gerda suonò le tre e mezzo. All’inizio non successe nulla. Per un minuto denso, che colava nelle nebbie, le donne rimasero in attesa senza quasi fiatare in quelle pose, ridicole, strane, insensate. E alla fine, in mezzo alle pietre apparve una canoa. Quattro giovani uomini, da quanto si capiva dai gilet di salvataggio e dalle divise, quattro giovani di una squadra di voga dell’Università di H., a settanta chilometri di lì, sani, forti, sportivi, si tenevano con tutte le loro forze ai remi, in quella gola, la più stretta e pericolosa del fiume, compiendo uno sforzo sovraumano per non schiantarsi contro le rocce appuntite. Videro le donne. Nel luogo in cui le vedevano ogni sabato.
«Ehi, fate del bosco! Ancora voi? Oggi arriveremo nel vostro paese.»
«Ragazze, aprite un altro po’, dai!»
«Parcheggiamo la canoa e arriviamo! Ferme lì!»
«Capelli rossi, a che serve se non ti togli i pantaloni!»
Le donne non davano alcuna risposta, non si muovevano neppure. Immobili e pallide, più silenziose di bambole.
Fischi, grida, scherzi dalla cintola in giù che tuttavia non scadevano troppo in basso… Qualche parola che maneggiava con noncuranza la magrezza di Beatrice, l’apertura volgare delle gambe di Dijana, il sedere di Gerda, i seni nudi di Graciella… Felicita invece, pietrificata dallo stupore nella posa di se stessa, stava ferma immobile, senza staccare gli occhi dal petto di Graciella esibito al mondo intero e dalle cicatrici, senza pensare, senza ricordare, senza sentire. Alla fine, mentre la canoa stava per scomparire dalla vista, le braccia di Filiz si levarono in alto piano piano. Sforzandosi come le ali di un uccello di legno dimentico di come si fa a volare, esitanti, si aprirono dai due lati, ma subito ricaddero in avanti senza forza, addossate una sull’altra come ali rotte. La voce di Graciella che giungeva da un altro universo si udì vagamente in mezzo alla violenza del fiume e alle grida che si allontanavano : “Vida e bonita…”
Due gocce tiepide sgorgarono dalle ghiandole lacrimali di Filiz; colarono lungo le guance lasciando tracce come un fiume giallo e fangoso. La canoa era sparita da tempo, le donne erano rimaste sole in mezzo alla foresta.
trad. Giulia Ansaldo
Uccelli di legno è un racconto di Aslı Erdoğan pubblicato con il titolo Tahta Kuşlar nella raccolta Taş Bina ve Diğerleri (Everest, 2009). Diritti riservati per la traduzione italiana, Kaleydoskop, 2017 (su concessione dell’autrice).
***

Aslı Erdoğan, nata a Istanbul nel 1968 è stata definita ‘Una delle 50 penne del futuro’ dalla prestigiosa rivista letteraria Lira Dergisi. Di formazione fisica si è dedicata completamente alla scrittura a partire dal 1996. Scrittrice, opinionista, attivista per i diritti umani, è stata arrestata il 19 agosto 2016 in seguito alla chiusura del giornale Özgür Gündem. Numerosissimi i premi letterari e civili ricevuti in Turchia e in Europa. Nel 2016 è stata scrittrice residente allo ICORN di Cracovia, in Polonia. Lo stesso anno il PEN Svezia le ha assegnato il premio Tucholsky, in Germania le è stato assegnato il premio Theodor Heuss per la partecipazione attiva allo sviluppo della comunicazione. Nell’agosto 2017 la Francia le ha attribuito la Légion d’honneur.
Illustrazioni di farinablu