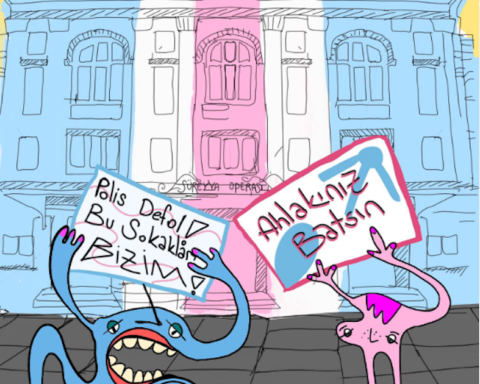Riceviamo questa testimonianza da Riccardo Gasco, dottorando in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna, che si trovava in Turchia al momento del terremoto e si è recato per ragioni familiari su uno dei luoghi più colpiti, la città di Antakya (Hatay/Antiochia).
Istanbul, sono le 5 del mattino del 6 febbraio, dormiamo, il telefono suona. Veniamo avvisati che un terremoto di proporzioni devastanti ha colpito il sud est della Turchia. Le informazioni che arrivano e che si riescono a raccogliere sui social media sono molto confuse ed è difficile comprendere l’entità dei danni. La famiglia di Özlem, la mia ragazza, è originaria di Antakya. La preoccupazione inizia ad aumentare quando capiamo che la città risulta essere una delle più colpite dal sisma. Özlem riesce a telefonare a sua madre cogliendo uno dei pochi momenti in cui la linea è disponibile. La donna è riuscita a scappare dall’edificio in cui viveva ma il resto della famiglia non è raggiungibile. Con il sorgere del sole, sempre più informazioni iniziano a circolare ed è evidente che il terremoto che ha colpito il paese è uno dei più forti degli ultimi cento anni. Qualche ora dopo, Özlem riesce nuovamente a collegarsi telefonicamente con la madre che nel frattempo, insieme ad un cugino, è riuscita a recarsi di fronte all’edificio dove viveva la maggior parte della famiglia. L’edificio è crollato e quasi nessuno è riuscito a scappare in tempo. Saranno sedici le vittime confermate nella sua famiglia.
Antakya è una città di circa un milione e mezzo di abitanti nella regione di Hatay, vicino alla Siria, anch’essa fortemente colpita dal terremoto. È un’area caratterizzata da una grande quantità di siti storici, considerata una delle culle del cristianesimo, dove si può visitare la prima chiesa cristiana scavata nella roccia. La città è da sempre un crocevia di popoli e religioni.

Sono ormai le 11 del mattino e iniziamo a ragionare su come raggiungere la città che dista 1200 chilometri da Istanbul. Dopo alcune ore, decidiamo di provare a raggiungere Antakya in auto. Non abbiamola certezza di riuscire a raggiungere la città, il gasolio scarseggia e durante il tragitto siamo dovuti uscire dall’autostrada per riempire le taniche in un villaggio. Nevica, le strade sono percorribili ma a velocità molto basse, fino ad Ankara non ha mai smesso di nevicare. Man mano che ci avviciniamo alle zone terremotate, la tensione aumenta e nessuno sa veramente a cosa stiamo andando incontro. I social media e le televisioni hanno iniziato a trasmettere immagini ma rimane comunque difficile comprendere la realtà della situazione nell’area coinvolta. Adana è la prima città colpita ma, attraversandola dall’autostrada, non vediamo edifici crollati. Superata Adana, sulla strada per Iskenderun, il rumore delle sirene e le luci di emergenza rendono davvero difficile guidare. Non ci sono autorità, la polizia non è presente e nemmeno l’esercito. I cittadini, con la torcia del telefono per farsi vedere, cercano di aprire il traffico per permettere alle ambulanze di passare velocemente e trasportare i primi feriti. Non c’è elettricità, non c’è luce. La tensione è molto alta, tant’è che il rumore di uno pneumatico scoppiato crea il panico tra le persone in coda.
Dopo circa venti ore di guida siamo in procinto di entrare nella città di Antakya. All’ingresso della città le uniche luci che vediamo sono quelle delle ambulanze, dei mezzi di soccorso e dei fari delle macchine. Avanzando verso il centro il numero di palazzi crollati aumenta, le macchine procedono in contromano, le persone urlano disperate nella speranza che qualcuno arrivi ad aiutarle a scavare per provare a salvare persone che potrebbero essere ancora vive. Le persone provano a scaldarsi accendendo fuochi e bruciando tutto quello che trovano, dalla plastica ai rami delle piante, ai primi libri che emergono dalle macerie. Özlem conosce bene la città in cui è cresciuta ma il numero di palazzi crollati e la mancanza di luce rende praticamente impossibile riconoscere le strade e i palazzi.
Dopo circa un’ora dal nostro ingresso nella città riusciamo a raggiungere la famiglia, alcuni cugini e l’unica zia sopravvissuta; quando il terremoto si è verificato si trovava in un altro edificio. Lo scenario è apocalittico. C’è un uomo che urla, non ha quasi più voce, dice di essere dell’AFAD, la protezione civile turca. Prova in tutti i modi a coordinare i soccorsi e il personale che però in realtà non esiste, o meglio è composto da cittadini volontari in affanno. Ci sono centinaia di cittadini disperati che provano in tutti i modi a raggiungere i parenti sepolti dalle macerie. Il trambusto del momento si alterna frequentemente a momenti di silenzio per cercare di udire se ci siano voci provenienti dagli edifici crollati. Le persone urlano a squarciagola “C’è qualcuno? Qualcuno ci sente?”. Si scava con le mani, non ci sono nemmeno guanti. Non c’è nulla. I primi soccorsi ufficiali si vedono solo a partire dal terzo giorno quando anche i primi team di ricerca e soccorso internazionale riescono a raggiungere la città. L’edificio di fronte a noi è composto da otto piani, le prime stime indicano che potrebbero esserci circa 200 persone sotto le macerie. Verso le 5 del mattino passa un escavatore, le persone gli si parano davanti per cercare di bloccarlo e lo implorano di iniziare a lavorare in quell’edificio. Le scosse di assestamento sono molto frequenti e vengono accompagnate da urla di paura.
I primi due giorni sono stati caratterizzati dalla mancanza di coordinamento degli aiuti e dalla mancanza di personale specializzato e professionale. Se non fosse stato per i cittadini sopravvissuti, probabilmente nessun corpo sarebbe stato estratto vivo nei primi due giorni. La vastità dell’area colpita ha sicuramente reso la logistica e il dispiegamento del personale molto complesso. Inoltre, l’aeroporto di Hatay, ora ripristinato, è stato danneggiato dal terremoto e la pista si è crepata rendendo impossibile l’invio di aiuti per via aerea. Tanti si domandano dove fossero gli elicotteri di uno degli eserciti più poderosi al mondo, che conta circa 425 mila militari all’attivo con oltre 200 mila riservisti. I primi due giorni le persone che erano sul posto hanno confermato che non ne hanno visto nemmeno uno. Quando abbiamo raggiunto la città il secondo giorno dopo il terremoto, mancavano anche acqua e cibo. Non c’era acqua corrente. Abbiamo iniziato a distribuire tutto quello che eravamo riusciti a caricare sulla macchina.

Il giorno seguente, con l’arrivo della luce del sole, riesco a capire meglio la situazione che ci circonda. È difficile trovare le parole per descrivere tanta distruzione. Ci sono centinaia e centinaia di edifici crollati, nessuno è agibile. Le persone hanno iniziato a costruire dei piccoli ripari con materiale recuperato tra le macerie. Il numero dei corpi che vengono estratti, purtroppo senza vita, inizia ad aumentare vertiginosamente. Le cifre quel giorno parlano di circa 8 mila vittime ma è subito chiaro che quel numero è destinato a moltiplicarsi velocemente arrivando oggi a oltre 41 mila. Non ci sono sacchi per i corpi che vengono talvolta avvolti nelle coperte e adagiati sui marciapiedi, talvolta solamente adagiati senza nemmeno essere coperti. I corpi vengono trasportati in tutti i modi, in spalla, in motorino, nei carrelli della spesa, nei bagagliai delle macchine. I parenti delle vittime provano in tutti i modi a dare dignità ai corpi cercando di seppellirli il più in fretta possibile.
Il terzo giorno, dopo circa 72 ore, iniziano a vedersi i primi soccorsi ufficiali e personale specializzato accompagnato dai team internazionali. Dal momento in cui la Turchia ha alzato l’allerta al livello 4, che implica la richiesta di aiuti internazionali, circa cento paesi hanno inviato aiuti materiali e personale specializzato nelle operazioni di ricerca e soccorso per un totale di circa 10 mila uomini e donne. L’aeroporto di Adana è diventato il centro logistico per lo smistamento degli aiuti e del personale. La vastità dell’area colpita, oltre 300 chilometri quadrati, ha reso indubbiamente difficile la gestione dell’emergenza nel corso delle prime 48 ore. Questa è stata anche la motivazione attribuita dal Presidente Recep Tayyip Erdoğan per giustificare la lentezza nel dispiegamento dei soccorsi. Ciò non giustifica però che interi edifici, alcuni anche di recente costruzione, si siano letteralmente accartocciati su sé stessi come palline di carta.
Nel corso del terzo giorno gli aiuti in termini di cibo, acqua e vestiti sono massicci, chilometri di code si formano a causa degli automezzi che arrivano da ogni singola municipalità della Turchia mentre cercano di raggiungere le zone colpite. Cominciano a essere distribuite le prime ciotole di ‘çorba’, minestra calda di vario tipo.
Decido di andare a fare una ricognizione nel centro storico della città per meglio comprendere la situazione. Quando raggiungo uno dei parchi principali, il Millet Bahçesi, inizio a vedere le prime tende che vengono montate. All’interno del parco, diventato uno dei punti cruciali per la distribuzione degli aiuti, è stato anche allestito un mercato improvvisato dove le persone cercano di accaparrarsi vestiti, scarpe e altri beni di prima necessità. Continuando sulla via per raggiungere il centro decido di attraversare uno dei ponti sopra il fiume che taglia la città per raggiungere la storica moschea Ulu Cami, anch’essa severamente danneggiata, il minareto è crollato. Le persone mi fermano per strada, chi cerca cibo, chi vestiti, chi medicine e chi sigarette.

Ricevo una chiamata da Özlem: hanno trovato una persona viva all’interno dell’edificio dove si trova anche la sua famiglia. Mi affretto a tornare indietro facendo lo slalom tra i mezzi di soccorso e gli edifici in procinto di crollare. Una volta raggiunto l’edificio, la situazione è surreale, è la prima persona viva che è stata individuata dopo tre giorni. Sono tutti con il fiato sospeso, ogni famiglia spera che si tratti di un conoscente ma ognuno è consapevole che a quel punto, ogni singola vita salvata rappresenta un piccolo successo per tutta la comunità. Al lavoro, oltre ai volontari, c’è un team di pompieri specializzato che è arrivato da Konya, una città dell’Anatolia centrale. Dopo oltre quattro ore di lavoro la donna viene estratta, è viva e sta bene. Il silenzio del momento è emblematico, nonostante una persona sia stata salvata, nessuno si permette di applaudire, il livello di distruzione è talmente enorme che nessuno si sente di gioire.
Aver estratto una persona viva ha ridato speranza a tutti coloro che aspettano notizie o sperano di sentire qualche voce provenire dalle macerie. I momenti in cui viene richiesto di fare silenzio aumentano con il passare delle ore. Il primo team internazionale che è arrivato per lavorare sull’edificio è cinese. Ogni team internazionale è seguito da un traduttore che viene assegnato dall’AFAD. Il problema è che ogni volta che un team internazionale arriva, viene assalito dalle persone in cerca di informazioni. Alcune squadre nei giorni seguenti hanno anche deciso di sospendere le operazioni di soccorso, prima di riprenderle scortati dai militari, per motivi di sicurezza.
Decido di provare ad assistere il team cinese nelle loro richieste. Uno dei membri prende un pezzo di legno dalle macerie e un pennarello, dice di dover ricostruire a grandi linee la struttura dell’edificio per capirne l’architettura di base e individuare il punto in cui è più probabile che ci siano persone ancora in vita. Le persone forniscono indicazioni sul numero di appartamenti, sulla loro distribuzione, sulla posizione delle scale e dei corridoi. Una volta capita la struttura il team si mette al lavoro ma dopo qualche ora dichiara che non è più possibile continuare senza l’aiuto di martelli pneumatici e gru specializzate per smuovere grandi blocchi di cemento. Nuovamente, la mancanza di equipaggiamenti fa innervosire le persone.
Il nervosismo aumenta sempre di più con il passare delle ore, le persone non capiscono perché i team di ricerca e soccorso passano, lavorano per qualche ora e poi decidono di spostarsi in altri edifici. Questo, per quanto la situazione sia grave, rappresenta una grande mancanza di coordinamento in un paese con alle spalle una storia sismica importante e in cui ci si aspetterebbe comunque più preparazione di fronte ad avvenimenti di questo tipo. Si cerca quindi di spiegare alle persone le modalità in cui i team lavorano al fine di tranquillizzarle, se non rilevano voci o segni di vita tramite cani e telecamere termiche devono spostarsi dove ci sono più possibilità di trovare ancora qualcuno vivo.

Chi è fortunato ad avere ancora un mezzo, prova a recuperare qualche ora di sonno in macchina, qualcuno è riuscito a trovare qualche tenda da campeggio, i materassi che vengono fuori dalle macerie sono utilizzati dalle persone per riposare. Le condizioni sanitarie ed igieniche iniziano a preoccupare, qualcuno inizia a allertare la popolazione del possibile sviluppo di epidemie. Le persone lamentano la mancanza dello stato, tanti si chiedono dove siano gli aiuti ufficiali, dove siano i bagni chimici e le tende.
A partire dal quarto giorno, grazie anche agli aiuti provenienti dall’estero, il governo inizia ad allestire delle tendopoli, la preoccupazione però rimane alta e non tutti sono sicuri di riuscire ad assicurarsi un posto. Il numero degli sfollati ammonta ad oltre quindici milioni.
Il quinto giorno decidiamo di tornare ad Istanbul. Altre venti ore di viaggio per tornare a casa. Le ripercussioni di questo tragico evento naturale sono al momento impossibili da quantificare e il futuro di circa quindici milioni di persone è incerto. La vera emergenza è solamente appena iniziata. (Riccardo Gasco)
Kaleydoskop appoggia, per le donazioni a favore delle persone colpite dal terremoto, le campagne di alcune organizzazioni che agiscono in modo trasparente e affidabile > qui per saperne di più