Cani Preistorici, un racconto di Burhan Sönmez
Mentre di notte si tagliava i polsi, la ragazza canticchiava una canzone. Neve in ogni dove, diceva, tuo è il mio cuore questa notte. Era in una piccola città dell’Inghilterra. Non si sapeva quanti tentativi di suicidio avesse già commesso; il suo compagno aveva chiamato l’ambulanza e l’avevano portata in ospedale.
Io facevo da interprete. Rispondendo con fatica alle domande dei medici, parlava di sé stessa al passato, un po’ in zazaki e un po’ in turco. Ero piccola, diceva, anche il nostro villaggio lo era. Una notte sono venuti i soldati e hanno portato via i miei genitori. Li hanno messi nella stessa stanza, e mentre violentavano mia madre hanno costretto mio padre a guardare. Li abbiamo aspettati per giorni, io e mia sorella. Tenevamo gli occhi fissi sull’orizzonte, ma continuava a nevicare. Sono ricomparsi una sera; completamente distrutti.
Caricare tutte le sofferenze del mondo sulla schiena di una persona era una vera ingiustizia. Mia madre non riusciva a farsi carico di un tale fardello: non era mica una santa che poteva camminare con la croce sulle spalle. C’era un dirupo vicino al nostro villaggio; si gettò da lì. Quel giorno mio padre se ne andò senza dire una parola. Qualunque fosse la destinazione che aveva in mente, lo uccisero prima che potesse raggiungerla. Mia sorella aveva quindici anni; la notte mi addormentavo abbracciandola, e piangevamo di nascosto l’una dall’altra. Poi se ne andò anche lei. Gli abitanti del nostro villaggio continuavano a ripetermi che sarebbe tornata. La pazienza, allora, era una dolcezza fasulla: ingannava la gente, ma non dava alcun gusto. Quanti inverni erano trascorsi? Un giorno mi portarono il suo cadavere. Si era unita ai miliziani delle montagne ed era morta alcuni mesi dopo in un combattimento vicino al villaggio.
In paese vivevo come quei pazzi che non fanno male a nessuno. Venni adottata da alcuni parenti che mi ripetevano ogni giorno di non salire per nessun motivo sulle montagne o sarei morta. Passavo il mio tempo osservando le tombe al cimitero. Così, da mattina a sera. Poi, per il mio bene, mi mandarono da una zia che viveva in Inghilterra. Chi poteva fare da scudo alla scure dell’ingiustizia? Ho un compagno, adesso, è inglese, e anche se le nostre lingue non combaciano, il mio cuore è suo. Del resto, se ci capiamo noi in Turchia con tutte le nostre lingue, figuriamoci qui. Un giorno siamo andati al cinema, e mentre guardavamo Braveheart – quello con Mel Gibson – sono scoppiata a ridere, tanto da farmi venire le lacrime agli occhi. Il mio fidanzato non capiva. Nemmeno io mi rendevo conto di cosa mi stesse succedendo; quella fu la prima notte in cui tentai il suicidio. Ingoiai un’intera confezione di pillole.
Ora la mia infanzia assomigliava al letto dei fiumi in secca disegnati sulle carte geografiche. A guardarci bene, vedrete che la neve imbianca ogni angolo di quella carta. Non ce la faccio più, sono diventata debole, proprio come mia madre. Non posso trasportare questo dolore, questa colpa, come una croce. Mia cugina mi aveva detto che l’unico posto nel quale mi sarei potuta finalmente liberare da un peso simile erano proprio le nostre montagne. Non farlo, avevo detto, meglio di no. Uccidersi è la cosa migliore, mentre la neve imbianca ogni angolo.
Sono scappata da casa di mia zia l’anno scorso. Rideva sempre, mi diceva di non dimenticare mai il mio passato. Non mi ha raccontato mai nulla, né della sua infanzia, né della sua vecchia vita. Eppure, non avrebbe mai osato suicidarsi. Non capisco come mai la gente esiti. Lei ci ha mai provato? Mi gira la testa, i dottori danno sempre più medicine di quante dovrebbero. A proposito, com’è che conosce la mia lingua?
È anche la mia, le dissi, veniamo dalle stesse parti. Mi prese la mano. Siamo parenti?, chiese. La sua voce tremava, la sua mano era tiepida. Forse, risposi, forse. Sorrise per la prima volta. Una luce passò attraverso i suoi occhi. Mia zia, disse, se dovesse incontrare mia zia le dica che sto bene.
La incontrai, sì, ma non nel luogo che aveva indicato. Era stata messa in una casa di riposo quattro mesi prima, e ora faticava perfino ad uscire dalla propria camera. Stando a quanto dicevano gli infermieri, avrebbe continuato a ridere e a parlare continuamente anche se la sua salute fosse peggiorata. Entrai nella stanza e mi sedetti sulla sedia accanto alla finestra. Quando aprì gli occhi, fuori stava iniziando a nevicare. Mi presentai. Le porto i saluti di Esma, dissi. Come sta Yesma? – chiese ridendo – Yesma, è questo il suo vero nome. Bene, risposi quieto. Se stesse davvero bene sarebbe venuta di persona, disse, è dal giorno in cui è fuggita da Dersim e ha messo piede qui che non riesce a dormire come si deve. La notte faceva degli incubi, gridava. Non sapeva di dover imparare ad essere paziente, invece di abbracciarmi. Mi chiedeva incessantemente di sua madre, voleva che le raccontassi la mia infanzia, ma a volte è meglio ridere e tacere. Chi è abituato a nascondere le proprie ferite per tutta la vita lo capisce meglio.
Somigli tanto a mio fratello maggiore, proseguì sorridendo l’anziana donna, da quando è morto non lo sogno più. Anche le sue dita erano così sottili, così lunghe. Si chiamava Vareno, Kara Vareno. L’ultima volta che l’ho visto avevo dieci anni. Quando è arrivata la notizia che i soldati stavano uccidendo tutti quanti, siamo andati a nasconderci nelle grotte sulla montagna dietro il villaggio. Non sapevo dove fossero fuggiti tutti gli altri uomini, ma riuscii a vedere mio fratello che correva in sella al suo cavallo bianco verso il villaggio della sua fidanzata. Tornò il giorno seguente, galoppando a briglia sciolta in mezzo ad un cumulo di polvere. Era solo. Risalendo il pendio della montagna con il suo cavallo bianco, gridava verso l’alto: tornate indietro, nascondetevi più in fondo che potete! Ormai eravamo tutti già dispersi, rimanevano venti o trenta persone tra donne e bambini. Tornammo indietro, tuffandoci nel buio fitto della caverna; abbracciammo le nostre madri rimanendo muti come pietre. Fuori si potevano sentire i rumori dei fucili provenire dall’altro versante della collina. A quei tempi non sapevo nemmeno cosa fosse un’ora, eppure mi parve che i combattimenti durassero all’infinito. Ad un certo punto, le nostre madri ci dissero sottovoce che si era fatta sera. I fucili tacquero. Assoluto silenzio ed assoluta eternità. I bambini avrebbero potuto dormire in qualsiasi momento. Mi svegliai all’improvviso da un sogno. Qualcuno dal basso gridò sia in turco che in zazaki; voleva che uscissimo tutti quanti. Non lo facemmo. Questa volta, furono le nostre madri ad abbracciare noi.
Non fu facile per i soldati trovarci: dovettero perlustrare ad una ad una ogni caverna del ripido pendio. Uscendo fuori, il giorno seguente, i nostri occhi vennero abbagliati dal sole. Eravamo dominati dalla paura e dalla sete. Soldati che non ci assomigliavano in nulla, puntavano i loro fucili contro di noi. Gridavano. Uno di loro si fece avanti e iniziò a parlare zazaki. Aspettate qui, disse, aspettate qui e non muovetevi. Se provate a scappare, vi ammazzeremo come abbiamo fatto con quel furfante laggiù. Guardai il versante destro della montagna, e fu allora che vidi mio fratello. Era disteso a terra, insanguinato; anche il suo cavallo bianco giaceva esanime accanto a lui. Adesso rido, ma allora non risi proprio per niente. Quel corpo marcirà, continuò il soldato, diventerà cibo per i lupi e per gli uccelli. Le nostre gole erano secche, le nostre pelli ardevano per il calore. Poi calò il sole, e l’oscurità si abbatté dappertutto. Ci infilarono in una grotta, così che non potessimo fuggire. Non ci permisero neppure di accendere un fuoco per scaldarci. Mia madre e gli altri non smettevano di piangere. Io non riuscivo a sentire il freddo, e a poco a poco anche la mia sete sparì. Mio fratello non sepolto mi aspettava. Lasciai in silenzio le donne che cercavano rifugio nel sonno e nelle lacrime all’interno della grotta. Fuori, due soldati facevano la guardia; altri non se ne vedevano. Scivolai tra le rocce con il mio piccolo corpicino.
Quando fui vicina al cadavere non c’erano né lupi né uccelli. Le stelle si specchiavano nelle gocce di sangue sul volto di mio fratello. Esitai; se avessi pulito il sangue con l’orlo del mio vestito, anche le stelle sarebbero andate via? Gli presi la mano e la portai alla testa; sentii la carezza di mio fratello sui miei capelli. Laggiù, piansi in silenzio tutte le lacrime che non ero riuscita a versare quel giorno. Scesero le stelle, e uno stormo di uccelli che veniva da lontano si dispose intorno a noi. Toccai le dita di mio fratello, una per una. Voleva alzarsi in piedi; aspetta, sussurrai, aspetta, voglio coprirti di terra. Il suo volto si rilassò, ma il dolore che gli si leggeva sulle labbra non svanì. Capii che non era riuscito a vedere la sua fidanzata nel villaggio vicino. Baciai io i suoi capelli al posto suo, poi iniziai a radunare manciate di terra con le mie minuscole mani. Adesso poteva dormire tranquillo, poteva riposare in pace. Avrei ricoperto di terra anche il cavallo bianco accanto a Kara Vareno. Non sarebbero diventati cibo per i lupi e per gli uccelli. Confidai nella notte; mancava ancora tanto al mattino.
Sentii il rumore di alcuni passi. In un istante, le stelle abbandonarono il cielo e gli uccelli volarono via. Quando mi guardai alle spalle vidi un soldato con un fucile in mano. Si avvicinò, mi afferrò per il braccio e mi fece alzare in piedi. Non capivo quello che diceva. Scoppiò a ridere, poi provò a dire qualcosa in zazaki con quelle poche parole che conosceva. “Ti Antigone ya?” Sei Antigone? Pensai che mi avesse confusa con qualcun altro. Mi si attorcigliò la lingua. A quei tempi non potevo sapere che Antigone fosse un’eroina della mitologia greca, e che fosse stata punita proprio per aver seppellito il fratello. Guardavo il soldato senza dire nulla, fino a quando non mi prese facendomi stendere sul cavallo. Mi stuprò ansimando come un cane rognoso. Nonostante il dolore non ebbi il coraggio di gridare: non volevo che mio fratello sentisse. Il mio sangue si mescolò a quello del cavallo bianco. La civiltà, un cavallo morto e i miei dieci anni. Le stelle avevano già ceduto alle tenebre, e il cielo era ridotto a brandelli.
Ho riso per due giorni consecutivi, distesa fra le braccia di mia madre. E mentre io ridevo, le donne piangevano. Qualche giorno più tardi ci fecero salire su un treno insieme a un nutrito gruppo di persone. Alla nostra testa avevano messo qualche soldato; ci stavano mandando in esilio. La notte, mentre tutti dormivano, provai un dolore fortissimo. Credetti che qualcuno mi avesse infilato un coltello nella pancia. Cercai di non svegliare nessuno. Appoggiai la schiena alla portiera del vagone. Un ragazzo dall’altro lato se ne accorse e mi venne incontro. Doveva avere uno o due anni in meno di me. Vedendomi ridere malgrado il dolore mi chiese se fossi pazza. Non sono pazza, dissi, sono una donna, nessuno mi prenderà più, ormai. Toccai con le dita il sangue che colava fra le mie cosce, e sempre ridendo tesi la mano verso il giovane. Annusò il sangue; non temere, disse, ti prenderò io. Si chiamava Cemal. Anni dopo scoprii dai giornali che era diventato poeta. Posò la sua mano fresca sulla mia fronte. Ti scriverò, disse, verrò a prenderti quando sarò più grande. Vieni, risposi, vieni e portami via. Fuori i cani abbaiavano. Fuori i cani abbaiano, disse Cemal.
Quando nacque mia figlia le diedero il nome Elida senza consultarmi. Qualche anno più tardi, quando sentii che il poeta Cemal aveva rimosso una y dal proprio cognome, capii che me l’aveva spedita in una lettera segreta. Presi la y e la misi all’inizio del nome della mia bambina. Diventò Yelida. Lei però non mi conosceva come sua madre; credeva fossi sua sorella. La famiglia aveva deciso così. Una bambina non può nascere da una bambina, dissero, puoi essere soltanto sua sorella. Io mi accontentai di ridere e di darle una lettera anni dopo. Venni messa in un istituto di cura privato. Quando i miei parenti decisero di tornare al villaggio, io non volli andare con loro, mai più. Mi mandarono da una famiglia in Inghilterra. Prima di andarmene, Yelida mi chiese: perché mi hai dato questa lettera? Diritto di sorellanza, risposi, poi scoppiai a ridere, tanto che mi vennero le lacrime agli occhi. I cani preistorici abbaiavano, proprio come aveva detto Cemal.
Anni dopo, mia nipote Yesma venne a stare da me, malgrado credesse che io fossi sua zia. Spesso la verità è a senso unico, come la vita. So che un giorno Yesma riuscirà a suicidarsi, e forse per questo vorrà tornare al villaggio e salire verso le montagne. Lassù morirà come uno di quelli delle montagne, di cui si conosce il numero dei morti dai giornali, ma con nomi e storie sconosciuti. Nessuno piangerà per loro. Non hanno alcun destino se non quello di essere malvagi e maledetti. Venuti al mondo per essere una favola, si sono svegliati con una croce sulle spalle. Non desiderano morire, e uccidere non li rende felici. La notte non hanno notizie gli uni degli altri, e canticchiano la stessa canzone. Neve in ogni dove, tuo è il mio cuore questa notte…
Ripetendo queste parole, l’anziana signora chiuse gli occhi. Un odore di morte si diffuse lungo i corridoi della vecchia casa di riposo. Guardai dalla finestra: c’era un mondo bianchissimo là fuori. La voce della donna rallentò, pesante come fiocchi di neve, poi si addormentò esausta. Attesi un istante. Osservai i suoi capelli bianchi e il suo volto rugoso. Le presi le mani, quelle minuscole mani che un tempo avevano amato il fratello, poi sistemai gentilmente la coperta sulle sue spalle. Quando uscii dalla stanza, si svegliò per via del cigolio della porta. Cemal, sei tu? – disse. Sorrise; non a me, quanto al vuoto nel quale anche io avevo preso posto. Poi chiuse gli occhi, e tornò a rifugiarsi in una pagina lacerata di storia.
Traduzione di Matteo Idà

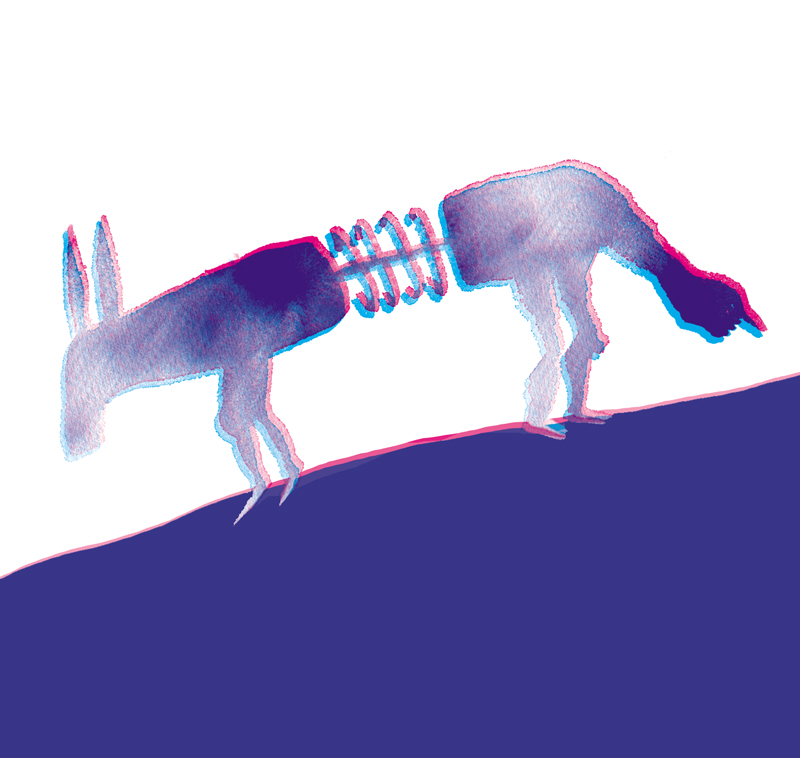

 Burhan Sönmez è uno scrittore e giornalista turco. Nato a Haymana (Ankara) nel 1965 in una famiglia curda, studia legge a Istanbul, dove entra in contatto con varie associazioni impegnate nella difesa dei diriti umani e si specializza in diritto umanitario. Come giornalista, collabora con varie testate nazionali ed internazionali. Costretto al trasferimento in Inghilterra per ricevere cure a seguito di uno scontro con la polizia nel 1996, si avvicina alla scrittura durante la riabilitazione. Dopo aver vissuto a lungo in Inghilterra è tornato in Turchia dove, oltre alle attività di traduttore e editore, insegna letteratura e scrittura narrativa all’Università METU di Ankara. Autore di diverse opere, è riconosciuto come uno dei maggiori autori del panorama letterario contemporaneo. In italiano sono stati tradotti i romanzi:
Burhan Sönmez è uno scrittore e giornalista turco. Nato a Haymana (Ankara) nel 1965 in una famiglia curda, studia legge a Istanbul, dove entra in contatto con varie associazioni impegnate nella difesa dei diriti umani e si specializza in diritto umanitario. Come giornalista, collabora con varie testate nazionali ed internazionali. Costretto al trasferimento in Inghilterra per ricevere cure a seguito di uno scontro con la polizia nel 1996, si avvicina alla scrittura durante la riabilitazione. Dopo aver vissuto a lungo in Inghilterra è tornato in Turchia dove, oltre alle attività di traduttore e editore, insegna letteratura e scrittura narrativa all’Università METU di Ankara. Autore di diverse opere, è riconosciuto come uno dei maggiori autori del panorama letterario contemporaneo. In italiano sono stati tradotti i romanzi: 






