Ogni anno in Turchia si assegna il premio per il racconto “Sait Faik Abasıyanık”. In quel paese la forma racconto gode di una fortuna che pare invece declinare dalle nostre parti, ed è così che per quel premio sono passati alcuni fra i nomi più significativi della letteratura turca di fine ‘900 e di inizio XXI secolo: Orhan Kemal (1958; 1969), Adalet Ağaoğlu (1975) Ferit Edgü (1979), Oya Baydar (1992), Aslı Erdoğan (2010), Kemal Varol (2018) e molti altri ancora. È un premio che viene annunciato l’11 maggio, nel giorno anniversario della morte dello scrittore eponimo che lo scorso anno è tornato in Italia, e in italiano, in una preziosa raccolta pubblicata da Adelphi, curata e tradotta da Giampiero Bellingeri e Fabrizia Vazzana: Un uomo inutile (19€, 263p.). Finalmente Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) arriva da noi sospinto dall’autorevolezza e dalla capacità di diffusione che può dargli un editore forte e attento alla letteratura “in purezza”. Si tratta solamente della seconda pubblicazione di letteratura turca da parte di Adelphi, dopo la lontana traduzione (1995, sempre a opera di Bellingeri) di Nur Baba di Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Per quel che riguarda Sait Faik, in Italia era stato pubblicato in precedenza nel 2007, dalla ormai scomparsa casa editrice A Oriente! (Con poco zucchero, trad. di Lino Beretta) e nel 2020, in poesia, per Lunargento (Ora è il tempo di amarsi, trad. di Giampiero Bellingeri). Le recensioni dedicate a questa recente uscita da Goffredo Fofi su Internazionale, Enzo di Mauro sul il manifesto, Melania Mazzucco su La Repubblica o Alessandro Zaccuri su Avvenire testimoniano finalmente del risalto dovuto a questo grande scrittore.
Grande? In verità, è un aggettivo che accostiamo ad Abasıyanık con un certo imbarazzo, perché la sua poetica è tutta in minore, priva di prosopopea, di magniloquenza, d’esaltazione classica e monumentale. Tutt’altro, Abasıyanık è un perlustratore dei bassifondi, uno scrutatore degli angoli in ombra, un raccoglitore d’occasioni, compagno di un’umanità popolare, anonima, vitale, brulicante, sconfitta e solare. Flâneur sulle rive del Bosforo, si è detto da più parti, ed è vero; ma a un flâneur più vicino a Robert Walser che a Charles Baudelaire dobbiamo pensare, poco intento alla decifrazione della “foresta di simboli”, quanto più incessantemente attratto verso gli squarci che aprano a una partecipazione panica ed erotica nei confronti dell’esistenza. Grande, dunque, è un aggettivo che gli accostiamo per collocarlo fra le voci più alte e pure della letteratura europea del ‘900, ma tenendo conto che la sua grandezza sta nella sua esilità, nell’assenza di grandi disegni narrativi, nell’evanescenza, nel breve disegno di destini particolari, nella capacità di far balenare immagini nitide, poeticamente compiute, ma pronte a essere soffiate via al primo refolo di vento… Come nelle pennellate nominali che introducono il meraviglioso racconto Sinağrit Baba, la storia di un dentice che si impicca a una delle tante lenze che oscillano nelle profondità del mare:
Una bella sera invernale. Vento da sud. Sul mare varie chiazze rossastre. Un colore di tisana di tiglio lasciata bollire troppo, e onda lunga, piatta, morta. Le barche oscillano lente, le esche aspettano, le persone tacciono.
Il mare – ci torneremo – è un polo spaziale e poetico cruciale per l’autore. Ma all’altro polo, non si può non parlare del teatro delle sue lunghe passeggiate, della passerella caleidoscopica che governa il destino degli incroci e degli incontri, la matrice delle storie, la narratrice somma di cui l’autore si fa interprete e scrivano: Istanbul. La città il cui corso principale è costituito da un braccio di mare. Stranamente, nel suo ampio libro a essa dedicato, il premio Nobel Orhan Pamuk fra i tanti autori che cita non nomina mai Sait Faik Abasıyanık, forse colui che più di tutti ha saputo penetrare l’anima di questa città. La cosa appare forse meno strana quando si pensi alla siderale distanza che corre fra la poetica di Pamuk, con la sua sovrabbondante nostalgia romanzesca post-imperiale, e quella invece di Faik, così minimale e universalista, laconica e sobria. Istanbul, si diceva. Dalle pagine di Faik emerge una città che non lascia tregua ai sensi, che eccita e percuote costantemente le membrane percettive, che incessante si replica, freneticamente si evolve. Creatura viva, ciarliera e linguacciuta a dialogo con altra creatura viva, ma taciturna e inespressa, il mare. Quella che l’autore percorre e racconta, fra il gli anni ’30 e ’50, non è già la metropoli che conosciamo oggi, ma non è già più la capitale dell’Impero. È una città in profonda trasformazione, spodestata da Ankara come cuore della nazione. Dopo la fondazione della Repubblica e durante la giovinezza dell’autore, Istanbul ha visto drasticamente calare la sua popolazione, mentre, negli anni in cui Faik cede alla malattia e muore, la città è sul limitare di un’esplosione urbanistica, pronta a vedere sparire quella fitta rete di villaggi greci, armeni ed ebrei che collegava una sponda all’altra e intrecciava il tessuto di una città squisitamente mediterranea, per arrendersi ormai a essere conquistata dall’Anatolia profonda. Sull’orlo di una sua ennesima metamorfosi, agli occhi di Faik Istanbul è una città elencabile e innumerabile, i personaggi delle sue brevi storie sono ciascuno una tessera di un mosaico enorme e in movimento. La città è autrice di destini, la sua geometria predispone un nascere incessante di intrecci che l’autore registra e annota. Detective di un giallo che è il mistero della vita. E va detto che egli accede alla città da una prospettiva laterale e diversa dagli altri. La sua abitazione, condivisa con la madre teneramente amata fino agli ultimi giorni, si trova sull’isola di Burgaz, sul Mar di Marmara, a circa venti chilometri dal centro e dove oggi sorge la sua casa-museo. C’è un traghetto che lo separa dal brulichio della città, c’è un’oasi di silenzio idillico e quasi provinciale contro cui far risaltare il frastuono, il sudore, lo sporco di Istanbul. Dal remoto dell’isola, la città è un richiamo costante e luminescente, è un corpo invitante che si rivela poi inattingibile, impossibile da possedere a pieno. Nella preziosa postfazione, Bellingeri parla giustamente dell’amore di Faik per la “bellezza bramata e non attinta”, dell’impossibilità di soddisfare il richiamo costante del desiderio. Ed è forse da questa sua collocazione isolana e insieme urbana che nasce questa frustrazione, da questa sua distanza poetica, da questo quotidiano tentativo di tradursi dall’isola alla città per poi a notte, consumati e svaniti i fumi dell’alcol, celebrare il rito del distacco e tornare all’urna di silenzio, alla quiete uterina e materna di Burgaz ada, senza in tasca nemmeno un soldo di verità, ma solo tante immagini abbaglianti, storie minime, brevi e universali, consumatesi all’angolo di una strada, ai tavolini di un caffè, sull’imbarcadero dei piccoli pescatori (vedi il racconto Un puntino sulla carta). Con le sue immagini confusamente accese nella mente, Istanbul non lascia tregua nemmeno sulle isole.
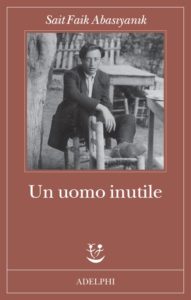
È solo sospesi sul mare, nei momenti di passaggio e traghettamento da una terra all’altra, così vicini al nulla, alla “morte per acqua”, alla presenza sottile del confine fra vita e morte, fra logos e caos, che si può trovare qualche attimo di requie da quella città che altrimenti sollecita senza posa l’osservazione, la percezione erotica, la libido. Sul mare, dondolati insieme a un pescatore e a un gabbiano la città momentaneamente cessa il suo trambusto e dal silenzio lascia emergere una voce terrifica. È da quella vicinanza abissale col nulla che nasce l’esigenza della parola, della scrittura:
Dall’universo blu che stava sotto di noi giungeva un rumore sordo, abissale. Udivo, da quegli abissi, un suono profondo e lontanissimo, un altro genere di rumore, diverso da quelli della terra che ci sono familiari: suoni umani, animali, fischi, rumori di macchine, del legno, del vento, dei cavi, di alberi, di insetti… Pensai che fosse il verso di questo universo blu, che inspirava ed espirava. Come una formica, che sente una milionesima parte di tutto ciò che sentiamo noi, anch’io udivo, tra miliardi, un suono sordo e profondo, una minuscola parte di quella straordinaria creatura vivente chiamata mare. Mi pulsavano le tempie, mi fischiavano le orecchie. Sono sempre stato intimorito dal vuoto muto di questa voce immobile e profonda. Voglio parlare. Mi viene da urlare per non sentire questa voce. Ora vado a nuoto a Sivri Ada, pensai, è lì che stiamo andando, tocco riva e mi metto a cantare a squarciagola (Una storia per due).
Poggiati su trame esilissime, i racconti di Sait Faik ricordano dei fiammiferi che si accendono nel buio, illuminano intensamente gli oggetti a portata e poi si spengono con grande rapidità. Nello spazio di quel breve respiro, i sensi sono accesi a catturare odori, suoni, sapori. Le figure umane del popolo minuto affaccendato nelle strade spesso scambiano “occhiate discrete, timide, sebbene colpevoli, perché umide di libidine” (Bellingeri). I personaggi vivono di propositi subito disattesi, di contatti umani fugaci; ingannano sé stessi e il tempo. L’ispirazione è occasionale e i racconti vengono pubblicati per lo più su giornali e riviste, è assente un disegno complessivo, un progetto d’ampio respiro. La scrittura, a volte, sembra voler ingannare la pagina. Riempire di storie infinitesimali il panico della pagina bianca. Alla fine di alcuni racconti, ci si sente come ingannati, come se lo scrittore ci avesse truffato rubandoci l’attenzione per lo spazio di qualche minuto senza portarci da nessuna parte. Ma poi, chiudendo, ci si ritrova in tasca qualche seme di poesia, uno strano, quasi dimenticato, senso di fratellanza, un paesaggio, un’immagine dietro cui la mente può perdersi come in una meditazione, uno sguardo obliquo verso la vita, uno slancio affettuoso. Vive di brevi attimi che persistono nella memoria la magia della scrittura di Sait Faik. Quasi la sensazione di aver condiviso quattro chiacchiere rivelatrici con uno sconosciuto che poi si allontana lungo la via e non rivedremo mai. Ci sono momenti in cui l’autore si presenta con autoironia e conduce il pezzo sul prezzo che costa un suo racconto (I miei vent’anni da scrittore); in altri il poeta è trasfigurato in un animale goffo e dolorante, incapace di respirare nel mondo: stavolta non l’albatro di Baudelaire, ma il pesce San Pietro (La morte del pesce San Pietro). In un racconto, bellissimo, intitolato Latte, l’alter ego dello scrittore sembra credere che la redenzione da una vita dissoluta possa trovarsi proprio nella bottega di un lattaio, in un ritorno illusorio alla comunione liquida e dissetante con il seno materno:
Sono entrato nella bottega del lattaio come rigenerato. Avevo voglia di lanciare un grido. Quasi stessi venendo alla luce. Ogni mattina, ormai, mi risveglierò fresco come un neonato…Quarantadue anni dopo, rinascerò in un mondo di pace e libertà, e di latte.
La raccolta è studiata in modo da darci il senso dell’evoluzione letteraria dell’autore. È una selezione di racconti, scelti dai curatori a partire dalle nove raccolte pubblicate in patria. Nei primi racconti c’è un sorriso che si spande fra le pagine, è ancora forte un senso di ottimismo, di possibilità di toccare la vita, comparteciparvi, abbracciarla in un bisogno copioso di scambio e di affetto: per il genere umano, per la natura, per ogni creatura, per ragazze e ragazzi, ugualmente concupiti. Con l’avanzare del tempo, però, l’immaginario sembra sempre più intorpidirsi, il fegato farsi amaro e nero per lo scorrere dell’alcol (la cirrosi lo porterà alla precoce morte), la frustrazione conduce verso orizzonti più cupi e allucinati. Entrano dei doppi, dei personaggi immaginari, l’amore totale verso gli altri inizia a essere percorso da gelosie o mancanze. La città inizia a farsi odiare, la morte entra fra i temi del suo scrivere. Ahmet Oktay descrive l’approdo a questa fase finale della scrittura di Faik come un passaggio “dal piacere al dolore, dalla fiducia alla paura, dalla convinzione al dubbio”. Spia ne è il ricorrere un po’ ossessivo di uno stesso personaggio, Panco, in diversi racconti: cosa mai avvenuta in precedenza.
Si sono fatti molti paragoni per inquadrare la scrittura di Sait Faik: il “Čechov turco” si è detto, è stato nominato Kafka, poi Walser, Kavafis e Penna anche per certa passione per i corpi al sole, si potrebbe arrivare fino a Pessoa. Tutti paragoni che colgono aspetti particolari. Ma in quest’ultima fase allucinata dell’opera di Faik, quando la solitudine inventa personaggi e assassini diventano piccoli come chicchi di sesamo per entrare nelle tasche del protagonista, il paragone migliore viene da cercarlo più a oriente, in quella grande figura che per cronologia, interessi e vocazione gli è misteriosamente simile: ovvero Sadeq Hedayat (1903-1951), scrittore persiano vissuto quasi negli stessi anni, anch’egli in un ex-impero sospeso fra modernizzazione e decadenza, anch’esso attratto dal mondo francese e cultore della forma racconto, anch’esso spinto da una pulsione devastante verso la vita che sembra esaurirsi, frustrata, in un cupio dissolvi mediato da alcol e oppio, infine dal suicidio (per le sue opere si consulti il catalogo di Carbonio editore). La scrittura di entrambi è pervasa dalla densa presenza della solitudine che cede all’allucinazione.
Ciò che è certo è che la vita non offrì mai a Faik una precisa collocazione. Fu studente pigro e discontinuo, visse in Francia per tre anni e visitò Milano. Al ritorno in patria provò a fare l’insegnante, ma arrivava sempre in ritardo, la classe gli sfuggiva dalle mani come uno dei tanti pesci dei suoi racconti. Traduce Gide, poi anche O’Flaherty e Simenon. È amico soprattutto di pescatori (e peccatori), osti, bottegai e ragazzi di vita, ma non è estraneo a frequentazioni di importanti figure culturali del suo tempo: il pittore Abidin Dino, lo scrittore Orhan Kemal, i poeti Orhan Veli e İlhan Berk. In un paese che reagiva alla caduta dell’Impero attraverso la chiave della monumentalità nazionalista e modernista, egli, lontano da qualsiasi retorica, è mosso da una vocazione all’erraticità, alla pigrizia, al pacifismo: per il racconto Çelme viene processato da una corte militare con l’accusa di disamorare il popolo al servizio militare. Era il 1940, e in quel caso ricevette il sostegno di colleghi illustri come Orhan Veli e subì le accuse di altrettanto illustri colleghi come Peyami Safa. Scrive due romanzi, ma con scarso successo. La sua cifra è il frammento, il respiro corto, il bozzetto. La sua parola è un corpo a corpo costante con la vita guidato da ironia, ammirazione, curiosità, divertimento, incanto e disincanto, percezione della poesia che aleggia fra le cose. Appare e scompare dal mondo della letteratura come una meteora luminosissima. Nella foto di copertina lo vediamo seduto scomposto su uno sgabello di paglia, dietro di lui bicchieri vuoti di çay o probabilmente rakı, intento a un’osservazione insieme attenta e stralunata, circondato da una città che lo ignora, pronto a cogliere e ad annotare l’attimo in cui sullo spazio della sua pagina balugini il nostro spirito.
Lo scenario cambia di minuto in minuto, di ora in ora; quando la strada sarà completamente deserta non sarà più la stessa. Osserverò questa scena mutevole e ti aspetterò, ogni giorno, fino a sera. Una volta sceso il buio, me ne andrò a bere. Poi, ti troverò di nuovo (Le tre condizioni dell’uomo in attesa).
Francesco Marilungo
Illustrazione di copertina ©Eren Topçu.








