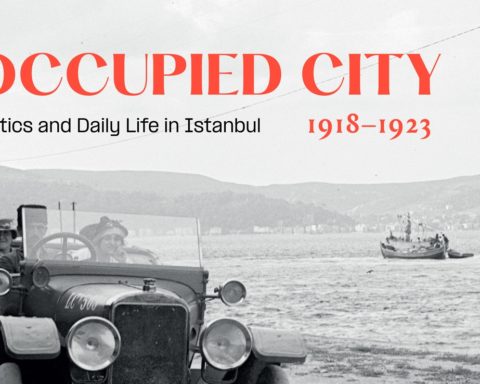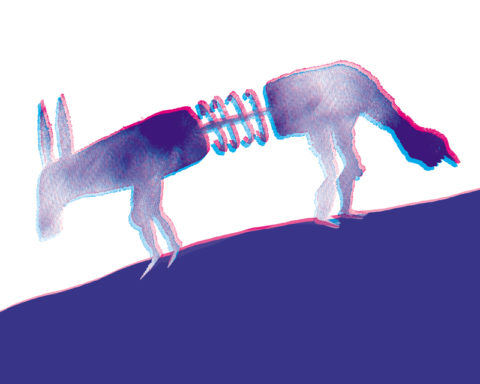Un racconto di Mahir Ünsal Eriş
Io e mio padre abbiamo fatto la rivoluzione nello stesso paese in decenni diversi, entrambi abbiamo fallito. La sua si è con conclusa con una brutalità che può essere rappresentata da scarponi che calpestano fiori, la mia invece ha dovuto soccombere alle condizioni del libero mercato. Entrambi siamo corsi dietro a un pallone nella stessa città in squadre diverse. In quello io ho fallito. Ma lui ci è riuscito, ha quasi avuto successo. Come figlio di un padre dotato per il calcio, ho consolato la frustrazione per un’inettitudine tale da poter comparare il mio piede a un’accetta, essendo orgoglioso di lui. Si fosse trattato di parlare, avrei detto che non mi si era sciolta la lingua, si fosse trattato di cantare, avrei detto che non avevo la voce adatta; non c’è stato verso insomma. Non ero dotato, al primo allenamento il mio piede ha toccato la palla solo quattro volte. Dopo il secondo allenamento d’altronde, quando l’allenatore mi si è avvicinato togliendosi i parastinchi e dicendo in modo da non farsi sentire da nessuno: “Caro, se vuoi smetti di stancarti inutilmente”, per me il calcio è finito. Senza voce, stonato, ho sviluppato il talento di contentarmi di ascoltare. Ma mio padre in un modo o nell’altro ha saputo dare prova di se stesso. Almeno con noi, forse anche con altri da qualche altra parte. Ho passato l’infanzia sognando e sperando di vedere un giorno la foto di mio padre con la maglia del Fenerbahçe sul giornale. Addirittura la fotografia della notizia era pronta in tutti i suoi dettagli nella mia mente. Mio padre era il capitano della squadra, certo. La foto era stata scattata mentre scherzava con Schumacher, ad esempio mentre cercava di togliere il berretto a Toni. Mio padre aveva indossato la maglia a righe di Lefter e la fascia di capitano, Schumacher invece aveva la maglia gialla, il mio più grande sogno d’infanzia. Mio padre rilasciava dichiarazioni del genere: “Siamo una squadra fenomenale, la complicità e l’affiatamento ci porteranno alla coppa”, proprio come si addice a un capitano. Raccontava che il segreto che aveva fatto tornare il Fenerbahçe ai vecchi tempi era nascosto nel suo essere capitano della squadra.
Mio padre non è mai andato al Fenerbahçe, se non si contano le partite che abbiamo visto insieme in tribuna a Kadıköy. Ma in qualche modo, avevo sei anni allora, lo hanno voluto a Samsun. Di giorno lavorava al molo di Kadıköy, nell’ufficio della Koç, la sera giocava a Üsküdar, tra gli Amatori. Lo aveva raccontato radioso mio padre, il cognato del direttore era allenatore a Samsun, quando aveva visto come proprio davanti all’area di rigore aveva sbeffeggiato quell’orso da vero re degli stopper, appena era tornato aveva fatto chiamare l’Anadoluspor di Üsküdar. Si erano messi di mezzo, da una parte e dall’altra e gli avevano fatto lasciare il lavoro a mio padre. E Samsun a quei tempi era vorace, all’Anadolu c’era aria di tempesta. Era passato in Serie A, l’emozione e l’attesa erano grandi. Era tutto un fermento mio padre. Lasciato il lavoro con stipendio, la casa obbligatoriamente in affitto, la moglie e me a Istanbul, prese e partì per Samsun. Fino all’inizio della stagione tornò una sola volta. Lavoravano, lavoravano sodo. Non somigliavano all’Anadoluspor loro. C’erano i tifosi, c’era girare per le strade di Samsun, c’era il lavoro, lavoro sodo. Ci telefonava tutti i giorni. Gli allenatori erano contenti. Era molto piaciuto alle amichevoli. Stava per indossare la maglia. Lo stopper della squadra era vecchio, seppure un uomo in gran forma. Ma la fortuna sarebbe girata certamente dalla parte di mio padre. E doveva girare, gli avrebbero dato un premio per ogni partita, trasferte escluse. Al telefono ci raccontava tutto questo.
Per le prime tre settimane era rimasto in panchina mio padre. Era tornato all’hotel che avevano prenotato per lui senza che avesse pestato l’erba. La quarta settimana, quando durante gli allenamenti lo stopper veterano ebbe uno stiramento, nacque l’occasione che mio padre aspettava. Ma la sfortuna, quando ti si ferma sulla testa come una nuvola nera di disgrazia, non se ne va senza prima aver piovuto. La veglia del giorno della partita fummo scossi dalla notizia della morte di mia nonna che abitava a Gebze. Quella volta fummo noi a telefonare a mio padre per dargli la triste notizia. Tornò il mattino dopo in fretta e furia con il primo aereo, nel pomeriggio eravamo a Gebze. Mia nonna aveva trovato il tempo per morire. Proprio quando mio padre aveva completato la preparazione sportiva, appena si stava adattando alla squadra, proprio nella settimana in cui avrebbe indossato la maglia… Utilizzando i dieci giorni di permesso non avrebbe più tenuto le fila mio padre. Mentre correva tra Gebze e Istanbul tra funerale, eredità e notaio, la squadra aveva cominciato a prendere forma, quando tornò si era strutturata al punto da non trovare un posto adatto per mio padre, aveva fatto gruppo. E siccome il tizio messo al suo posto giocava bene, a mio padre toccò il ruolo di riserva della riserva. Soltanto se qualcuno si fosse fatto male, infortunato fino al termine della stagione, mio padre aveva speranza di entrare. Il tempo in cui rimase in campo non superò mai i venti minuti. E nella partita contro il Fenerbahçe non era neanche tra le riserve. Non l’avevano neppure portato da Samsun mio padre. Io e mia madre eravamo andati a vedere la partita allo stadio. Mio padre, essendo del Samsunspor, lui, non era potuto venire. Fosse stato a Istanbul, almeno l’avrebbe vista dalla tribuna, da tifoso del Fenerbahçe.
Quando cominciarono a non prenderlo neppure tra le riserve mia madre aumentò le sedute di pianto in solitaria, si trasformò in due occhi vistosamente bagnati, in una cascata di lacrime. A metà stagione annullarono il contratto con mio padre e lo rimandarono a casa. E mio padre tornò a casa pallido come un fogliaccio e delle occhiaie scavate come soffrisse di calcoli renali. Poi senza quasi più muoversi trascorse la vita in casa. Rimase lì, fermo dove’era, come se credesse che se si fosse mosso, se come tutti i padri di giorno fosse uscito di casa, andato al lavoro, allo stadio, al caffè, a passeggiare in centro, ce ne saremmo accorti e lo avremmo preso in giro. Non parlava, non si faceva vedere, non rideva, non piangeva, non gridava, non usciva; rimase fermo lì. Ha sempre creduto che non gli avessimo mai perdonato di aver abbandonato la casa e la famiglia, di essersi perso per le strade rinunciando al lavoro che aveva allo scopo di ottenere per sé una brillante carriera, per noi un luminoso futuro. Eppure noi non eravamo arrabbiati con lui, ma con quella cosa, fortuna fato destino qualunque essa sia, che non permette mai in nessun modo che le cose vadano per il verso giusto. È quella che non abbiamo mai perdonato.
Non ha neppure provato a trovarsi un lavoro mio padre una volta tornato da Samsun. Con i soldi guadagnati da quelle tre o quattro partite più la trasferta, ha comprato il piano inferiore della casa di mia nonna a Gebze. Con l’affitto dei due piani abbiamo tirato avanti così, senza dover chiedere nulla a nessuno. Prima che le banche diffondessero l’utilizzo dei bonifici, una volta al mese andava a Gebze a riscuotere l’affitto. Quando anche quell’operazione è diventata più semplice, è rimasto così, come fosse un soprammobile di casa. Tutta la mia infanzia, l’adolescenza è trascorsa in maniera liminare alla presenza di un padre sempre fermo dentro casa. Non lavorava, non andava da nessuna parte, se pure usciva brevemente, due ore dopo tornava con la faccia compunta per aver visto il mondo come se lo ricordava. Vedeva il mondo lasciato fuori dalla porta, dalla finestra, dal balcone di casa come un cumulo di insuccessi. E certo, più che altro comprendeva i suoi di insuccessi. Aveva trascorso, come tutti i bambini cui risplende il volto, un periodo della vita del paese credendo alla possibilità della rivoluzione come una mano calda che carezzi la schiena. Se la rivoluzione accadeva o meno, quello è un altro discorso. Ma anche soltanto credere alla rivoluzione aveva un gusto, direttamente connesso all’insoddisfazione, che alleggeriva la coscienza, che rinverdiva l’animo nei periodi più insperati. Il giorno in cui la possibilità della rivoluzione, in un momento in cui si credeva tanto vicina da mostrare le luci, fu soffocata in un buio spaventoso, e vedendo che anche il proprio destino personale era affondato, mio padre dovette trasformarsi in un uomo completamente diverso. Perché mio padre amava prendere su di sé tutte le sfortune del mondo. È per questo che persino l’insuccesso della rivoluzione l’ha sempre visto come qualcosa da scrivere nella sua personale storia dei fallimenti. È per questo che in ufficio si sentiva punito a strappare biglietti. Perché il primo e imperdonabile insuccesso era quello secondo lui. Non era riuscito neppure a fare una rivoluzione. Eppure nelle fotografie con i peli sopra il labbro talmente radi da non poter essere definiti baffi di sinistra, davanti alle locandine stellate, ai manifesti col pugno chiuso, sembrava tanto felice. Neppure una volta noi lo abbiamo visto sorridere come sorrideva con i compagni coi pantaloni a zampa di elefante. Da piccolo pensavo che amasse quei suoi amici con baffi e basette più di noi, che loro fossero morti e non riuscisse ad amarci perché aveva nostalgia di loro, ed era per quello che non c’era verso potesse ridere di nuovo in quel modo. Perché il sorriso di mio padre, nei giorni in cui la possibilità della rivoluzione era calda, era rimasto congelato da qualche parte tra manifesti e locandine, e noi non riuscivamo a farlo sciogliere.
L’unica cosa che amava, l’unica cosa a cui credeva era il calcio. Non aveva studiato. Quando ci fu il colpo di stato era stato costretto a interrompere gli studi all’università tecnica di Tașkıșla. Non era riuscito a trovare un lavoro che gli piacesse. Nessuno dava lavoro a un vecchio attivista rimasto dentro quattro anni e mezzo. Non aveva potuto costruire né per sé né per la donna che amava la vita che aveva desiderato. D’altronde, come se non bastasse non essere riuscito a fare la rivoluzione, non aveva avuto successo neppure nella squadra dove era stato trasferito e era tornato a casa, lo svergognato. Addirittura forse il colpo di stato era avvenuto per colpa sua, e mia nonna era morta per lui. Credendo che sarebbe riuscito almeno nel calcio, una volta presa la lezione anche lì, mio padre decise definitivamente di scomparire. Si tolse dalla circolazione, si mise a sedere nel salotto di casa, a fianco di una finestra davanti alla televisione.
Invecchiava. Un giorno aveva scelto d’invecchiare d’altronde, ma mentre io crescevo invecchiava anche fisicamente, per conto suo. Fare come tutti i suoi coetanei che sapevano fosse inevitabile, sforzarsi di rubare alla vita correndo a destra e sinistra, partendo per gite, viaggi in barca, 3 giorni e 2 notti a Praga, frequentando parchi di divertimento, caffè per pensionati, gli sembrava inutile. Voglio dire come apriva bocca era preso da una rassegnazione che gli faceva dire “Invecchiamo tutti, tutti moriremo, non serve a niente che vi affanniate”. Passava buona parte del tempo a risolvere parole crociate, a trascrivere su dei quaderni le parole che trovava, a raccogliere ritagli di giornale e a bestemmiare contro la televisione. Soltanto, siccome andare al mercato di Üsküdar significava trainare il carrello su per la salita, il lunedì, visto che a mia madre faceva male la schiena, andava al mercato che da Fıstıkağa si allungava sino a Selamsız, poiché era vicino, metteva nel sacchetto della spesa le cose che la sera gli scriveva mia madre e il tabacco che comprava dal solito uomo da anni, poi tornava a casa. A parte questo, a meno che non fosse chiamato dallo stato o dalla banca, non metteva molto piede fuori casa. Non era triste, era inasprito ma dentro di sé orgoglioso. Non parlava molto ma aveva trovato mille vie per raccontarci tante cose. Per esempio certe settimane il mercoledì mattina non si alzava quando noi ci svegliavamo. Si svegliava presto anche la domenica, ma alcuni mercoledì non si svegliava. Questo significava “Ho guardato il pugilato con la parabola fino alle cinque del mattino, mi sono addormentato tardi, lasciatemi stare”. In mattinate simili facevamo colazione in un silenzio rivoltante io e mia madre. In ogni angolo della casa scriveva note per noi e per se stesso. “Il pulsante dello scaldabagno non funziona, usate l’accendigas!”, “Ti ha chiamato Öner, voleva sapere se stasera resti da loro. È noioso, un po’ alla buona, ma un bravo ragazzo. Ha detto di chiamarlo quando torni!”, “Alle 9h30 stasera su canale 6 danno Piano Piano Bacaksız, non te lo scordare!”, “Ho messo l’olio della frittura nel barattolo, nella dispensa!” Specchi, libreria, armadio, vetrina, mobile del televisore, comodino del telefono, tavolini, tutto era cosparso di note. Con mio padre ho visto come una persona, dal momento in cui entra in casa e si chiude la porta dietro, possa vivere senza sfiorare gli altri, come possa restare senza altri amici che se stessa con cui parlare. Negli anni dell’infanzia e della prima giovinezza trascorsi con la tensione dell’aria di quando non riesce a piovere che si era portato dietro da Samsun dopo essere uscito di casa come un sole, ho imparato questo da lui. E noi, che fosse un architetto mancato di Tașkıșla, un bigliettaio alla Koç, o un giocatore dell’Anadoluspor, lo abbiamo sempre considerato allo stesso livello. Anzi, forse in fondo lo amavamo ancora più profondamente. Quando ha perso la testa lasciando il lavoro, quando ha percorso tanti chilometri di strada per inseguire il suo sogno, quando si è accontentato delle coperte odoranti di muffa nelle stanza di hotel mentre a casa lo aspettava sua moglie, tanto lo conoscevamo, tanto lo rispettavamo. Qualcuno gli ha mai detto una parola? Fatto un’allusione? Quando da una squadra professionale è giunta una sonante proposta di trasferimento doveva forse restare a riempire note di consegna in ufficio? Che non fosse contento matto? Come se fosse stato meglio non essere andato… Ma lui, con quella cosa trasformata in una questione di orgoglio, ci ha lasciato fuori dall’enorme barriera che si era costruito intorno. Ha scelto di comportarsi come abitassimo nella stessa casa per caso, ha creduto che chiudendosi così non lo avremmo visto, e se non l’avessimo visto non gli avremmo rinfacciato di aver buttato tutto all’aria per niente. A andare tutto all’aria è cominciato in quel momento a dire il vero. Mio padre nella nostra casa nel cuore di Üsküdar ha deciso di vivere in una grotta di montagna, lasciando noi e il mondo per conto nostro.
A diciotto anni ho passato il test d’ingresso alla ODTÜ e sono venuto a Ankara lasciando i miei dentro al silenzio sconfitto e infinito, al pallore stantio di mio padre. Da mio padre, dai mie zii, uno morto a trentasette anni per le malattie contratte in carcere e fortificate bevendo alcool fuori e l’altro che ancora beve, dalle mie zie, e un poco anche da mia madre, avevo ereditato una buona stoffa per la rivoluzione. Non ci è voluto molto tempo prima che quello stato magico che nella loro gioventù li aveva strappati dalle loro case e li aveva mandati a fare la calce nei quartieri liberati, nelle baracche costruite di notte, a distribuire riviste, facesse presa sul mio animo. D’altronde quando sei alla ODTÜ la rivoluzione sprizza persino dalle aule magne, dagli alberi, dagli stadi; avevo dimenticato mio padre. Avevo scambiato quell’avvilimento, quella mai interrotta tristezza ingiustificata di anni con il corso eccitato della mia nuova vita. La sconfitta, la malinconia, lo stato depresso di casa me li ero lasciati alle spalle insieme alle crisi adolescenziali. Nei quartieri poveri avevo avuto nuove madri e nuovi padri che mi chiamavano figlio mentre cercavamo di riempire il posto lasciato dai loro figli e figlie. Portavo giornali e riviste, provviste, sacchi di carbone che avevamo reso pubblici sottraendoli al deposito di Akdere, portavo vestiti invernali raccolti in associazione. Distribuivo opuscoli, ho svuotato decine di bombolette spray sui muri infreddoliti delle case piangenti. Sarebbe successo, se non oggi, domani, ci credevo, un giorno sarebbe successo e volevo vedere quel giorno. Perciò ci ho creduto; ci ho creduto ecco.
Non posso dire che non ci creda ancora. Una pena sottile da qualche parte del cuore, quando vedo qualcuno con manifesti in mano, striscioni arrotolati, si fa sempre sentire. Ma la vita non è abbastanza. La vita viene e ti si para davanti in un modo tale che i sogni, le speranze, tutto quello che hai immaginato dall’infanzia e dalla gioventù te lo fa ingoiare. Vengono gli esami, vengono i colloqui di lavoro con le cravatte indossate a forza, viene il servizio militare, viene la carta di credito, la fine del mese, i vecchi che muoiono uno a uno, vengono i giovani che invecchiano uno dopo l’altro. Di punto in bianco comincia a appesantirsi la vita. Come qualcosa di appiccicoso. Si impregna alle ali, la gente rimane come incastrata. Insomma non che saresti volato, ma comunque è difficile. Fare sogni per un più grande domani resta lì in mezzo alla realtà che domattina andrai al lavoro o a cercarne uno. Si fa dimenticare. Come se non fosse quello ad averti fatto passare tutta la gioventù in mezzo a luci sfolgoranti. Poi la gente si vergogna a forza di vedere quelle riviste avvolte di rosso, i giovani dalle sopracciglia aggrottate che cercano di accattivarsi speranzosi la gente delle strade da un megafono scassato, quelle lettere a forma di falce scritte sui muri con una fretta irregolare. Si vergogna come se tutti avessero scoperto una bugia sempre ripetuta in passato. Si allontana da chi gli sta fianco cercando di non incrociare lo sguardo, non è così la vita? Mentre stiamo cercando di fare qualcosa di bello, proprio mentre le migliori cose stanno per succedere. Così vivere, sarebbe un modo di perdere rinunciando ai nostri sogni di fronte alla realtà della vita.
Dopo l’università sono rimasto a Ankara. Gli amici si sono stupiti, mi hanno forse persino biasimato prendendomi in giro. Quando nel mondo c’è un posto che si chiama Istanbul, quando ci sono così tante città che ti mettono il mare in braccio, che coltivano il vento, non capivano come potessi rimanere a Ankara, secca come una galletta. Neanche io lo capivo. Si chiama la lotta per il pane questa, dicevano; non c’era alcuna possibilità di convincermi.
Mio padre invecchiava. Dicendo che invecchiava non intendo che non poteva fare le scale, che aspettava impaziente le sei del mattino per farsi segnare le medicine o che metteva i denti in un bicchiere d’acqua, solo che la sua giovinezza si spegneva. Impallidiva. I peli bianchi dei capelli e dei folti baffi che sembravano essere la ragione del suo silenzio stavano per sconfiggere quelli neri. Ogni due tre settimane ci costringevamo a parlare al telefono, come ogni volta non avendo niente da dirci e sapendo che niente di quello che gli avrei detto lo avrebbe interessato, chiudevamo la conversazione dopo silenzi stagnanti. Erano come turni cui eravamo obbligati a intervalli regolari le nostre telefonate. Portato a termine il compito, eravamo tranquilli sino alla volta successiva.
Una sera, uscito da lavoro verso le sette e mezzo, immerso nella preoccupazione immobile del traffico di Ankara che attanagliava da qualche anno la città, è squillato il telefono. Era mio padre. Essendo una telefonata che rompeva la routine mi preoccupai. Dio lo sa, pensai subito a mia madre. È così, fosse successo qualcosa a mia madre sarebbe stato lui a chiamarmi, a darmi la notizia. Risposi in fretta e con voce interrogativa, “Papà?”. La voce mi rispose con la mollezza di un diciassette diciottenne e un’allegria che definirei deliquescente, “Che mi racconti architetto!” chiese ridacchiando, era la voce di mio padre. Fu come quando nei momenti di panico entra in funzione una mente di riserva che pensa immediatamente al posto tuo tutto ciò che è pensabile e in un tempo inferiore al secondo. Ecco mi venne a mente che mio padre a forza di stare seduto in casa a poltrire, alla fine era riuscito a impazzire. Perché l’immagine che avevo in mente di mio padre era pallida al punto da non riuscire a collegare la sua allegria a nient’altro. “Cos’è successo?” riuscii a dire, con l’attitudine di finta calma che si assume per non spaventare i matti. Facendo scendere ancora di qualche anno l’età della sua voce e alzando ulteriormente il tono, con una gioia di dodicenne quasi gridò “A Samsun, andiamo a Samsun!” Samsun; quella città che non avevo mai visto, conosciuta come speranza, che poi aveva coperto la nostra vita con una coltre fredda e metallica, la padrona di casa della delusione che ci aveva tolto mio padre. Il dubbio che mio padre potesse essere impazzito si fece più fondato. Forse è davvero così che le persone impazziscono. Una volta che ci si è messa in testa una cosa, nella mente si apre un piccolo foro, poi a forza di girare lì dentro quel foro si allarga al punto di inghiottire tutta la mente. A forza di pensare a Samsun, Samsun di qua, Samsun di là, alla fine è impazzito, pensai. Morivo di curiosità ma rimandai perché credevo fosse meglio parlarne in un posto più tranquillo. “Papà sono in mezzo al traffico adesso, ti chiamo appena arrivo a casa”. Mio padre era così contento che non se la prese. “D’accordo” disse e chiuse la conversazione. Perché e percome, con il traffico lento che affliggeva Ankara, riuscii a arrivare a casa quaranta minuti dopo, appena entrai chiamai i miei.
Con grande emozione cominciò a raccontare sin dall’inizio della creazione. Il Samsunspor festeggiava il suo quarantacinquesimo anno. Quanta gente era passata da allora. Perciò per fare le cose in grande avevano chiamato tutti i vecchi giocatori per consegnare loro una targa. Addirittura quel giorno, dopo la cerimonia, i vecchi giocatori avrebbero giocato contro gli attuali in una partita serale. E non si erano dimenticati di mio padre. “Saremmo molto felici di vederla tra noi” gli avevano detto. I colleghi che si occupano dei biglietti aerei la contatteranno” gli avevano detto, gli avevano comprato il biglietto, lo avrebbero ospitato in un grande hotel. Con una premura in ritardo e una fedeltà sorprendente avrebbero viziato mio padre. Gli avrebbero offerto da mangiare, consegnato la targa, scattato fotografie. Forse avrebbero addirittura fatto delle interviste, qualcuno avrebbe chiesto autografi sulla divisa e sul pallone. Avrebbero annunciato mio padre come “giocatore veterano”, con una gioia inconsapevole del mondo sarebbe stato indicato come “uno dei veterani che hanno portato la squadra ai livelli di oggi”. Neppure la rivoluzione avrebbe potuto farlo tanto contento.
Organizzammo il viaggio. Il fine settimana sarei andato a Istanbul, da lì, il lunedì mattina saremmo partiti insieme per Samsun. Io non conoscevo affatto la città, non l’avevo mai vista, ero curioso. Mio padre era emozionato anche per farmi da guida, con l’esperienza maturata in quel suo breve soggiorno. “Ti porto al Mercato Russo,” diceva, “Ci sono cose bellissime. Una volta ho trovato per caso una medaglia di guerra sovietica, grossa così, con falce e martello e tutto. L’ho avuta per tre centesimi.” Non gli ho chiesto dove fosse quella medaglia. Ho avuto paura che rispondesse “Venendo via in fretta e furia da Samsun chissà che fine ha fatto”. Ho avuto paura che gli scorressero davanti agli occhi i tristi colori di quei giorni, volevo che se ne ricordasse felice com’era in quel momento. Volevo che si desse delle arie. Perché crescendo, potevo capire meglio mio padre, aveva perso il gusto di vivere non perché non aveva avuto successo, ma perché non gli era rimasto niente di cui vantarsi con noi. Suo padre era commerciante, un uomo molto stimato. Mio padre credeva che per rispettare il padre, i figli attendessero qualcosa di simile da lui. Forse a suo modo aveva ragione ma non valeva comunque la pena restare per tutti quegli anni così come una seggiola di ferro sul balcone che conservava bei ricordi ma alla fin fine restava pur sempre una cosa fredda di metallo.
Il mattino alle nove e mezza atterrammo all’aeroporto di Çarșamba. Appena scesi l’aria tiepida e appiccicosa del Mar Nero ci avvolse dappertutto come una gelatina cosparsa sulla pelle. Ci volle un’ora per arrivare al centro della città. Dalla navetta di servizio scendemmo di fronte a un grande e anonimo edificio. D’altronde costruire un edificio tanto ripugnante in riva al mare è cosa che può venir in mente giusto alla burocrazia. Dando la schiena alla prefettura bianca e rosa come una torta di compleanno e al mare, guardammo verso la città che si innalzava davanti a noi. Mio padre guardò a lungo la città, il parco di fronte, quella statua a cavallo simbolo del parco e la piazza, come un personaggio di un film d’autore. Felice come qualcuno che torna al suo paese dopo essere uscito di galera, sembrava al tempo stesso preoccupato come se dopo tutti quegli anni trovasse il paese molto diverso da come si era immaginato in carcere. Mostrò la statua. “Guarda” disse, “La vedi? Quella è la statua dello stemma del Samsunspor.” Guardai con interesse, poi aggiunse mormorando; “E di molte altre cose a Samsun”. Poi mi fece sedere alla locanda di fronte al parco in cui si trovava la statua. Ci sfamammo con una zuppa, poi qualcuno chiamò mio padre. Mentre aspettavamo che quel qualcuno ci venisse a prendere bevemmo un tè.
A prenderci venne un uomo giovane, di otto anni più grande di me. Con un’auto dai vetri oscurati ci accompagnò in un grande hotel nelle vicinanze, ci fece accomodare. L’hotel era in riva al mare. Nei confronti di mio madre mostrava molto rispetto, molta sollecitudine. Adulato in quel modo, sul volto di mio padre, sul suo sorriso che sembrava essere lì da anni, calò una gioia sempre più intensa da quando aveva ricevuto la notizia. “Voi sistematevi, spogliatevi, accomodatevi, riposatevi fino a sera. Verso le sei vengo a prendervi per portarvi alla partita”, e dicendo così l’uomo che ci aveva accolti se ne andò. Significava che quella sera alla partita mio padre avrebbe incontrato i vecchi compagni di squadra, dirigenti vecchi e nuovi, tifosi che solo oggi avrebbero saputo del contributo che un tempo aveva dato alla società. Essendo rimasto la notte insonne io non resistetti ulteriormente all’aria umida e pesante di Samsun. Vedendo i comodi letti dell’hotel di lusso la cui sola ragione d’esistenza è viziare le persone, decisi di dormire qualche ora. Mio padre non si teneva dall’emozione. Era forse la prima volta che vedevo mio padre emozionato. “Io esco a fare un giro” mi disse mentre stavo per addormentarmi. Non lo sentii uscire.
Quando mi svegliai era tornato, andando su e giù per la stanza cercava di vestirsi. “Sei sveglio?” disse vedendo che mi muovevo. Aveva indossato un completo dal taglio stretto color grigio scuro. Era un bel completo, capii che l’aveva comprato apposta per quel giorno. “Che ore sono?” chiesi dal letto. Con una tranquillità sul volto che sembrava cantare, con una mano teneva la cravatta, con l’altra faceva il nodo. Dalle strisce diagonali bianche e rosse, la stoffa lucida, si capiva che era una cravatta costosa. “Quasi le cinque” disse. Mi sollevai. Non potevo lasciare mio padre da solo in preda a quella gioia e frenesia. Mi alzai dal letto e mi vestii. A un’ora dall’appuntamento con l’uomo che doveva venirci a prendere eravamo già pronti e vestiti, aspettando seduti nella reception. Mio padre, dalla grotta dove aveva riposato per tutti quegli anni, quel giorno si era ricostruito da zero. Aveva persino la gelatina sui capelli, aveva pensato anche alla spilletta del Samsunspor da appuntare al collo, ovunque l’avesse trovata. Era impaziente. Si chinava a prendere una di quelle riviste di moda e società sul tavolinetto davanti che probabilmente le persone leggono soltanto quando sono in attesa di qualcosa, e dopo averle stropicciate grossolanamente le rimetteva al loro posto. Di quando in quando si scuoteva le spalle, le gambe, le ginocchia del completo, non stava nella pelle. Sorrisi dentro di me pensando che dovevano aver fatto a mio padre un’iniezione di eccitazione, impazienza, gioia e stupore. Vedere i padri tornare bambini ha un’aria così calorosa, così malinconica. Perché padre e figlio sono come le due ampolle di una clessidra; arrivati a un certo punto il tempo, il destino, Dio, o qualunque altra cosa sia, gira la clessidra. Quella calda tristezza che riempie il figlio quando vede il padre diventare bambino è forse il flusso tiepido della sabbia che scende verso il basso.
Siamo rimasti seduti nella reception per un’ora e venti minuti. Lo so perché ogni due o tre minuti mio padre ricordava l’ora. Appena abbiamo visto il nostro accompagnatore nella porta girevole dell’hotel ci siamo alzati. La pazienza di mio padre e la mia sopportazione stavano per esaurirsi. La nostra pomposa auto dai vetri oscurati ci aspettava davanti all’hotel. Abbiamo fatto sedere comodamente mio padre nel sedile posteriore a destra. Io, per non far fare l’autista al povero uomo che ci accompagnava, mi sono seduto davanti. La strada fino allo stadio è durata venti minuti.
Il nostro accompagnatore ci ha presentato i dirigenti della squadra che aspettavano davanti alla tribuna d’onore. Operazione lunga e macchinosa. Tra alcuni vecchi giocatori famosi, altri uomini di mezza età con cui aveva giocato, dirigenti, la visita agli spogliatoi per i complimenti a giocatori e allenatori, i tifosi, ci è voluta mezz’ora perché raggiungessimo i posti a noi riservati. Dopo aver ricordato tanti uomini, tanti momenti, tanti morti ci siamo seduti nella tribuna d’onore in seconda fila. Appena seduti un ragazzo in papillon ci ha persino chiesto se avevamo bisogno di qualcosa. Abbiamo chiesto dell’acqua. Per mio padre che durante lunghi anni aveva considerato il mondo inesistente, la folla fu un po’ troppo. Se si aggiunge l’emozione e la gioia trasalii quasi davanti al suo volto impallidito. Fortuna che arrivò l’acqua, svuotata come se avesse mangiato sottaceti fino a quel momento ne chiese un’altra. Sembrava calmato. Dopo aver osservato lentamente da un capo all’altro la folla che riempiva lo stadio pieno a scoppiare si voltò verso di me: “Sai, è la prima volta che guardo una partita dalla tribuna d’onore” disse. Fu come prendere un pugno in faccia. A volte capitano certe cose, si sentono certe parole che uno non sa come trattenere le lacrime e deve trovare un gesto di riserva. Che so, si deve chinare a scuotere le zampe dei pantaloni, girare la testa da qualche altra parte e far finta di interessarsi a un certo schiamazzo, strizzare gli occhi e guardare il cielo come se stesse cercando di capire se sta per piovere eccetera. Io non seppi cosa fare. Strinsi il bracciolo della sedia, trattenni a forza le lacrime, non le ho lasciate, ho risolto così. Ma era come se mi avessero spinto dentro un ferro arroventato. E chi se ne frega della tribuna d’onore, chi se ne frega di guardare una partita da tal posto, tifare per una squadra dal palchetto bestemmiando debolmente contro i terzini d’ala con un sigaro in mano! Sembrava che invece di “Sai, è la prima volta che guardo una partita dalla tribuna d’onore” avesse detto “Mia madre non mi comprava mai dei giocattoli, lo sai? Scolpivo il legno, impastavo la mota, giocavo con quelli anche se non somigliavano a niente”. Capendo che se avessi parlato avrei pianto, mi sono messo a ridere, ho cercato di sdrammatizzare, “E va bene papà, guarda, ti pare che non fosse per te, io l’avrei vista?” Si è sentito lusingato. L’onore di guardare la partita da lì era stato accordato a lui, è vero, e soprattutto quell’onore se lo era guadagnato col sudore per la maglia della squadra. Felicità, emozione, onore e stupore erano visibili nei comportamenti di mio padre come i grafici altalenanti dei risultati elettorali. Tutto questo ringiovaniva mio padre ad ogni minuto che passava, lo infantilizzava piuttosto. Come tutto era normale, come tutto era strano. Mio padre era come i semi che dopo essere rimasti per anni sotto terra germogliano una volta trovati il clima, la luce, l’acqua giusta. Pare che avesse aspettato proprio quel giorno. Aveva passato tutto quel tempo dentro la lampada, in una posizione che facesse dimenticare il suo insuccesso, per rinfrescare quella scintillante fotografia che portavamo nella mente e adesso la sua vecchia società, strofinando la lampada, aveva fatto uscire mio padre come neanche io avevo mai conosciuto. Significava che aveva atteso con ostinazione come avesse saputo che quel giorno sarebbe arrivato. Conosceva tutti i cannonieri del Samsun, chi veniva da dove, chi era stato allenato internamente, il punteggio della squadra, la differenza reti, la dirigenza, sapeva tutto. Ma la cosa stupefacente è che quando si parlava della squadra avversaria la sua conoscenza era quasi a zero. Per anni quell’uomo, senza mai perdere la fiducia, aveva osservato il Samsunspor da lontano. Forse era sicuro che quel giorno sarebbe arrivato.
Prima che la partita iniziasse il presidente della società venne da noi. Lui e mio padre si strinsero di nuovo la mano, parlarono un poco. Dopo la partita ci sarebbe stata una cena, gli stava dicendo il presidente. E l’indomani sarebbero state consegnate le targhe durante la cerimonia della squadra, verso sera ci sarebbe stata la partita tra i vecchi e i nuovi giocatori. Poi, poco prima che la partita iniziasse il presidente andò al suo posto, nella fila davanti alla nostra. I tifosi erano magnifici, il baccano divertente. A parte le partite che avevo visto a Kadıköy, allo stadio Inönü e Ali Sami Yen, trascinato dagli amici avevo visto qualche partita dell’Ankaragücü e della Gençlerbirliği a Ankara. Il calcio per me significava vedere le partite con mio padre, perciò da anni non era riuscito a interessarmi più di tanto. Il boato infuocato e talvolta ingiurioso dei tifosi, l’eccitazione data dalle luci artificiali che colpivano il verde dell’erba, la gioia di sentirsi parte di qualcosa, dopo tutto quel tempo mi faceva bene. E mio padre era con me. E soprattutto il Samsun non era affatto male. Attacco dopo attacco, tiro dopo tiro sembrava stesse per succedere qualcosa. Ma anche l’avversario era aggressivo. Era una squadra forte, venivano da una città abituata all’umidità, persino più calda. Alla fine, dopo neppure la prima mezz’ora gli avversari mostrarono i denti al Samsun, passarono in vantaggio uno a zero. Guardai mio padre senza batter ciglio, si era intristito. Accorgendosi che lo guardavo, “Fa niente, questa partita la vinciamo noi”, disse. Fu come se tutto lo stadio avesse sentito che con quel “noi” mio padre si riferiva a quella squadra anatolica dove aveva giocato solo per pochi mesi, sfortunata e senza futuro quanto lui, e scoppiò in un’ovazione ritmata e fragorosa. Sono sicuro che se non fosse stato seduto nella tribuna d’onore, con il presidente davanti, il prefetto, il direttore e così tante persone considerevoli, si sarebbe alzato a gridare anche lui.
Si era vicini alla fine del primo tempo. Il Samsun non era riuscito a rovesciare la partita. Mio padre con la bocca chiusa stretta si mordeva le guance da dentro. Doveva farlo nei momenti di emozione o preoccupazione, non glielo avevo mai visto fare prima. Di lui non conoscevo altro che l’espressione che aveva risolvendo parole crociate. Mentre noi aspettavano dalla squadra sul campo prima un neutro pareggio, poi il gol della vittoria che avrebbe trasformato lo stadio in un campo di festa, davanti alla panchina avversaria scoppiò un tumulto. Con quelle grida che si potevano udire persino nel brusio dello stadio ci alzammo tutti in piedi. Uno degli uomini si era avvicinato al direttore tecnico della squadra avversaria e lì infilzava e strappava, infilzava e strappava via il coltello che teneva in mano. Allora qualcuno intervenne, presero l’uomo, tennero il direttore tecnico, l’arbitro fischiò, la partita si interruppe. Nello stadio si levò un mormorio di curiosità che a vederlo dall’alto somigliava a un gran punto di domanda. Portarono via l’uomo con il coltello, i giocatori presero l’allenatore in mezzo a un lago di sangue e lo fecero sdraiare sull’ambulanza in attesa. Poi giunse la notizia, la partita era stata sospesa. Restammo lì.
Anche la tribuna d’onore si alzò in piedi davanti al fracasso sul campo. Solo io e mio padre rimanemmo seduti dove eravamo. Non sapevamo cosa fare. Il presidente, il prefetto, il capo della polizia e gli altri uomini importanti se ne erano andati in fretta e furia. Per un po’ restammo a guardare con una faccia stranita la gradinata che si svuotava. Dopo un po’, quando anche la tribuna d’onore cominciò a sfoltirsi, ci venne in mente di alzarci in piedi. Mio padre, con una faccia congelata, restava fermo dov’era. Mentre ci indirizzavamo verso l’uscita incontrammo l’uomo che ci aveva accompagnato, “Pare che l’allenatore avesse dei dissidi in famiglia”, disse, “Era un parente, è entrato nello stadio e l’ha accoltellato”. Chiesi quello che mio padre moriva dalla voglia di sapere: “Ora cosa succederà?” L’uomo con una preoccupazione spontanea rispose: “Adesso vi accompagno in hotel, quando la squadra ci dirà qualcosa vi terrò informati. Prego, andiamo in macchina.” Lo seguimmo. Non parlavamo. Vedendo che restavamo in silenzio anche l’uomo smise di parlare. Proprio davanti alla macchina uno degli uomini che mi ricordavo aver visto poco prima seduto nella tribuna d’onore accanto al presidente ci venne incontro di corsa. Avvicinandosi: “Ah mi dispiace, anche voi così” disse interrompendosi. Come l’uomo ci fu vicino mio padre si voltò d’improvviso e cominciò a camminare verso l’autobus della squadra parcheggiato poco più avanti. Si fermò a fianco dell’autobus con le spalle verso di noi. Io e gli altri due uomini lo osservavamo stupiti. L’uomo che ci aveva raggiunti ricominciò a correre “Scusateci”, disse “Davvero spiacevole. Non sappiamo bene cosa sia successo. Il capo della polizia e il prefetto ci hanno chiesto di annullare la cerimonia e la partita di domani. Prego, scusateci, i nostri uomini vi saranno di aiuto, siete nostri ospiti.” Fare da padre a mio padre toccò a me. Ringraziai l’uomo stringendogli la mano, mi mostrai maturo dicendo che possono esserci cause di forza maggiore eccetera, poi lo congedai. Mi avvicinai a mio padre. Aveva puntato incomprensibilmente gli occhi sui finestrini dell’autobus, un autobus vuoto, e come se stesse cercando di incrociare lo sguardo di qualcuno guardava verso un punto fisso. Quando gli fui accanto, senza distogliere lo sguardo disse piano: “Portami via di qui”. Ma la voce era soffocata. Sentii come il freddo di un coltello infilato nella carne. “Vieni” dissi prendendolo sottobraccio. Non so perché ma avevo paura che cadesse. Lo portai in macchina e lo feci sedere sul sedile posteriore destro.
Viaggiamo in silenzio per un tratto. Mi accorsi che eravamo vicini al punto in cui eravamo scesi venendo dall’aeroporto il mattino. Quando vidi la prefettura poco più avanti capii che eravamo arrivati nell’unico luogo della città che conoscessi. Mio padre mi chiamò da dietro. Con la mano indicava il mare. “Guarda, vedi lì?” disse. Facendo un semicerchio all’indietro con la testa mi voltai verso il mare. Mostrava un lungomare liscio, vuoto, insignificante. Un inutile vuoto di cemento dove sarebbe potuto atterrare un aereo, infilato a forza tra il mare e la strada. La voce mio padre continuò alle mie spalle:
“Ecco, il Mercato Russo era qui.”
Trad. G. Ansaldo
Stopper è un racconto di Mahir Ünsal Eriş pubblicato con il titolo Stoper nella raccolta Olduğu kadar güzeldik (Per quanto possibile eravamo belli) pubblicata da Iletişim Yayınları nel 2013.
Diritti riservati per la traduzione italiana, ©Kaleydoskop, 2018 (su concessione dell’autore)
 MAHIR ÜNSAL ERIŞ è nato nel 1980 a Çanakkale. Laureato in archeologia lavora come
MAHIR ÜNSAL ERIŞ è nato nel 1980 a Çanakkale. Laureato in archeologia lavora come  traduttore e scrittore per diverse riviste e case editrici. Membro per qualche tempo del collettivo Afili Filintalar ha pubblicato tra il 2012 e il 2017 cinque raccolte di racconti, l’ultima, Öbürküler, è stata illustrata dal disegnatore M.K. Perker. La raccolta da cui è tratto il racconto qui presentato è il suo secondo libro, insignito nel 2014 del sessantesimo premio per il racconto dedicato a Sait Faik. Tifa il per il Gençlerbirlik.
traduttore e scrittore per diverse riviste e case editrici. Membro per qualche tempo del collettivo Afili Filintalar ha pubblicato tra il 2012 e il 2017 cinque raccolte di racconti, l’ultima, Öbürküler, è stata illustrata dal disegnatore M.K. Perker. La raccolta da cui è tratto il racconto qui presentato è il suo secondo libro, insignito nel 2014 del sessantesimo premio per il racconto dedicato a Sait Faik. Tifa il per il Gençlerbirlik.
Illustrazione di copertina di ©Hayalcan Deniz Güner per Kaleydoskop