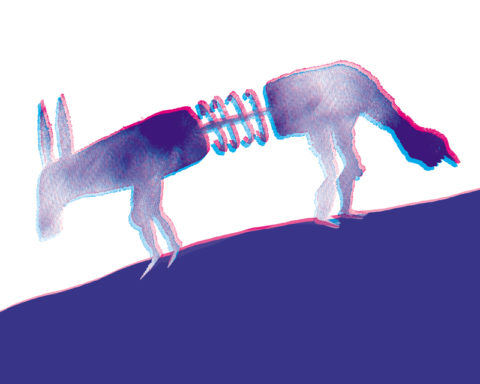Un racconto di Mıgırdiç Margosyan
Quel mattino a Diyarbakır era l’inizio di un giorno nefasto. Non potevo saperlo. Per me era soltanto un giorno come gli altri, all’inizio. Una qualsiasi giornata autunnale.
Avevo appena aperto gli occhi, appena iniziato a spulciarmi le narici. Mentre con l’indice scavavo dentro il naso, dall’angolo in cui stavo disteso contavo i pilastri di casa nostra: «uno, due, tre, quattro, cinque…».
Finito di contare in turco, cominciavo a farlo in armeno: «meg, yergu, yerek, çors, hink, vetz…»
Quei pochi pilastri, stanchi e scheletrici, reggevano l’intero peso di casa nostra, del nostro tetto. Non so il perché, ma offrire un sostegno con le mie spalle, non aiutare quei pilastri ossuti che sopportavano tutto il peso del nostro tetto di tufo, e restarmene sdraiato sul letto come uno spettatore, mi faceva sempre sentire in colpa.
Non so nemmeno come e perché avessi perso la fiducia nei nostri pilastri, logorati dagli anni, scrostati qua e là, rovinati, poveri, miseri, sconfitti dalle cimici nella lotta per la vita, stanchi, esausti, sfiniti. Avevo paura. Dentro di me, questa paura sembrava essersi trasformata via via in mancanza di rispetto. E loro, come se comprendessero i miei pensieri, i miei sentimenti, mi schernivano con sguardi rabbiosi, rugosi, torvi.
Disteso sul mio letto, prolungavo quella serenità mattutina. E contavo anche in curdo: «yek, dü, se, çar, penç, şeş…».
“Car”, il quarto pilastro, mi provocava sempre ansia e paura. Era il più gobbo e invecchiato. Forse era lui a sentire più di tutti il peso della cisterna sul tetto, e ansimava. Soprattutto nelle fredde notti d’inverno, quando uno spesso manto di neve ricopriva il tetto, lo sentivo rimanere senza fiato, e mi angustiavo molto per lui.
Anche se in curdo “car” mi fa pensare alla parola armena che significa “cura, rimedio universale”, non era il caso di “Car”, che rimaneva comunque un buon pilastro.
Penç e şeş, cioè il quinto e il sesto, erano gemelli. Erano i fratelli maggiori. Due metà. Uno si chiamava Penç e l’altro Şeş, venivano da quello tagliato in due, per il lungo.
Se tu stessi costruendo casa tua e al momento di creare il tetto ti accorgessi che manca una colonna, coi soldi quasi finiti, ti siederesti in un angolo a piangere? Oppure rideresti? Mettiamo che rideresti, ma cosa farebbe il resto del mondo? Scoppierebbe in una risata? O si rattristerebbe, dicendo: «Oh, poveraccio, non è nemmeno riuscito a costruirsi un tetto, gli mancava un pilastro!»
«un pilastro in meno e gli è rimasto il tetto aperto»
«Poveri loro!»
«Avete sentito? La casa di Sıke è rimasta con il tetto a metà»
In quel caso la soluzione migliore, la più rapida, è dividere un pilastro in due, chiamarli penç e ses e chiudere il tetto, senza stare a disperarsi tanto.
In realtà, il quinto e il sesto dei nostri pilastri erano più giovani e forti degli altri, ma io ne avevo ugualmente paura. Perché la cisterna era molto pesante. Non avevo mai visto un recipiente più pesante del nostro. Forse neanche la macina del mugnaio Uso il curdo era così pesante… e il peggio è che stava sempre sul tetto, con tutto il suo peso. Lo sapevo, perdurava una guerra interminabile tra i pilastri e la vasca. Sentivo che alla fine sarebbe stata lei ad averla vinta, la nostra vasca dal cuore di pietra…
Ero sicuro, avrei potuto giurare che un giorno, anzi no, una notte, precisamente una notte d’inverno, non appena la neve avesse ricoperto il nostro tetto, e colmato il recipiente, proprio in quel momento i nostri pilastri sarebbero crollati e la vasca mi sarebbe finita sulla testa, sicuramente sulla mia testa.
Mi arrabbiavo, la odiavo, quella cisterna. E più mi arrabbiavo con la cisterna, più mi angosciavo per i pilastri. Mi addoloravo per mia madre, per mio padre, per i miei fratelli e anche per il gatto Mestan. Quei nostri pilastri, perché erano così esili, rosi, crepati, strappati, fragili? Perché? Eravamo dunque dei poveri?
E perché eravamo poveri? Perché, nonostante mio padre non facesse altro che lavorare, eravamo comunque poveri? Sì, sì, noi non avevamo così tanti quattrini. Se sei ricco, la tua casa e i pilastri del tetto sono numerosi, solidi e robusti. Mica finisce subito così «dü, se, çar, penç, şeş…», vai avanti: «heft, heşt, neh, deh…» e poi undici, dodici, tredici…finché riesci a contare… E allora non ti spaventi della cisterna, ma è lei che si spaventa di te, lei che si cerca un angolino per nascondersi… Nelle case dei ricchi non ci sono buchi sui muri, né mattoni di fango. Ma perché i nostri muri erano così smangiucchiati? In quei buchi si rintanavano gli scorpioni. Che hanno pungiglioni aguzzi, con un loro morso ti si gonfia la pancia e muori stecchito.
Anche i figli dei ricchi muoiono? Sì, muoiono anche loro, ma più tardi.
Quelli che pregano non muoiono presto, vivono a lungo, a loro Dio dà loro quello che desiderano, tutto ciò che chiedono.
Avevo sei anni. Mi ero svegliato presto. E non avevo niente da fare. Perciò parlavo con Dio:
«Dio padre, caccia via quella cisterna da casa nostra!»
«Dio, di’ a quei pilastri di non spezzarsi!»
«Dio, non lasciare che le bisce entrino a casa!»
«Dio, tieni gli scorpioni lontani da qui!»
«Dacci del pane!»
«Dacci l’uva, l’uvetta passa, il pestil, e anche le noci!»
I miei ordini non finivano mai. Più pregavo, più desideravo, e il mio appetito aumentava. Era la prima volta che mi trovavo così in contatto con Dio, così a tu per tu. Questa forza mi avrebbe portato dove volevo, mi avrebbe procurato ciò che desideravo.
«Dacci le more secche! Le uova!»
«Dacci il latte! E anche il miele! Zucchero, mandorle!»
«Vorrei anche del cocomero!»
«E poi vorrei una trottola!»
I miei desideri erano al completo; non appena stavo per rimetterli in ordine, la mia sorellina si svegliò piangendo. La sua voce arrivò fino al letto di mia madre, che si diresse verso la lanterna a gas, o più precisamente alla piccola lampada d’emergenza appesa al chiodo sulla parete, e le diede un po’ più di stoppino. La luce ridisegnava l’amaca di tela sospesa tra le due pareti. Sull’amaca mia sorella piangeva. Mia madre la prese in braccio, si sedette sul letto, si scoprì i seni e con la forza ne ficcò uno in bocca a mia sorella, che si zittì. In quel baccano si interruppe anche la mia conversazione con Dio.
Nella stanza eravamo in tre: io, mia madre e mio fratello. Mio padre non c’era. Alcune volte all’anno mio padre andava nei paesi e nei villaggi vicini a Diyarbakır, lavorava là. Estraeva i denti agli abitanti dei paesini oppure li metteva finti o d’oro. A quelli dei villaggi, soprattutto ai giovanotti e alle ragazze, piaceva tanto farsi fare un incisivo dorato. Chiedevano in curdo, a mio padre, di mettere l’oro sui denti, “zer” dicevano: «Draneme zer çeke».
In realtà mio padre non era un dentista o un odontoiatra. Non era mai andato a scuola. Aveva fatto qualche anno di apprendistato al fianco del dottore Mahmut il dentista, poi era diventato il suo assistente e più avanti si era conferito il diploma, lui stesso. Esercitava la sua professione di villaggio in villaggio. Si chiamava Ali il dentista. Il suo vero nome era Sarkis, non sapevo perché i paesani lo chiamassero Mastro Ali o Ali il dentista. Allora avevo sei anni. Niente mi portava a preoccuparmi del nome di mio padre, c’erano questioni più importanti: tra queste, non avere neanche un osso per giocare ad aliossi.
Pensavo a trovare una forcola e un elastico per farmi una fionda e andare a caccia di uccelli. Certo, era un po’ strano chiedere qualsiasi cosa a Dio!
Mi rattristavo ogni volta che mio padre andava ai villaggi, e aspettavo impaziente che tornasse. Perché sapevo che ad ogni suo ritorno mi avrebbe portato pestil, noci, uvetta passa e azzeruoli.
Sì, aspettavo trepidante il suo ritorno. Scendendo dal cavallo davanti alla nostra porta, dicendo “hoppalà” mi avrebbe abbracciato e baciato, e poi mi avrebbe messo in sella. Io avrei sentito la paura di cadere dal cavallo, senza però darlo a vedere, mi sarei tenuto agli arcioni e poi per farlo andare più veloce, avrei colpito con le gambe la sua pancia dorata:
«Ço, ço, deh mirat, ço».
Il cavallo avrebbe preso il passo, e io mi sarei esibito davanti ai miei amici nel nostro “kuçe”, nella nostra viuzza. E loro mi avrebbero ammirato. Mi avrebbero implorato, desiderosi di montare su. Ma io non avrei fatto salire il figlio del nostro vicino Pilo, Vanes, che mi aveva rotto la trottola.
Mentre mi cullavo nella fantasia, mia madre aveva riempito la pancia di mia sorella. La rimise sull’amaca, perché dormisse. Per farla dormire presto, tirò il cordino che la dondolava da destra a sinistra, e intonò la sua ninna nanna senza pause, interminabile:
«E, e, e, e»
«Ey, ey, ey, ey».
Questa cantilena monotona diede sui nervi a Mestan, il gatto di casa. Si scostò dalla stufa ormai spenta, si guardò intorno, cercò con lo sguardo un posto più calmo, meno chiassoso, sbadigliò, si stirò come un arco sulle zampe anteriori e posteriori, con tutto il corpo, allungò un po’ il collo, poi camminò verso il divano e si accucciò tra i cuscini imbottiti, ad occhi chiusi.
«E, e, e, e»
«Ey, ey, ey, ey».
Agli “ey, ey” di mia madre si sovrappose all’improvviso la voce del nostro dirimpettaio Tumas: «Signora, signora!»
Zio Tumas strillava dal suo cortile.
«Signora, ehi, signora!»
Nel buio pesto del mattino, mia madre non capì che Tumas si stava sgolando per chiamare lei. Ma smise comunque con i suoi “ey ey” e corse fuori dalla porta, agitata. Il frinire di mia sorella infastidì Mestan. Si stiracchiò, si alzò, con le zampe si fece la toelettatura mattutina, si pettinò, si mise a posto i baffi, per ripicca miagolò tre volte a mia sorella, quindi andò a riempirsi la pancia. Mestan uscì dalla porta e mia madre entrò, fu un tutt’uno, credo che si sia anche preso qualche calcio. Io, ancora disteso là, con le mani sulla pancia nuda, continuavo il mio gioco, e contavo i pilastri, sempre iniziando dalla stessa parte: «Uno, due, tre…»
Che cosa stava succedendo fuori? Perché zio Tumas se ne stava fermo a urlare? Per quale motivo mia madre era così agitata, ansiosa, spaventata, affannata? Non sembrava minimamente preoccuparsi per me. Ma sarebbe stato impossibile da parte sua. Afferrò mia sorella, e colpendomi con i piedi mi urlò: «Alzati, alzati, sta crollando il tetto».
Non fui in grado di comprendere le parole di mia madre, sul momento. Ma non aveva certamente né il modo né il tempo di soffermarsi a spiegarmele. Era in preda alla fretta, all’agitazione e alla paura. Vedendo che indugiavo ad alzarmi, mi afferrò il braccio e mi trascinò in cortile. Fuori, nell’ombra dell’alba, riuscii a riconoscere zio Tumas, sua moglie Estiğik, Dikran e sua moglie Bayzar, gli altri vicini. Ma dunque cos’era tutta quella concitazione, tutto quel baccano? Perché Estedur e sua moglie Verto, Keya e Meryem, l’orafo Haço e la signora Verjin, uno dopo l’altro si erano radunati nel nostro cortile? Perché in quel mattino d’autunno piovevano così tante imprecazioni? Per chi?
Mia sorella era passata in braccio alla signora Eğso. Io guardavo il tetto sulla nostra unica stanza, con gli occhi svuotati, la mano stretta a quella di zia Verjin. E se all’inizio avevo osservato imbambolato, ormai avevo capito che la causa di quel tumulto era il tetto di casa nostra sul punto di crollare. Anche mia madre l’aveva detto. Non era qualcosa da prendere alla leggera. Il tetto stava sprofondando; mi tornava alla mente tutto ciò che sul mio letto avevo immaginato e temuto. Però ero molto felice, perché ero in cortile e quel maledetto recipiente, ormai, non mi sarebbe caduto in testa.
Casa nostra, il nostro tetto, avrebbero ceduto, avvertiva zio Tumas, mastro muratore con anni di esperienza.
«Io che ho sentito aprirsi la crepa, sono schizzato fuori, ho capito che il tetto sarebbe caduto, non c’era nessun’altra possibilità. Nessuna soluzione».
Poi si inclinò verso l’orecchio di Dikro e sussurrò: «Guarda Dikro, sta venendo fuori il cartongesso». Zio Tumas, con le sue grosse dita, indicava a Dikro un pilastro di cartongesso. Questo stava per sbucare fuori dal nostro muro di fango. Io non lo conoscevo nemmeno, quel povero pilastro. Da ciò che riuscivo a capire dei commenti di Tumas, questo pilastro aveva sostenuto un peso eccessivo rispetto agli altri, che l’avevano tradito.
Mia madre entrò e uscì rapida un paio di volte, nel tentennamento della frana. Un’entrata le servì per portare fuori il letto. Un’altra volta uscì con il vassoio di rame, la pentola e il catino. Intanto, zio Dikro e l’orafo Haço caricarono fuori la cassapanca in legno di noce che aveva costruito mia madre.
Tutta la ricchezza di casa nostra era custodita in quel baule di noce. Mia madre aveva nascosto l’enorme chiave. In realtà l’aveva nascosta perché rubacchiavo i dolciumi riservati agli ospiti. Io andavo matto per quelle caramelle che arrivavano da Istanbul, con l’incarto variopinto, proibite, messe da parte per gli ospiti.
Tumas bloccò mia madre con le sue mani e le vietò un’ultima incursione in casa, per salvare, nell’ordine, cuscini, tappeto e lanterna:
«No, no, signora mia, non entrare, il tetto inizia a crollare!»
Mia madre non aveva altra scelta che dare ascolto a Tumas.
In quella dannata mattina di autunno, sotto la pioggerellina furono sconfitti i pilastri, e il cartongesso, incapaci di sostenere il peso del recipiente di pietra. Non accadde in un attimo, con un boato: il nostro tetto sprofondò pian pianino. Dapprima il cartongesso sbucò fuori dalle pareti di fango, poi Yek e Se, dopo Car e Penç, e alla fine Dü insieme a Şeş vennero giù scricchiolando.
Sul cortile la pioggia si mescolava alla polvere e al fumo.
Dio onnipotente di Diyarbakır aggiungeva all’abbondanza della pioggia la polvere, la terra, la paglia di casa nostra, cosparse sulle nostre teste.
Mia madre piangeva lacrime di disperazione, che scendevano come pioggia. Le vicine cercavano di consolarla: «Grazie al cielo vi siete salvati».
Io mi liberai dalla mano della signora Verjin e corsi ad aggrapparmi alla gonna a balze di mia madre, la abbracciai, ma non riuscii a piangere.
Chiacchierando coi pilastri e spulciandomi le narici nel mio lettuccio, sconfinando con la mia fantasia, tanto da chiedere a Dio di mantenere forti i pilastri, come e perché avrei potuto sapere, quella mattina d’autunno,che il Dio della chiesa di San Ciriaco, della croce che reggeva la statua del profeta Gesù, coi rilievi d’argento, della Bibbia dall’enorme copertina nera, avrebbe realizzato l’esatto contrario di ogni mia richiesta, di ogni mio desiderio, e in più, avrebbe lasciato che il diavolo arrivasse nella nostra cisterna, animasse quel maledetto cartongesso e ci facesse piovere addosso la polvere e il fumo di casa nostra? Altro che mandorle, dolci e caramelle…
Mia madre piangeva. L’unica salvezza era mio papà, in giro per villaggi a guadagnarsi la pagnotta. I passi della Bibbia che padre Arsen recitava ogni domenica: «Fai del bene e ne riceverai»; «Iddio aiuta sempre i poveri»; «Beati gli uomini che sono poveri a questo mondo, saranno i primi a godere della gioia eterna» erano del nostro profeta, Gesù, che però non si era mai fatto vivo.
Quel giorno, di fronte al disastro del tetto, la vasca di pietra con un ghigno sembrava beffarsi di me, sentivo il suo peso spaventoso sulle mie spalle gracili, ossute, da bimbo. Sì, ero io a trascinare il suo peso, come una pena, con tutte le mie forze. Come per anni e anni avevano sopportato il peso del nostro misero tetto quei poveri e innocenti pilastri, Meg e Yergu, Tre e Quattro, Penç e Şeş…
Traduzione dal turco di Fabrizia Vazzana
Immagine di copertina tratta da una leggenda del libralogo “Preghiere di vetro – Fantasie di cristallo” scritto da Mauro Neri e illustrato da Luigi Ballarin



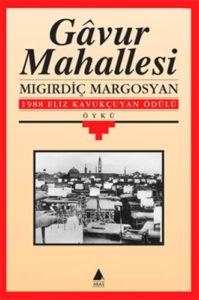 Lo scrittore armeno
Lo scrittore armeno