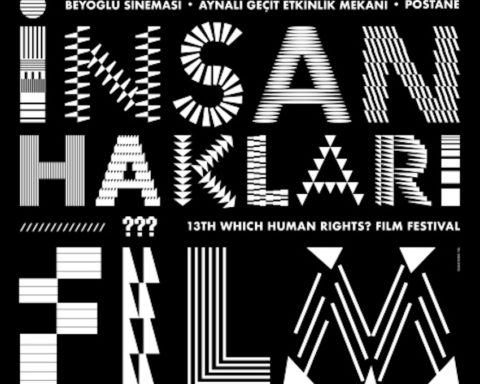Il cinema curdo è uno spazio narrativo transnazionale che in assenza di uno stato che regola e sovvenziona l’industria cinematografica, deve tentare di ricavarsi uno spazio tra Turchia, Iraq, Iran e Siria, oppure seguire la strada della diaspora curda, che conta 2 milioni di emigrati in Europa o ancora appoggiarsi a produzioni internazionali. I festival del cinema curdo assumono, in questo contesto, un ruolo fondamentale per la promozione di un cinema indipendente che ha difficoltà maggiori di quelle già grandi che lo stesso settore incontra negli altri paesi. A Lisbona sta nascendo uno di questi importanti momenti in cui il cinema curdo può mostrarsi anche all’estero: dal 23 al 25 marzo 2018 si svolgerà il primo Kurdish film & arts festival Lisboa.
 Nella capitale portoghese, in occasione della presentazione del festival, abbiamo avuto l’occasione di vedere il film La canzone perduta (Annemin Şarkısı/Klama Dayîka Min, 103′) e di intervistare l’autore, Erol Mintaş. Vincitore di diversi premi internazionali, tra cui il Sarajevo Film Festival 2014, il film inizia con un antefatto: un insegnante racconta a dei bambini di un villaggio curdo una storia, ma una macchina bianca arriva davanti alla scuola e alcuni uomini prendono il maestro e lo portano via con la forza. Sono gli anni ‘90 e questo modello di macchina, la Renault Beyaz Toros, è famosa perché utilizzata dai commandos responsabili della persecuzione dei dissidenti politici in quegli anni di conflitto. Poi un balzo temporale ci porta nella Istanbul di oggi, che mostra i risultati della gentrificazione; qui sono messe a confronto le diverse generazioni di immigrati curdi provenienti dall’est della Turchia, una madre ospite a casa di un uomo che vive una vita precaria, diviso tra il lavoro di insegnante, la passione per la scrittura e la fidanzata anch’essa curda ma che a causa delle politiche di assimilazione parla solo turco.
Nella capitale portoghese, in occasione della presentazione del festival, abbiamo avuto l’occasione di vedere il film La canzone perduta (Annemin Şarkısı/Klama Dayîka Min, 103′) e di intervistare l’autore, Erol Mintaş. Vincitore di diversi premi internazionali, tra cui il Sarajevo Film Festival 2014, il film inizia con un antefatto: un insegnante racconta a dei bambini di un villaggio curdo una storia, ma una macchina bianca arriva davanti alla scuola e alcuni uomini prendono il maestro e lo portano via con la forza. Sono gli anni ‘90 e questo modello di macchina, la Renault Beyaz Toros, è famosa perché utilizzata dai commandos responsabili della persecuzione dei dissidenti politici in quegli anni di conflitto. Poi un balzo temporale ci porta nella Istanbul di oggi, che mostra i risultati della gentrificazione; qui sono messe a confronto le diverse generazioni di immigrati curdi provenienti dall’est della Turchia, una madre ospite a casa di un uomo che vive una vita precaria, diviso tra il lavoro di insegnante, la passione per la scrittura e la fidanzata anch’essa curda ma che a causa delle politiche di assimilazione parla solo turco.
 Erol, ci racconta un po’ della sua storia come regista curdo?
Erol, ci racconta un po’ della sua storia come regista curdo?
Sono nato in un piccolo villaggio e parlavo solo curdo finché non ho iniziato la scuola: è stato allora che ho scoperto che vivevo in un luogo in cui c’era un’altra lingua e un altro popolo, ma allo stesso tempo ho dovuto fare i conti con il fatto che il mio maestro e le persone intorno a me non volevano che io parlassi curdo. All’inizio ero confuso, ma poi ho iniziato un percorso molto individuale per scoprire me stesso, poi la mia cultura e la mia storia, visto che su di essa avevo sentito solo delle storie orali. Il percorso è proseguito alla scuola superiore, insieme ai miei compagni, ed è stato in questo periodo che ho scoperto anche il cinema.
La prima cosa è identificare se stessi, solo dopo di ciò si può iniziare a condividere diversi tipi di storie. Questo è il motivo per cui i film curdi sono basati su questo confine dell’identità tra le parti geografiche e tra di noi. Come regista, sento anche il bisogno di raccontare molti dei traumi che noi abbiamo avuto nel passato, è come se fosse necessario raccontarli per lasciarli andare via; solo dopo si può iniziare a raccontare diversi tipi di storie, senza mai smettere di raccontare storie individuali perché è importante farlo.
Una cosa interessante di Annemin Şarkısı è che, raccontando la storia personale di un uomo curdo a Istanbul che vive con sua madre a ha una ragazza, riesce a raggiungere una dimensione collettiva e allo stesso tempo politica…
Penso che una storia personale possa essere in ogni caso una storia politica. Il film è basato sulle mie osservazioni sulla migrazione dei curdi dall’est verso Istanbul dopo la guerra degli anni ’90 e sulla loro integrazione in città, in special modo per quanto riguarda la terza generazione di migranti. La madre rappresenta la prima generazione che è venuta e non ha potuto a integrarsi né linguisticamente, né culturalmente. Invece le generazioni che sono venute dopo, come quella del personaggio principale del film, Ali, vi hanno costruito una vita e considerano se stessi di Istanbul. Anch’io posso considerarmi di seconda generazione e mi considero di Istanbul: non riesco a immaginare di vivere una città diversa in Turchia. In questa città sento che riesco a respirare, è dove ho scoperto me stesso. E se si riuscissero a trovare le giuste maniere e a costruire degli approcci giusti per l’integrazione della terza generazione, si potrebbe creare tutta un’altra Istanbul.
Ci sono infatti due questioni per i curdi, una per quelli che vivono nelle grandi città e l’altra per quelli che vivono nelle città curde. Io mi sento più in grado di dire qualcosa riguardo ai curdi che vivono a Istanbul, ma secondo me dovrebbe essere anche ascoltata la voce delle persone che vivono nelle città che hanno un’identità curda. Per arrivare a una soluzione è necessario l’ascolto di tutte e due le parti, di tutte e due le componenti.
 Il film inizia con il fratello del protagonista che insegna in curdo in una piccola scuola di villaggio e racconta, mimandola, una storia sugli uccelli; poi passa ad Ali, insegnante a Istanbul e lo mostra mentre la stessa storia la fa semplicemente leggere agli studenti in turco. Il rapporto tra il turco e il curdo è tematizzato molto bene nel film, e vengono utilizzate entrambe le lingue. Perché questa scelta?
Il film inizia con il fratello del protagonista che insegna in curdo in una piccola scuola di villaggio e racconta, mimandola, una storia sugli uccelli; poi passa ad Ali, insegnante a Istanbul e lo mostra mentre la stessa storia la fa semplicemente leggere agli studenti in turco. Il rapporto tra il turco e il curdo è tematizzato molto bene nel film, e vengono utilizzate entrambe le lingue. Perché questa scelta?
Perché anche nella mia quotidianità utilizzo entrambe le lingue. La storia degli uccelli può essere letta in molti modi dagli spettatori. Si tratta di una semplicissima storia senza significato politico: raccontata in curdo, può portare all’arresto e all’uccisione dell’insegnante; raccontata in turco nelle scuole, rimane solo un racconto per bambini.
 La madre di Ali arrivata a Istanbul si era stabilita nel quartiere di Tarlabaşı, ma a causa della ristrutturazione urbana che ha portato molte demolizioni in quel quartiere, si deve trasferire a casa del figlio, che vive in periferia. Il film ci mostra la vita di questa donna anziana che non si integra mai realmente nel nuovo quartiere; nelle ore di solitudine trascorse in casa ascolta in uno stereo cassette di musica dengbej, uno stile tradizionale di musica curda, si ricorda di un cantante ma Ali lo cerca su tutte le bancarelle di cassette della città senza mai riuscire a trovarlo…
La madre di Ali arrivata a Istanbul si era stabilita nel quartiere di Tarlabaşı, ma a causa della ristrutturazione urbana che ha portato molte demolizioni in quel quartiere, si deve trasferire a casa del figlio, che vive in periferia. Il film ci mostra la vita di questa donna anziana che non si integra mai realmente nel nuovo quartiere; nelle ore di solitudine trascorse in casa ascolta in uno stereo cassette di musica dengbej, uno stile tradizionale di musica curda, si ricorda di un cantante ma Ali lo cerca su tutte le bancarelle di cassette della città senza mai riuscire a trovarlo…
Il ruolo del dengbej nella storia curda è molto importante, perché si tratta di una storia raccontata oralmente anche con l’aiuto di queste canzoni. Scrivendo il personaggio della madre, ho pensato che l’unica cosa che le rimaneva era il dengbej; l’autore che lei cercava non esisteva, ma rappresentava l’unico suo rapporto con la vita. Riesco a spiegarlo usando un termine dello scrittore Yusuf Atılgan, “tutamak”, difficile da tradurre ma che significa “avere qualcosa in mano per continuare a vivere”. Non è solo la nostalgia del villaggio ma una cosa un po’ metaforica: “tutamak” è qualcosa che teniamo in mano, ma allo stesso tempo ci sostiene, su cui ci si appoggia per continuare a vivere. I canti dengbej vengono cantati soprattutto durante le cerimonie, nei funerali o matrimoni e nella cultura curda hanno più significato di un qualsiasi tipo di musica. Hanno altrettanta importanza per me. Quando ero bambino, negli anni ’90, prima di leggere dei racconti o altre cose scritte, ho capito la mia identità curda tramite le canzoni di Şiwan Perwer e Ciwan Haco, cantautori che appartengono alla musica curda più moderna rispetto al dengbej che ha una sua storia un po’ più vecchia, che però continua e vive ancora.
 In che modo il dengbej vive ancora, e qual è la sua attualità?
In che modo il dengbej vive ancora, e qual è la sua attualità?
La particolarità del dengbej è che funziona come uno storytelling. Al passo che, negli ultimi trent’anni, la popolazione curda si è politicizzata, tutti i racconti sono cambiati e si sono evoluti. Quelli che prima erano racconti d’amore, in cui un uomo paragona la donna a un tipo di uccello o a un fiore, adesso vengono contestualizzati in senso politico. Lo stesso accade ai racconti sulla morte. Purtroppo nella cultura curda manca l’idea di archiviare le cose e il mio intento non è tanto quello di celebrare la bellezza del dengbej ma piuttosto quello di far notare che non c’è nessun archivio; ci sono racconti che risalgono al 1700, e il dengbej è diffuso non solo in Turchia ma anche in Iran, in Iraq, e tutti gli altri posti in cui ci sono i curdi, ma si è cominciato a registrare tardi e non esiste alcuna raccolta sistematica.
Qual è lo stato attuale del cinema indipendente curdo?
Dopo il 2005 il governo turco ha iniziato a creare dei fondi del ministero della cultura per supportare il cinema; in quel periodo inoltre c’è stata una negoziazione tra il movimento politico curdo e il governo turco per dare inizio a un processo di pace. Il mio ultimo film difatti è stato supportato dal governo ma lo scorso anno, quando la guerra è iniziata di nuovo nelle città curde, gli accademici hanno fatto una petizione per mettere fine alla guerra, con il risultato che migliaia di essi sono stati licenziati e noi abbiamo fatto una petizione per supportarli. Da allora le cose hanno iniziato a cambiare; una lista di film-maker è stata bloccata e sono stati tagliati i fondi per coloro che hanno firmato questa petizione. Questo è successo non solo per i curdi ma anche per quei registi turchi che erano, come noi, contro la guerra.
E quali sono le prospettive?
Le difficoltà sono aumentate, ma penso che oggi con le tecnologie si possano fare dei film forti a basso costo, anche solo con i telefonini, e bisogna pensare a storie intelligenti con budget non più di 200 mila ma di 5 mila euro. Se questo conflitto durerà a lungo penso che dovremo concentrarci a fare film di grande qualità, ma con un basso costo di produzione.
Negli anni ‘90 soprattutto le persone pensavano alla rivoluzione, molti sono andati sulle montagne a combattere ma all’inizio degli anni 2000, abbiamo iniziato a discutere, molti di noi hanno pensato di dover rimanere e creare valori culturali per poter realizzare prima di tutto una rivoluzione culturale. Come possiamo farla? Con la letteratura, con il cinema, con la musica e dobbiamo essere connessi con il cinema di tutto il mondo. Perciò è importante che i nostri film vadano nei più grandi festival d’Europa e che incuriosiscano le persone sul cinema curdo, le invoglino a seguirlo di più e a supportarlo.
(Luca Onesti)