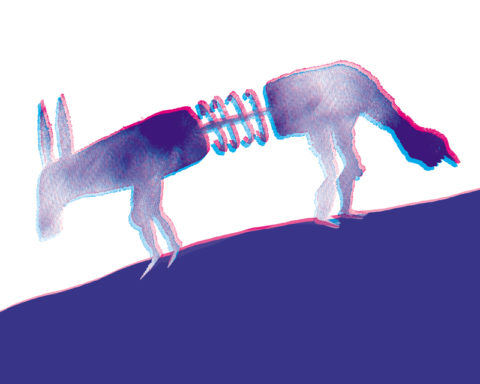Gli uomini del postale di Izmir, un racconto di Ahmet Büke
Il vecchio noce aveva appoggiato lo stanco braccio che si era biforcato dal tronco almeno venti anni prima sui mattoni della stazione proprio di fronte, e attendeva di perdere le sue ultime foglie. Si era affacciato alla soglia dell’inverno. Al mattino non lo raggiungevano altri che corvi irriverenti e gruppi di topi spaventati. I pochi frutti bacati che gli erano rimasti dondolavano nei lori malli striminziti, sul punto di cadere da un momento all’altro.
Il tronco colore henné, quel vecchio torso contro cui le persone che stavano in attesa, che partivano, i viaggiatori dai fazzoletti sporchi poggiavano una mano e riposavano la schiena, alla cui base spengevano le sigarette, si distendeva nello spazio senza conoscere fine. L’acqua sottile che filtrava nella vasca ricoperta d’alghe dalla fontana ricurva poco più avanti, per anni aveva fatto esplodere incontrollato il noce. Si era espanso strato su strato, si era scrollato, ad ogni primavera aveva fatto scricchiolare sempre più la veste che gli andava stretta e adesso si era trasformato in un’ombra che dominava uno spazio di quasi mille metri.
Ma la robustezza cela i difetti. Con il suo odore che stordiva le persone, le foglie venate di verde lasciavano apparire ulteriormente la sua magnificenza sin da lontano. Indurite le gambe ricoperte di eczemi, con le dita ingiallite aveva lasciato la sua cenere ai venti appena comparsi e aspettava. Sia. Che differenza può fare? Chi mai avrebbe saputo, chi si sarebbe accorto di quel suo stato? Tanto scompariva in mezzo alla gigantesca nuvola di preoccupazioni che lo avvolgeva.
Quella tabella ad esempio… “Stazione dei treni di Akhisar”. La scritta stanca dei chiodi subito sopra la porta d’ingresso dalla tinta scrostata, con il grigio volato via. Oppure il vaso di bocche di leone fiorito la scorsa primavera nella moschea del capostazione ma che adesso raccoglieva sul fusto secco gomitoli di polvere e ai cui piedi si accumulano biglietti strappati. All’interno i sedili d’attesa scuriti. Il pavimento corroso sotto i sedili. Al muro i manifesti della protezione civile che mostravano i colori di avvertimento degli attacchi aerei. Di fianco a quelli, le tabelle delle tariffe segnate con inchiostro blu. La cornice dello sportello dei biglietti, lucidata a forza di essere usata come appoggio. Il sogno mormorante del gatto tigrato appollaiato sul bidone della spazzatura capovolto sotto la cornice. I suoni dei passi dei viaggiatori che odoravano di paese. Il gigantesco orologio da muro di fabbricazione russa fregiato con una locomotiva su cui sbattevano i suoni. I tic tac dell’orologio che andavano di continuo all’indietro.
E poi? Cosa non c’era stato, vigilie passate, feste, ciarloni che scendevano e salivano milioni di volte, sopraggiunti inverni, trascorsi geli, caldi che facevano crepare le mensole, addirittura anni prima, il gorgoglio di sangue dello stomaco squarciato di Cerci Reşat.
Ecco, in mezzo a tutte queste dimenticanze rovesciate così in un batter d’occhio, chi mai poteva far caso al vecchio noce? Mettiamo ci fosse qualcuno. Non sarebbe comunque finita qui. Per mettersi a scrivere queste cose serve uno scrittore sfaccendato che però in questa stazione non si trova. Non passa di qua neanche per cercare un rimedio.
Ad ogni modo, questi discorsi non sono caramelline note ai mortali. Perché nella vita ci sono due cose in cui non ci si deve immischiare. Dio e le Ferrovie dello Stato. E soprattutto le vite fallite e i treni in ritardo sono come due metà di una mela.
Sì, è proprio così. Se non ci credete, guardate la panchina che si trova subito all’angolo del dipinto a olio invecchiato con la cornice rotta, cioè nel punto del noce più lontano dalla stazione.
Dicono che dopo quarant’anni marito e moglie si somiglino, dopo tante conversazioni diventano specchio e servente l’uno dell’altra. Non fate caso al fatto che stanno seduti dandosi le spalle. Non sono offesi, è per la troppa attesa.
Il nome di quello avvolto nell’impermeabile sporco, con un berretto della marca Hayati sulle ginocchia, è Fethi. Dicevano che fosse un ereditiere ma di fatto era una bugia. Forse era perché non aveva mai lavorato in vita sua, chissà.
Se chiedete della vecchia villa di cui occupava la grande stanza sotto al tetto affittando per tre lire gli altri due piani a insegnanti celibi e sottufficiali dell’aviazione, quest’uomo benestante non si scomponeva. Quando si trasferirono nell’edificio di legno su cui suo padre, direttore del catasto, aveva fatto scrivere “preso” da un sellaio Rum che aveva abbandonato la casa quando era stato costretto ad andarsene con le deportazioni, c’erano state tribolazioni nei dintorni per mesi. Ma non molto dopo, ciò che aveva detto sua madre dai capelli tinti di henné risultò vero e quello che sopraggiunse con i sospiri di disperazione non fece ridere neanche loro. Quando fu un anno che il padre era morto, aveva sepolto la madre da due giorni.
Rimase solo nella grande casa. Quando i tre soldi rimasti da suo padre scarseggiarono, cominciò a lavorare come secondo scrivano in un grande oleificio. Si stufò presto. Più tardi rilevò un chiosco di giornali in uno spazio grande quanto un pugno nel mercato coperto. Essendogli difficile svegliarsi presto al mattino, cominciò a sistemare sulle mensole vuote antidolorifici Gripin, infusi di timo, mazzi essiccati di artemisia, ottima per il mal di stomaco, e a seconda della stagione vecchie bottiglie di spirito piene di sanguisughe.
Poi si appassionò di profumeria. Cedette il negozio per uno sgangherato baule di profumi al cui interno si agitavano essenze di ogni tipo, incorniciato da legno annerito, dotato di uno specchio sporco, che entrava persino sotto la poltrona. Girava per mercati, andava nei paesi, invitava clienti facendo “Pss pss” nei mercatini davanti alle moschee.
Terminati i profumi doveva andare al mercato di Kemeraltı di Izmir per fare rifornimento. Doveva, ma gli venne più facile abbandonare anche questo lavoro.
Quando la passione per farlo sposare delle vecchie vicine di casa che non badavano né a tanta svogliataggine né al rivestimento di legno logoro della villa fu al culmine, venne a soccorrerlo la cartolina di leva. Partì per il militare ridendo e scherzando Fethi. Si era liberato delle ristrettezze, di scoppiare come un petardo alle feste in quel posto grande quanto un pugno.
E per fortuna partì per il militare. Per fortuna che fu assegnato alla vecchia caserma di cavalleria che si affacciava sulla punta estrema del Golfo di Saros. Perché là, incontrò l’uomo che sarebbe stato la sua metà per il resto della sua vita. Laz Osman. Parlo di quell’uomo che adesso è seduto proprio accanto al lui, con gli occhi infossati di tre strati, e i baffi per metà bianchi. Fethi aveva incontrato Laz il giorno in cui entrò nella sartoria della compagnia per far cucire sull’uniforme da libera uscita le spalline rosse da caporale ottenute per merito della sua bella calligrafia.
Per prima fece un profondo inchino. Peraltro aveva molti pochi soldi in tasca. Aveva pensato che prendendola alla larga e facendo un po’ di cordiale conversazione avrebbe potuto ottenere il lavoro a gratis. Ad ogni modo quel giorno sarebbe sceso fino a Gelibolu, sarebbe entrato nell’hammam Hâkimefendi e si sarebbe fatto sgrumare per bene. Cioè la preoccupazione di quel giorno era di spendere i soldi per il massaggio prima di uscire dalla caserma.
Ma Fethi quel giorno non uscì affatto. Fino a sera rimase a sedere nella minuscola sartoria della compagnia, sotto il sorriso appeso alla bocca storta di Laz Osman. Quest’uomo non parlava quasi. Batteva il pedale dalla macchina per cucire di continuo, abbassando di tanto in tanto sul posacenere le sigarette che accendeva una dietro l’altra, continuando a cucire a tutta velocità tende strappate, sacchi del pane scuciti, divise verdi di soldati e non so quanti colletti del sottufficiale della compagnia.
L’indomani Fethi tornò. Su un fornellino a gas prepararono un cono di caffè sottratto dalla stanza dell’ufficiale. Dopo l’adunata della sera scavalcarono il filo spinato e si sedettero sulla terra marrone del campo sconfinato di girasoli.
In refettorio, in dormitorio dove si erano trasferiti fianco a fianco, nelle taverne clandestine simili a cave, in cui scendevano nei giorni di permesso senza farsi notare, Fethi parlava a catinelle e Laz Osman sorrideva di continuo.
Il silenzio dell’uno completava l’inarrestabile prolissità dell’altro come la notte si mescola al giorno. Sembrava fossero diventati una sola persona.
C’è dell’altro. La gola di Fethi che le sue tasche bucate non riuscivano a soddisfare, grazie a Laz si ringalluzzì. Il talento è ovunque una miniera d’oro. Tra scuciture militari e orli dell’ufficiale, con le monete che gli entravano in tasca se la passavano come rose tutti e due. Insomma, divisero a metà la merenda di helva strizzando lo stesso limone.
Il giorno che presero congedo salirono con i loro bauli di legno sullo stesso autobus. Diretti a Akhisar.
Laz si sistemò in una stanza della vecchia villa. Con i soldi ricavati dalla vendita delle pompose bardature che il sellaio greco non era riuscito a vendere e che per anni erano rimaste a impolverarsi in cantina, comprarono una macchina per cucire di seconda mano. Osman era un sarto egregio ma la sua taciturnità sempre più profonda arrivò quasi al mutismo. Per fortuna la loquacità di Fethi bastava a intrattenere i clienti.
Il tempo che scorreva come acqua quieta trascorse molto bene a dire il vero finché nelle loro vite non entrò Feriye.
Feriye era una bella donna che viveva con il marito nella casa a un solo piano adiacente al muro del giardino della villa. Quando stendeva i panni sui fili tesi tra gli alberi di susino era sempre con la testa scoperta. Pettinava i folti capelli biondi ondulati che faceva scendere dalla nuca al petto.
Quando trovarono il corpo bianco di Cerci Reşat davanti alla stazione, Feriye era incinta di due mesi. Picchiò la testa contro le pietre. Le caddero le ciglia dal piangere. Dopo una settimana abortì. Non si trovò l’assassino del poveretto. Non aveva nemici. A dire il vero nessuno seppe chi fosse il nemico.
Quando qualche mese dopo Laz Osman prese Feriye mezza impazzita con due o tre cose e la portò nella villa, tutti si tranquillizzarono. In fondo aveva sposato una vedova rimasta da sola. Eh, Laz non poteva considerarsi bello, per di più era parecchio in su con l’età, e il suo silenzio eccessivo. Ma aveva salvato una donna dalla fame e dalla solitudine. E forse la mente mezza sconvolta della donna sarebbe tornata a funzionare in un letto caldo.
Ma quest’aria da “ben fatto” che era scesa sul quartiere non colpì affatto Fethi. Prima notò le forbici luccicanti che stavano sul banco di legno annerito della sartoria. Si stranì per quel nuovo acciaio all’ultima moda, con gli anelli per le dita ondulati, che non facevano venire i calli sulle mani. La luce della sera che colpiva negozio si rifletteva sul soffitto dalla superficie d’acciaio delle forbici, grossa come un cece.
Fethi si sentì scoppiare. Eppure non riuscì a dare un senso a ciò che gli passava per la mente. Mise tutto sotto sopra. Svuotò i cassetti. Rovesciò la spazzatura piena di ritagli di stoffa, arruffò dappertutto. Ma non riuscì a trovare le vecchie forbici che accompagnavano la penna dietro l’orecchio di Laz Osman e il suo imperturbabile sorriso.
Eppure Laz più volte aveva guardato con aria piagnucolosa quell’attrezzo di fabbricazione di Bursa che a causa del bullone allentato si apriva nei punti più voluminosi della stoffa; e Fethi era andato di corsa dal ferramenta.
Quando calò la sera, giunse alla porta di Osman. Il verde del volto doveva notarsi anche al buio, che appena Laz aprì la porta, abbassò il capo. Poi indossò il lungo cappotto e uscì sulla soglia. Camminarono fino alla stazione nel silenzio della notte. Superato il noce si accasciarono nel punto in cui sono seduti adesso.
Senza aprir bocca Fethi scoppiò a piangere. A furia di tirare su col naso frinì fino a bagnarsi di lacrime il colletto. Laz sciolse i nodi al fazzoletto tirato fuori dalla tasca e mise le vecchie forbici tra di loro, poi cominciò il più lungo, più disperato discorso che avesse mai fatto.
L’inizio e la fine di ogni cosa era Feriye. Raccontò dei loro sguardi sul muro che li separava di notte, delle lacrime che versavano quando verso mattino tornavano ai loro letti freddi. La donna l’aveva implorato con gli occhi ogni notte. Mentre Laz si avvolgeva sotto strati e strati di coperte con la testa sotto il cuscino, Feriye era venuta e l’aveva spogliato.
“Guarda un po’ qui” gli aveva detto. “Guardami e esci dal pozzo”. Come se non bastasse, gli era entrata nei sogni. Qualunque porta aprisse, qualunque porta chiudesse, in qualunque angolo si nascondesse, le appariva davanti. Era molle fino alle ginocchia. Gli era entrata dentro come una scheggia facendo fuoriuscire il pus.
Il mattino che seguiva le notti semi addormentate trascorse in folli corse, era stata Feriye a fargli sollevare le palpebre. Aveva svegliato Laz con l’odore di latte nel petto.
Come se tutto questo non bastasse, con il suo aspetto dismesso Feriye, soprattutto di giorno, si era sdraiata davanti alle forbici di Laz, era saltata fuori dal ditale, diventata il magnete porta aghi. Quando aveva aperto il metro la voce di Feriye si era allungata sui centimetri neri: “Prendimi. Salvami da me.”
Alla fine la mente ondeggiante di Osman si era saldata e lì era rimasta facendosi tutta nera. Tutte le vie d’uscita erano terminate in un bullone cieco.
Fethi quella notte gettò nel buio di un vagone del treno che trasportava carbone di Soma le vecchie forbici ormai consumate.
Si alzarono, tornarono indietro fianco a fianco.
La settimana successiva Feriye scomparve. Le donne del quartiere dissero: “Non ha resistito alla morte di Reşat. Sarà andata a buttarsi in un pozzo a Şarlak.” Ma io lo so, è montata sull’ultimo vagone del posatale di Izmir. L’ho giurato a Fethi. Anche se era notte non li riconosco forse quei suoi capelli biondi?
Dopo questa dipartita Laz Osman svuotò il negozio. Si lasciò i baffi con una punta bianca. Ogni pomeriggio veniva a guardare la stazione e quelli che scendevano dal treno. Poi anche Fethi si abituò a quella attesa. Per anni sono invecchiati sotto il noce come statue.
Anche questa sera sono lì. Ma non li potrete vedere, tra un po’ se ne andranno. Ai loro fianchi due vecchie borse, in pugno due biglietti di seconda classe. Attendono il postale di Izmir. Manca poco. Sentono l’ultima campana. Tra poco il treno sarà qui.
Laz spererà di trovare Feriye e Fethi si farà travolgere dalla brezza di quel vento.
Io chiuderò lo sportello. Conterò i soldi dei biglietti e li chiuderò nell’armadietto di ferro. Voi senza sapere niente di questi fatti tornerete a casa, al vostro focolare. Ma le loro vite che proseguono senza toccarci, scorreranno tra le luci sgargianti del postale di Izmir, e gli uccelli notturni.
Il vecchio noce si stenderà. Vedrà sin da adesso il sogno di domani.
1 febbraio 2004
Traduzione di G. Ansaldo

Gli uomini del postale di Izmir è un racconto di Ahmet Büke pubblicato nella raccolta omonima edita nel 2004 dalla casa editrice Kanat Kitap, e poi riedita insieme alle altre sue altre raccolte da Can, nel 2010. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020, su concessione dell’autore.
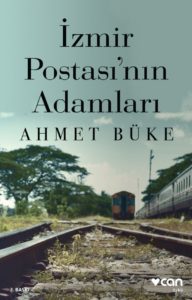 Ahmet Büke (1970-) con sette raccolte di racconti all’attivo e diversi libri per l’infanzia è uno dei maggiori narratori contemporanei. Nato a Manisa, ha studiato a Izmir e Ankara per laurearsi poi in Economia e Amministrazione a Izmir. I suoi racconti sono stati pubblicati in numerosissime riviste letterarie prima di pubblicare nel 2004 ‘Gli uomini del postale di Izmir’, la sua prima raccolta.
Ahmet Büke (1970-) con sette raccolte di racconti all’attivo e diversi libri per l’infanzia è uno dei maggiori narratori contemporanei. Nato a Manisa, ha studiato a Izmir e Ankara per laurearsi poi in Economia e Amministrazione a Izmir. I suoi racconti sono stati pubblicati in numerosissime riviste letterarie prima di pubblicare nel 2004 ‘Gli uomini del postale di Izmir’, la sua prima raccolta.
Illustrazione di copertina di Francesco Testa, in arte ©Leteste.