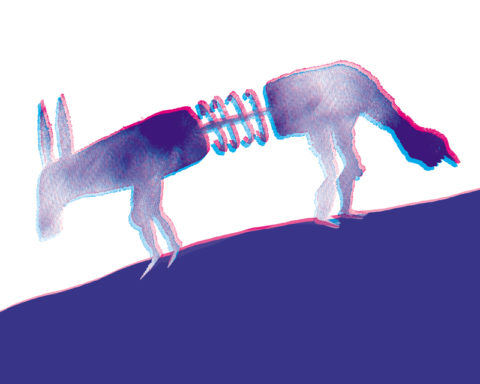Un racconto di Isahag Uygar Eskiciyan
La cosa strana della faccenda è che tutti in questa storia trovarono qualcosa in cui credere ma Mahmut era deciso a non credere. Perché a urlare con rabbia, appena sveglio, “Dov’è il mio piano?” era stato lui in persona. E il suo nome era soltanto una pretesa. Una questione dubbia… Finché non si capirà la verità, lo chiameremo Mahmut.
La sua voce risuonò in paese dai rami acerbi ai rami secchi, dai muri di fango ai muri di mattoni, dai forni alle stalle. E dovette pensare che non fu sufficiente, che gridò di nuovo. Questa volta la sua voce si sparse da stato a stato, da paese a paese, da cimitero a cimitero, da pascolo a pascolo. Quella mattina in tutti i paesi di quello stato lontano, le persone fecero fatica a credere che quella voce non venisse dall’al di là. La domanda che avevano in testa invece era “Quale piano e dov’è?”. Suo padre, ovvero Ahmet Bey, aveva tirato giù dal muro il suo saz a corde. Non fate caso a che lo chiami Ahmet Bey, il titolo di ‘bey’, signore, dopo il nome, non l’ha mai sentito in vita sua. Al contrario, in paese era uno dei quelli considerati da ssempre spregevoli. Secondo l’algoritmo del disprezzo i primi a disprezzare quel paese erano, nell’ordine, quelli del palazzo, i cittadini, e poi coloro che abitavano vicino a un corso d’acqua; una volta esaurito lo sguardo esterno, veniva il turno dei paesani di sminuirsi a vicenda. E Ahmet Bey non era stato mai visto passare da un’attitudine passiva a una attiva. Tuttavia, a causa dell’affetto mostrato ai suoi figli, il favore nei confronti degli animali, e la deferenza provata per sua moglie, il titolo di bey gliel’ho attribuito io, e per la durata di questo racconto.
Ahmet Bey allungò a suo figlio il saz che aveva staccato dal muro. Mahmut afferrò il saz a sette corde per il manico e lo frantumò contro il muro. Questa volta lo disse pacatamente: “Dov’è il mio piano, chi è lei, dove siamo qui?”
Ahmet Bey si voltò a guardare sua moglie Döne la quale non fece tardare la sua abituale risposta: “Li hai viziati tu questi ragazzi. Gliene avessi data ogni tanto qualcuna sulle orecchie, non sarebbero così viziati.” Mahmut sillabando la sua domanda rincarò. “Che strana lingua è questa, quando l’ho imparata?”
Si avvicinò alla finestra. Scostò la tenda coi tulipani disegnati. Stupito di fronte al giallo della sconfinata steppa disse: “E allora, dov’è Eyfel? dov’è Parigi?”. E svenne. Sia lodato che prima di sbattere a terra Ahmet Bey accorse a sostenergli la testa. Gli allungò un cuscino. “Döne”, disse, “qualcuno l’ha colpito alla testa questo ragazzo?”. Sistemandosi il foulard sulla testa Döne si contentò di rispondere “Li hai viziati tu questi ragazzi!” e includendo all’interno del cerchio disegnato con la mano anche gli altri due bambini, Kürşat e Keziban, che osservavano spaventati gli avvenimenti, aggiunse “Gliene avessi date ogni tanto sulle orecchie, a suo tempo…”
Kürşat e Keziban si guardarono l’un l’altra trasalendo. Dopo che la madre fu uscita Kürşat chiese a sua sorella, “Cos’è successo a nostro fratello?” Keziban era silenziosa. Per quanto Ahmet Bey dicesse non è niente, passerà quando si sveglia, non andò così. Mahmut questa volta si svegliò gridando. “Dov’è il mio piano? Dov’è Eyfel? Dov’è Parigi? Dov’è il mio francese? Dov’è la mia robe de chambre? Perché siete vestiti così? Mi avete rapito per riscatto?” Fece le domande in rapida successione, poi lasciando un po’ di vuoto, le ripeté. Cercò di calmarsi. Ahmet Bey guardando suo figlio negli occhi gli chiese “Mahmut, figlio mio, cosa ti è successo?” Mahmut si guardò intorno senza lasciarsi sfuggire di mano il suo contegno. “Chi è Mahmut? Il mio nome è Arthur! Arthur!” Allungò un po’ l’ultima sillaba. Kürşat si voltò verso suo padre. “Mio fratello è diventato infedele papà!” disse spaventato. Keziban cominciò a piangere. Ahmet Bey non aveva più la forza di consolarli. Li abbracciò entrambi con affetto.
Döne entrò con un vassoio in mano. Lo posò di scatto lì nel mezzo. Mahmut, o forse dovremmo dire Arthur, aveva fame. Anche se un po’ schifato, la sua era una delle cinque mani che inzuppavano il pane nelle uova di anatra del tegame. Se gli ci volle solo un momento per imparare a infilare i cipollotti freschi in mezzo al pane cotto nel forno di pietra, lo doveva alla fame, la migliore delle maestre. Il suo commento, o meglio, il suo rimprovero non tardò. “Senza caviale, niente ha sapore.” Questa fu l’ultima frase che pronunciò in turco. Dopo essersi sfamato cominciò a parlare in francese, e i suoi interlocutori ormai non lo capivano più.
Per un po’, finché non inghiottirono il boccone che stavano masticando, rimasero ad ascoltare Mahmut che parlava in francese. Kürşat cominciò a singhiozzare dicendo “Mio fratello è diventato infedele”. Il pianto si interruppe d’un tratto come se gli fosse venuto a mente qualcosa di importante. “Ora posso picchiarlo, mia madre non si metterà di certo a prendere le parti di un infedele!” Si rallegrò.
Ahmet Bey schizzò via dalla tavola. Pregò il vicino Ramazan di accompagnarli in città, all’ospedale. Ramazan si preparò in fretta e furia dicendo “Cos’è successo, cos’è successo amico mio?” Ahmet Bey prese in braccio Mahmut e lo fece salire sull’auto. Ramazan ingranò. Le strilla in francese di Mahmut riempivano l’auto, nessuno capì una parola. Ramazan attendeva una delucidazione da Ahmet Bey il quale non sprecò altre parole che “Non so come spiegarlo”. E Ramazan non infierì. Mahmut si dimenò per tutto il viaggio. Né si poteva spiegare, né gli altri potevano capirlo.
Entrarono in ospedale dalla porta del pronto soccorso. Il medico, per quanto avesse chiesto a Ahmet Bey “Cos’ha?”, non ottenne risposta e cercò di mandarlo via prescrivendogli un antibiotico e un antidolorifico. L’infermiera aveva abbassato i pantaloni a Mahmut già sulla porta e faceva l’ultima prova, prima di infilargli la siringa nel sedere. Le grida di Mahmut avevano lo stesso significato in tutte le lingue del mondo: Aiuto! Ramazan intervenne. Raccontò che quando Mahmut si era svegliato non era più il vecchio Mahmut, si era ritrovato a essere un’altra persona. Il dottore faticò a comprendere, quando la questione era estremamente semplice. L’infermiera questa volta cercava di bucare il braccio di Mahmut per inserirgli la flebo. Ramazan la fermò di nuovo.
Il dottore si avvicinò un po’ a Mahmut. Era stranito del fatto che il bambino che aveva di fronte parlasse un francese perfetto. “Cioè il suo nome sarebbe Mahmut?” chiese di getto. “Vuol dire che si è addormentato da stinco di Sivas e si è risvegliato parigino?” Ad Ahmet Bey non era rimasta la forza per rispondere a quelle domande. Dicendo che la situazione era al di là delle sue conoscenze, il medico li consegnò in psichiatria. Non molto tempo dopo li accolsero nel policlinico psichiatrico. Compresa l’urgenza, li fecero entrare subito. Ramazan teneva stretta la mano di Mahmut per evitare che scappasse. Le lacrime negli occhi di Mahmut scorrevano come la Senna. “La dottoressa parla molto bene il francese, lo capirà”, disse qualcuno del personale per consolare Ahmet Bey.
La dottoressa, forse per deformazione professionale, dopo averli accolti con saluti esagerati, scomparve dietro al computer non appena si mise a sedere. Se non avesse sentito le grida in francese di Mahmut, la situazione si sarebbe prolungata in quella maniera. Sì, aveva gli occhiali e abbassandoli sul naso, si mise a osservare Mahmut. Cominciò a parlare in francese. Da quanto si capiva, lo chiamava Arthur. Ahmet Bey era perplesso ma speranzoso per il tono di voce rallegrato di Mahmut. E anche Ramazan provava sensazioni simili. Per un po’ tesero l’orecchio al dialogo. Poi la dottoressa chiese loro di lasciare la stanza. “Voglio parlare da sola con Monsier Arthur”, disse. Pervaso da sentimenti nazionalisti Ramazan protestò “Mahmut, non Arthur” ma neanche lui trovava qualcosa a cui credere in quella storia. Mentre usciva dalla stanza puntò gli occhi su Mahmut. Non riusciva a credere agli sguardi di Mahmut che aveva visto giocare nel fango il mattino precedente. “Questo non può essere lui”. disse. Non aveva la forza di ripetere.
Il suono delle sirene rimbombò per i corridoi grigi dell’ospedale. D’altronde coloro che erano affetti da malattie erano sbiancati ben bene con tutto quell’andirivieni. Uomini grossi e ben vestiti si pararono davanti a Ahmet Bey accompagnati dalla polizia. “È lei Ahmet Öztürk?” Ahmet Bey fece segno di sì con la testa e immediatamente fu ammanettato dietro la schiena. E anche Ramazan ebbe la sua parte. “Siete in arresto per la ritenzione di Arthur Malet.” In un batter d’occhio li portarono alla stazione di polizia. Dopo un po’ li misero a confronto con Mahmut. Arthur parlava in francese, la psichiatra fatta venire dall’ospedale per fare da interprete, traduceva in turco. La donna ogni tre per due guardava sul telefono il dizionario di francese, e ad ogni volta, esprimeva il suo stupore dicendo “Ma questo francese ormai non si parla più nemmeno a Parigi!”
“Non mi ricordo il momento del rapimento,” diceva Arthur. “Quando ho aperto gli occhi ero a casa di questo tipo.” Il dito indicava Ahmet Bey. E per quanto Ahmet Bey dicesse, io sono suo padre, ma quale rapimento, non riuscì a convincere nessuno. Lo guardavano come un alienato. Ramazan, quasi sul punto di perdere la testa, aprì la bocca per pronunciare un paio di frasi. “Commissario, ne sono testimone, questo bambino è il figlio di Ahmet, e il suo nome è Mahmut.” Il grosso commissario di polizia si piazzò davanti a Ramazan. “Da lì questo bambino ti sembra Mahmut, eh? Ma non fateci ammattire!” gridò. “Il bambino si è fissato con il Bordeaux, fosse stato Mahmut avrebbe chiesto una lattina di Coca!” Ramazan vide che non c’era nulla da fare, cambiò atteggiamento. “Ha ragione commissario, vuol dire che hanno ingannato anche a me tutti questi anni. Io li ho soltanto accompagnati in ospedale.” Quando Arthur confermò la cosa, Ramazan si rilassò un poco.
Con l’arrivo in elicottero degli incaricati del consolato la situazione si fece ancora più seria. Arthur gridava agitando il dito davanti agli uomini che avanzavano parlando in francese. La dottoressa disse: “Da quel che ho potuto capire, li minaccia di esilio, e per di più nelle provincie più recondite.” Ramazan sussultò di scatto. “Questa minaccia solo un turco può farla.” Nessuno fece caso alle sue parole. Gli incaricati del consolato non seppero nascondere lo stupore davanti a Arthur. “Parla in un impeccabile francese del diciassettesimo secolo.” disse uno di loro. Gli altri concordarono. La dottoressa si intromise. “Lo avevo detto io, questo francese non si parla più nemmeno a Parigi.”
Arthur raccontò della sua famiglia. Ma gli incaricati per quanto conoscessero bene l’ambiente descritto da Arthur, non seppero individuare la tenuta Malet. È un bambino, ecco, può stare inventando, disse quello più alto. Ne parleremo in dettaglio andando sul posto in elicottero, aggiunse. Davanti all’elicottero Arthur rimase a bocca aperta dallo sbigottimento. Lo osservò attentamente. Chiese se volava. E la dottoressa afferrando la mano di Arthur, prese posto. Durante il viaggio Arthur parlò della sua famiglia, componente dell’alta società parigina, e gran parte del viaggio trascorse con Arthur che enumerava le proprietà della famiglia.
Di fronte all’elicottero che atterrava nel cortile della casa, Kürşat fu preso dal terrore. “Mamma, gli infedeli hanno preso in ostaggio mio fratello, papà e lo zio Ramazan,” gridò. Döne da un lato cercava di tenersi il foulard che s’involava per l’elicottero, dall’altra si lamentava “Che gli si spezzi il collo, chissà cos’ha combinato!” Keziban si strinse spaventata alle gambe di sua madre. Kürşat quando vide suo padre in manette andò fuori di testa. Cominciò a lanciare verso i poliziotti e gli incaricati del consolato qualunque cosa si trovasse sotto mano. Per quanto Ahmet Bey gli dicesse fermati, figlio mio; lui non lo ascoltava. Da una parte lanciava improperi, dall’altra recitava il giuramento degli studenti. Terminate tutte le ciabatte nei dintorni cominciò a lanciare le patate che prendeva dal sacco sull’uscio della porta.
Döne disse: “Se gliene avessi data qualcuna sulle orecchie a suo tempo, questo non sarebbe successo”. Quelli che scendevano dall’elicottero cercavano di ripararsi da quell’aggressione. Intanto una patata grossa quanto un pugno colpì Arthur sulla testa. Quando lo vide accasciarsi a terra traballante, Kürşat si fermò. Presero in braccio Arthur e lo portarono in casa. Mentre la polizia raccoglieva la testimonianza di Döne, Arthur rinvenne. Lanciando il cuscino verso Kürşat gridò “Tra un po’ mi spaccavi la testa!” Quando vide Ahmet Bey in manette chiese, “Papà cosa sta succedendo? Mamma chi sono questi signori?” La dottoressa allungò a Arthur il bicchiere d’acqua che aveva in mano. Davanti agli occhi stupiti di tutti i parenti, Arthur si rivolse al grosso commissario di polizia. “Signor poliziotto, non ci sarebbe una lattina di Coca?”
Traduzione di G. Ansaldo
 Arthur oppure Mahmut è un racconto di Isahag Uygar Eskiciyan pubblicato nella raccolta di racconti Patates Jazzı (Il Jazz delle patate) edito dalla casa editrice Sel nel 2020. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020, su concessione dell’autore.
Arthur oppure Mahmut è un racconto di Isahag Uygar Eskiciyan pubblicato nella raccolta di racconti Patates Jazzı (Il Jazz delle patate) edito dalla casa editrice Sel nel 2020. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020, su concessione dell’autore.

Isahag Uygar Eskiciyan (1982-) con una raccolta di poesia e quattro raccolte di racconti all’attivo è uno dei personaggi più stravaganti dell’editoria turca contemporanea. Di lui non si sa quasi niente, ha un nome armeno, e questa è la sua unica fotografia. Ha vinto dei premi – Selçuk Baran Öykü Ödülü nel 2015, per la raccolta di racconti Metropol Ninnisi (La Ninnananna della Metropoli) e Arkadaş Z. Özger İlk Kitap Ödülü, nel 2013, per la prima raccolta poetica pubblicata, Aşağıdan Seveceğim Ülkeyi (Amerò il Paese dal Basso) – ma non si è mai presentato a ritirarli. La sua biografia autografa recita: “Isahag Uygar Eskiciyan è atterrato nel 1982.”
Illustrazione di copertina di ©Valo, Valentina Patete