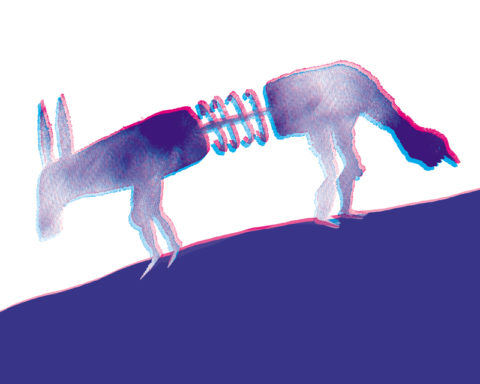Un racconto di Bilge Karasu
A Aslı a sei anni.
Dietro la finestra stava un uomo piccolo e minuto, magro e secco. La finestra era chiusa; il vetro ricoperto di gocce d’acqua. Chi guardava da fuori vedeva il volto dell’uomo tutto rigato. L’uomo aveva gli occhi puntati in alto, guardava il cielo. Ma in cielo non c’era proprio niente da vedere.
Niente di niente. Perché in quel paese ogni giorno, ogni notte, ogni mattina e ogni sera, pioveva. Pioveva ininterrottamente, senza aumentare, senza diminuire, e pure senza mai fermarsi, pioveva sottile sottile, fine fine. Cosa c’era da guardare in un cielo color piombo che non cambiava mai di una virgola? Cosa avrebbe potuto vedere?
A causa della pioggia l’asfalto delle strade e le pietre delle vie brillavano sempre luccicanti, i muri erano pulitissimi e dalla faccia scura, gli infissi delle finestre facevano sempre colare strisce di fuliggine dagli angoli. I giardini sarebbero stati verdissimi a lasciarli in pace, ma come potevano essere lasciati in pace che la pioggia copriva continuamente tutto quel verde con il fumo che sbuffava dai camini?
Le persone che abitavano in quella città, dal giorno della loro nascita a quello della loro morte conoscevano un solo colore del mare e del cielo. Che il cielo potesse essere blu – chiaro o scuro ma pur sempre blu – che il mare potesse tingersi, in accordo con quello, di ogni colore immaginabile, dal blu più scuro al verde chiaro, che potesse addirittura apparire rosso, viola, giallo, lo imparavano soltanto dalle persone che avevano girato il mondo in lungo e largo. Inoltre, stando a quanto dicevano quelle persone, negli altri cieli di giorno c’era un sole giallo – giallastro, biancastro o rossastro – che splendeva brillante. Quelli che non erano mai usciti da lì invece non avevano mai visto il sole, né le stelle o la luna… In realtà studiavano a scuola che il sole illuminava il giorno. Ma il loro di giorno, come il loro cielo e il loro mare era color piombo, o meglio, un colore tra il brunastro e il piombastro.
Le persone in quella città vedevano il colore soltanto sulle imbarcazioni in mare. Barche, chiatte, navi erano dipinte da un capo all’altro di ogni colore che gli veniva in mente, giallo, rosso, verde, blu, viola, e in quella maniera prendevano il largo.
Siccome la pioggia cadeva senza sosta, i gatti, i cani e anche i polli non potevano mai gironzolare fuori. Si poteva mica uscire e mettersi a gironzolare perché peli e piume s’inzuppassero tutti? Certamente c’erano anche gatti, cani e polli scimuniti. Quelli uscivano, si bagnavano e poi si ammalavano, e finivano a letto. C’erano delle oche, queste amavano girare sotto la pioggia. A gruppi di dieci o venti gironzolavano con le code e le ali attaccate le une alle altre, somiglianti a una nuvola con le zampe che fluttuava un poco staccata da terra. E sopra a quella nuvola dei lunghi colli dondolavano come pioppi, i becchi, quasi, si aprivano e si chiudevano come slegati da quei colli. Ma gli stormi di oche erano radi e sparuti; invece i cani e i gatti sedevano guardinghi ai piedi del muro, sotto le tettoie…
In quella città, siccome tutti quelli che giravano per le strade avevano l’ombrello, e siccome gli ombrelli fuori non si chiudevano mai, nelle strade principali si stendeva tra terra e cielo come una specie di coperta ondeggiante a altezza d’uomo. E quella coperta si ritirava e si distendeva soltanto davanti alle porte di autobus, tram, case, negozi, uffici, ingoiata come incastrata tra due labbra, due mascelle, due cilindri…
E sempre per quella stessa ragione in ogni casa c’erano ombrelli, stanzini per asciugare le scarpe e piccoli condotti in cui far colare l’acqua accumulata in quegli stanzini.
E ancora più importante, è sempre per la stessa ragione che quando si svegliavano al mattino le persone non correvano ad aprire finestre, serrande e persiane per guardare il cielo e chiedersi emozionati o infastiditi “chissà com’è il tempo oggi?” come facevano quelli che abitavano nelle altre città; oppure, sdraiati a letto, non si mettevano a guardare la luce che colpiva il muro dalle finestre filtrando attraverso le tende, e non gli passava neppure per l’anticamera del cervello di tendere l’orecchio di quando in quando verso il rumore delle ruote delle auto cercando di indovinare se piovesse, nevicasse, fosse nuvoloso o soleggiato. Perché le persone che vivevano in quella città, sapendo che il tempo sarebbe stato senz’altro piovoso, né guardavano la luce, né tendevano l’orecchio ai suoni. Dal giorno in cui erano nati in poi, non era mai cambiato…
Le persone di quella città non conoscevano speranza né delusione in fatto di meteo; quando uscivano dal cinema, dal teatro, dal caffè o dai concerti non venivano sorpresi dalla pioggia che cadeva a fiotti, non aspettavano sotto le tettoie per essersi dimenticati di prendere l’ombrello, né se andavano di corsa da qualche parte; e la domenica, neanche pensavano che se fosse stato bel tempo sarebbero andati al mare, alla partita, in campagna. Non si aspettavano niente del genere…
Le persone di quella città non conoscevano la paura di venire sorpresi dalla pioggia, non aspettavano che il cielo si aprisse, tra di loro ce n’era uno soltanto che non somigliava agli altri. Quell’uomo che guardava il cielo dalla finestra… Quell’uomo non aveva nessuno al mondo. Il suo ufficio era in uno degli enormi palazzi nella zona amministrativa della città; andava, tornava, non invitava mai nessuno a casa. Perché sapeva che non sarebbero venuti. Neanche lui andava molto a casa di amici e conoscenti, tanto meno quando non era invitato. Era un uomo silenzioso, non aveva mai fatto male a nessuno, sino a allora non aveva dato dispiacere a nessuno. Aveva un solo difetto. Ed era per quello, soltanto per quello, che amici e conoscenti si innervosivano con lui.
Non che fosse mai uscito da quella città, o avesse visto altri cieli, ma aveva ascoltato quello che si diceva a proposito del sole, l’aveva letto. Restava a lungo in silenzio poi cominciava a dire: “domattina…”; quelli che erano nei dintorni rispondevano “sì sì…” e scappavano via subito. Lo sapevano cosa sarebbe seguito. Bene, pertanto il pover’uomo la maggior parte delle volte non riusciva nemmeno a terminare la frase.
“Domattina, se nel cielo vedrete il sole, cosa farete?” Ecco quanto aveva da dire, tutto lì. Se glielo avessero fatto dire…
Si era fissato insomma. Se fosse apparso il sole, se si fosse fatto vedere… Eppure era qualcosa che sapevano da sempre. La comparsa del sole significava che la pioggia sarebbe cessata, le nuvole si sarebbero aperte; lo sapevano sin dalla nascita; la comparsa del sole voleva dire che il cielo sarebbe cambiato, gli ombrelli si sarebbero chiusi, le stanze per asciugare le scarpe non sarebbero state più utilizzate, e peggio, che la speranza, così come la delusione avrebbero fatto capolino. Significava che pietre, muri, e mattoni si sarebbero asciugati perdendo il luccichio, che i fumi invece di depositarsi sul verde sarebbero saliti in aria. Erano cose che si potevano mai vedere queste?
Non fosse stato per questa fissazione indisponente, quest’ossessione, amici e conoscenti dell’uomo avrebbero mostrato una maggior prossimità con lui, ma temendo che da un momento all’altro, se non subito, a breve, si mettesse a dire “domattina…”, lasciavano perdere.
L’uomo arrivava a casa, si lavava, si spazzolava i denti, si metteva a letto, leggeva un libro, fumava una sigaretta. Poi si addormentava.
Ma quando quell’abituale colore brunastro e piombastro o piombastro e brunastro si faceva luce entrando nella stanza, quando annunciava il mattino…
Non riusciva a trattenersi, pur sapendo che era una follia, si alzava, si metteva davanti alla finestra e cominciava a guardare il cielo da dietro il vetro rigato di pioggia.
Sul volto tutto ondulato che avrebbe visto qualcuno che guardava da fuori, sul volto che non portava traccia di curiosità, sul quale non si poteva scorgere nessuna speranza, sembrava che solo gli occhi fossero vivi. Forse oggi è uscito il sole, forse oggi uscirà. Se non oggi, domani, o il giorno dopo ancora. Ma quando arrivava davanti alla finestra sapeva per certo una cosa: non uscirà neanche oggi, non sarebbe apparso…
Eppure, mentre era ancora a letto, fintanto che non si accorgeva che la luce era cambiata, come poteva pensare quell’uomo che una volta arrivato davanti alla finestra avrebbe potuto vedere il sole? L’abbiamo già detto. Ha delle stranezze, delle peculiarità questo vostro povero uomo… Senza che la speranza neppure gli compaia sul volto, forse un po’ stupidamente, continua a nutrirla nel cuore.
Traduzione di G. Ansaldo
 L’uomo del sole nella città della pioggia è un racconto di Bilge Karasu pubblicato nella raccolta di racconti Göçmüş Kediler Bahçesi (Il giardino dei gatti sepolti) edito per la prima volta dalla casa editrice Milliyet nel 1979 e riedito da Metis Kitap nel 1991. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020 su concessione della casa editrice Metis Kitap.
L’uomo del sole nella città della pioggia è un racconto di Bilge Karasu pubblicato nella raccolta di racconti Göçmüş Kediler Bahçesi (Il giardino dei gatti sepolti) edito per la prima volta dalla casa editrice Milliyet nel 1979 e riedito da Metis Kitap nel 1991. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020 su concessione della casa editrice Metis Kitap.
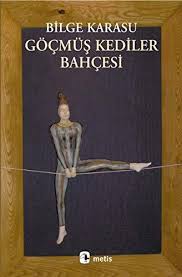 Bilge Karasu (1930-1995) laureato in filosofia alla facoltà di letteratura di Istanbul ha lavorato per l’emittente di Ankara della radio statale TRT come autore radiofonico; traduttore, scrittore e accademico ha beneficiato a metà degli anni Sessante di una borsa Rockefeller con la quale ha viaggiato in diversi paesi in Europa. I suoi scritti cominciano a comparire nel 1950 e nel 1952 pubblica la prima raccolta di racconti. Nel 1963 gli viene riconosciuto il premio per la traduzione dell’Istituto della Lingua Turca per il libro di D.H. Lawrence The Man Who Died e da allora è insignito di numerosissimi premi letterari per i suoi scritti. Autore principalmente di racconti e scritti sparsi, è conosciuto in particolare per il suo perturbante romanzo Gece, già pubblicato in italiano dalla casa editrice Mesogea con il titolo Notte attualmente fuori catalogo.
Bilge Karasu (1930-1995) laureato in filosofia alla facoltà di letteratura di Istanbul ha lavorato per l’emittente di Ankara della radio statale TRT come autore radiofonico; traduttore, scrittore e accademico ha beneficiato a metà degli anni Sessante di una borsa Rockefeller con la quale ha viaggiato in diversi paesi in Europa. I suoi scritti cominciano a comparire nel 1950 e nel 1952 pubblica la prima raccolta di racconti. Nel 1963 gli viene riconosciuto il premio per la traduzione dell’Istituto della Lingua Turca per il libro di D.H. Lawrence The Man Who Died e da allora è insignito di numerosissimi premi letterari per i suoi scritti. Autore principalmente di racconti e scritti sparsi, è conosciuto in particolare per il suo perturbante romanzo Gece, già pubblicato in italiano dalla casa editrice Mesogea con il titolo Notte attualmente fuori catalogo.
Illustrazione di copertina di Güliz Kayahan.