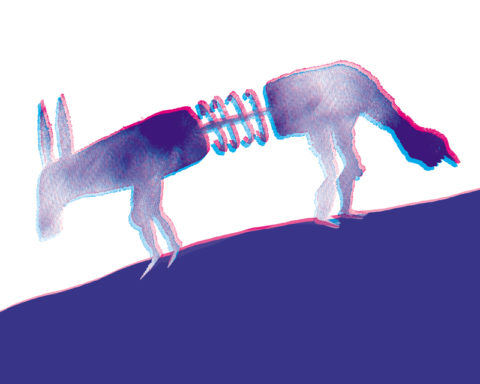Un racconto di Yiğit Bener
Non so cosa ho provato quel giorno. Dolore? Vergogna? Probabilmente entrambi al tempo stesso. Ma soprattutto ricordo di essermi stupito. Non avevo capito cos’era successo. Era pur sempre il primo schiaffo; almeno per quanto mi ricordi, il primo. Sì, senza dubbio, quando mio padre mi ha schiaffeggiato ho provato principalmente stupore: Cosa avevo mai detto per meritarlo? E mio padre che mi amava senz’altro, come aveva potuto colpirmi?
Certo bisogna tenere in considerazione anche i fattori esterni. Era la nostra prima vacanza estiva dopo che mio padre era stato trasferito a lavorare all’OCSE in Francia. Con la Ford Tanus color ocra avevamo attraversato da un capo all’altro tutta l’Europa… Mio padre che aveva guidato quasi senza sosta da Parigi doveva essere piuttosto stanco. Arrivati alla frontiera di quella che all’epoca si chiamava la “cortina di ferro”, la targa verde arancio dell’auto diplomatica aveva perso il suo privilegio trasformandosi quasi in un abbagliante. I funzionari della dogana dalla camicia color kaki appena vedevano la targa ci facevano passare davanti, tra gli sguardi arrabbiati dei migranti che formavano una fila lunghissima di auto stracariche, ma invece di farci attraversare la frontiera davano ordini di prendere contatto con le “autorità” di Belgrado o Sofia.
A causa di quell’iter burocratico fummo costretti a attendere mezza giornata alle due estremità del paese che si chiamava Jugoslavia…. Erano ancora i giorni “caldi” della Guerra Fredda, anno 1964… La tensione aggravata fino all’allarme rosso dalla crisi dei missili di Cuba non si era ancora placata… Fatto sta che la polizia bulgara in uniforme blu aveva un’altra preoccupazione; all’entrata di ogni città fermavano l’auto mostrando a mio padre a cui si rivolgevano chiamandolo “komşu” – questo vicino ingombrante – un segnale stradale nascosto tra gli arbusti avvicinandosi con un’espressione sorniona sul volto… Per far chiudere un occhio -avido- in quella cerimonia immutabile, mio padre sacrificava ogni volta due o tre pacchetti delle preziose sigarette americane Kent dentro un imballaggio bianco, che in quegli anni erano merce rara in Turchia… E i doganieri vestiti di bruno alla frontiera di Kapıküle erano degli appassionati di quel mercato sottobanco… Dopo aver ispezionato una per una tutte le valigie nel portabagagli, mio padre, esasperato nel vederli decisi a fargli smontare anche i bauli sul tettuccio dell’automobile, fu costretto a rinunciare alla bottiglia di whisky Black Label destinata a mio zio… Per di più, c’era ancora un bel pezzo di strada da fare fino a Istanbul dove avremmo trascorso la notte; e solo l’indomani saremmo potuti arrivare alla nostra meta finale, Ankara…
Per di più faceva molto caldo. Quando scendemmo dall’auto per la pausa pranzo in una bettola a bordo della strada appena fuori da Edirne, eravamo completamenti sudati; al punto che mentre aspettavamo i nostri kebab sulla terrazza senz’ombra avevamo l’impressione di evaporare… Non mancavano inoltre gli odori di urina che giungevano dalla cabina vagamente rosa in fondo al giardino e oltre alle mosche che si posavano dappertutto, degli spaventosi tafani con i loro giganteschi occhi verdi.
Mi ricordo come fosse ieri il colpo che fece esplodere fulmini di tutti colori nella mia testa e ogni particolare della breve conversazione avuta poco prima che accadesse.
Ma quanto è giusto aspettarsi dal ragazzino di sei anni che ero, mentre ancora mi massaggiavo la guancia infiammata, che capissi a caldo tutte le attenuanti di quel gesto che oggi con il senno di poi mi sembrano di facile interpretazione? Fatto sta che non c’è alcuna scusa per colpire un bambino e nonostante il profondo rispetto e affetto per mio padre che non c’è più, neppure oggi posso dire di aver scusato quel gesto impulsivo e astioso di mezzo secolo fa…
Quanto alla stanchezza e al nervosismo, lo eravamo tutti. E poi, credete fosse facile per un moccioso come me che non riusciva a stare fermo un minuto passare tre giorni sul sedile posteriore dell’auto? In più con tutto il fumo che arrivava dietro!
Quando mio padre cantava “Dammi una sigaretta, te ne prego”, mia madre ne accendeva due alla volta e con che gusto… Una la incastrava tra le labbra di mio padre, dall’altra aspirava subito una profonda boccata. A dire il vero per quanto l’odore di sigaretta mi desse la nausea mi piaceva vederli flirtare in quel modo, credo. Fatto sta che non arrivando mai alla meta, il mio coefficiente di tristezza aumentava vedendo mia madre che invece di prendermi in braccio accendeva una sigaretta dietro l’altra…
Era vero che grazie a quella pausa avrei potuto saltellare su e giù e sgranchirmi un po’ le gambe ma ero stato ammonito di non allontanarmi troppo: la locanda era sul bordo della strada, i camion passavano rombando, d’altronde il cibo stava per arrivare, dopo aver mangiato un boccone dovevamo ripartire, il viaggio è viaggio… Così ero costretto su una sedia più scomoda del sedile dell’auto con una faccia tutta imbronciata. E oltre agli strani insetti che si appiccicavano all’incerata, dovevo far fronte a ogni tipo di bestiola alata che ronzava e insisteva a posarsi sui miei polpacci nudi…
Alla fine me ne ero lamentato: “Ma quanti insetti ci sono qui!”
Il tono nervoso di mio padre era in effetti un segnale; dovevo riconoscerlo: “Cosa c’è di più naturale degli insetti in campagna?” Incosciente rincarai: “Ma in Francia non c’erano così tante mosche…”
Allora non sapevo ancora distinguere le frasi che servivano come segnale di avvertimento dalle altre: “Questa è la Turchia, il nostro paese… È bene che ti ci abitui!”
Un tafano grosso quanto un vitello aveva scelto proprio quel momento per appiccicarsi al mio ginocchio. Fu un misto di paura e disgusto a farmi parlare: “Se la Turchia è sempre così io preferisco diventare francese e restare sempre in Francia…”
Insieme a un’espressione selvaggia che vidi per la prima volta calare sulla faccia di mio padre, sentii lo schiaffo esplodermi in faccia! La guancia mi bruciava, sentivo male, ma non avevo ancora capito cos’era successo.
A pensarci ora, quante cose non avevo capito quell’estate. Ad esempio perché quei ragazzini sul mar di Marmara dove eravamo andati in vacanza due settimane dopo si erano messi a rincorrermi urlando: “Sei una femmina! Sei una femmina!”. Certo in confronto ai loro capelli rasati a tre millimetri i miei potevano considerarsi lunghi… E allora?
All’epoca non sapevo certo che in questo paese ci fossero sin dall’origine del mondo certe fissazioni a proposito di peli e capelli, ad esempio sulla lunghezza dei capelli dei ragazzi o i capelli coperti e scoperti delle ragazze. Oggi mentre mi lego i capelli ben grigi mi viene quasi da ridere a ricordare il mio stato quel giorno nella bottega del barbiere dove ero andato di corsa “per provare la mia mascolinità”, scortato da una folla di bambini che aspettava alla porta.
Era una bottega piccolissima, d’altronde all’epoca Marmara Ereğlisi era un posto piccolissimo, una cittadina praticamente desolata. All’entrata della bottega erano appese fianco a fianco la solita fotografia di Atatürk e una preghiera in caratteri arabi che fronteggiavano un enorme nazar boncuk contro il malocchio. Pennelli per la barba, spazzole, rasoi, barattoli di talco e acqua di colonia di tutti i colori addobbavano le mensole. Quanto alla tavola di legno posata di traverso sui braccioli che il barbiere usava come rialzo per i bambini, mi faceva male al sedere. Ero scocciato. Non capivo assolutamente perché dovessi sacrificare i miei capelli per farmi accettare come un maschio. Mi sentivo umiliato.
Avrei vissuto una scena simile verso la fine del liceo: la direttrice moderna della nostra moderna scuola aveva fatto venire il barbiere per tagliare i capelli ai ragazzi che li portavano lunghi nel cortile del liceo a titolo di esempio…
In quella piccolissima bottega mentre il barbiere mi radeva i capelli, nonostante i miei sei anni, “Pazienza” pensai, “Alla fine ricrescono…” Non sapevo ancora che alla fine dell’estate, per poter essere un vero uomo avrei dovuto farmi tagliare la pelle del prepuzio…
Lì, mi opposi! A dire il vero non si trattava di un’opposizione di principio rispetto alle mie convinzioni attuali, era una ribellione basata solo sulla paura. Rifiutando di consegnarmi docilmente all’uomo in abito bianco, me l’ero data a gambe levate. Alla fine di una breve rincorsa tra i corridoi dell’ospedale mio padre mi afferrò ben bene per offrire il mio sedere all’enorme ago della gigantesca infermiera…
Non so se prima di svenire riuscii a dire “Anche tu, padre?” Fatto sta che per lunghi anni me lo sono chiesto: Com’era possibile che mio padre ateo mi avesse sacrificato a una simile tradizione religiosa? La risposta la ebbi da lui stesso molti anni dopo. Il suo obiettivo era proteggermi da eventuali discriminazioni, perché temeva che se non fossi stato circonciso, negli anni successivi (ad esempio durante il servizio militare) avrei potuto essere trattato da “infedele”.
Significava cioè che in questo paese era indispensabile essere un corpo unico, dalla punta dei capelli alla pelle del prepuzio, con stato e popolo.
D’altronde essere “diverso” a scuola era già un guaio. Questo l’avrei imparato due anni più tardi una volta tornati e installati a Ankara.
Dopo aver studiato per tre anni in una scuola privata di Parigi in una classe di quindici studenti, mio padre per non viziarmi e farmi sentire un privilegiato mi iscrisse alla scuola pubblica di quartiere; pensava che così avrei potuto integrarmi meglio.
Forse ero io il problema, fatto sta che quando alla prima lezione alzai la mano, non capii perché i miei sessanta compagni di classe col grembiule nero dal colletto bianco mi guardassero con tanto orrore.
La reazione del nostro caro professore fu parecchio esplicativa del resto. Con le sopracciglia aggrottate, una faccia contrariata e passi lenti mi si avvicinò in silenzio. “Che c’è!” sibilò con una voce roca e sbuffando dal naso. (Così come era stato prima dello schiaffo di mio padre, non avevo interpretato come un monito quel volto severo). Ricordo di aver risposto con tutta innocenza a quell’esclamazione interpretata come una domanda “Volevo chiedere una cosa della lezione”.
Il professore si contentò di dire “Apri la mano” e come eseguii l’ordine mi batté il palmo con la bacchetta di metallo. “Che ti serva da esempio, non interrompere più”, disse allontanandosi.
Ancora una volta ero rimasto a bocca aperta più per lo stupore che per il dolore. Perché la mia domanda l’aveva fatto tanto arrabbiare? Non avrebbe dovuto, al contrario, lodarmi? Fare domande non era una prova del mio interesse per la lezione? Era sbagliato che uno studente si interessasse alle lezioni?
Ma in quella scuola c’erano molte altre domande destinate a restare senza risposta. Ad esempio perché ogni mattina eravamo costretti a metterci sull’attenti e gridare con quanto fiato in gola “Sono turco, retto, lavoratore, la mia legge è difendere i piccoli, rispettare i grandi, amare il mio popolo e la mia patria più di me stesso!” E perché ogni lunedì mattina e ogni venerdì sera dovevamo allinearci nel cortile come soldati e cantare l’inno nazionale? O forse anch’io come tutti i turchi ero nato soldato? E mia sorella allora? E perché quando avevo avuto il coraggio di dire che le punizioni collettive erano ingiuste il direttore mi aveva rinchiuso nell’armadietto?
Col tempo a dire il vero avevo capito cosa ci si aspettava da me: Ubbidisci senza interrogarti, consegna la tua volontà, fare domande è vietato, le critiche poi, completamente vietato! Sull’attenti… Imbraccia quella sacra divisa… Dio e Patria! La mia patria, quella da amare più di me stesso, che non rideva mai, che non faceva mai ridere, che non sopportava neppure le risate di una donna, che considerava la critica e la satira un insulto… Sacrifica tutto al popolo e alla patria, dai capelli alla pelle del prepuzio!
Non ce l’ho con mio padre per avermi fatto conoscere con quello schiaffo un’infanzia alla turca. Anche lui come tutti cercava di tenersi in piedi in quelle condizioni, si preoccupava solamente di insegnarmi a adattarmi, a restare in piedi, a difendermi. A dire il vero certi metodi adoperati a quello scopo portavano le tracce della violenza che aveva impresso la sua anima da bambino, stridevano con l’obiettivo finale. Ma d’altra parte le contraddizioni non sono forse proprie dell’uomo? Sono ormai in pace con i difetti umani di mio padre, che riposi sereno.
E poi… non era quello stesso padre scrittore che mi insegnava a fare domande, a dubitare, a rifiutare ogni tipo di fanatismo, a interrogare ogni dogma? In nome di ciò nella sua gioventù era stato in prigione, per non chinare il capo davanti all’autoritarismo dispotico, e in questo mi è sempre stato di esempio.
Se pure mi aveva dato qualche schiaffo non era lui che mi aveva parlato dei libri, trasmesso la passione per la scrittura? Oggi preferisco ricordarlo per questa eredità. Non è ancora oggi quell’eredità l’unico sostegno di fronte alla brutalità del mondo? Cos’altro serve?
Fatto sta che avrei conosciuto la violenza soprattutto dopo, durante la mia gioventù militante: Colpi di manganelli o calci di pistole, proiettili e bombe piovuteci addosso…
In verità ho superato sano e salvo quegli anni bui ma non tutti li hanno superati. Come dimenticare gli amici passati sotto tortura prima di marcire nelle carceri della giunta militare, i corpi di decine di migliaia di giovani della mia generazione trivellati e esposti come “trofei di guerra”?
E negli anni della dittatura, come dimenticare gli insulti, le minacce quotidiane dei generali dagli schermi della televisione?
Ma niente di tutto questo mi ha fatto né mi farà rinunciare a pormi domande.
Oggi seduto in poltrona davanti alla televisione osservo quei generali, ormai abbattuti, al tavolo degli imputati, accusati di diversi colpi di stato militari. So che questo primo schiaffo della loro vita non cambierà il mondo, e che ci sono altre minacce all’orizzonte, certo.
So anche che altri colpi potranno abbattersi su coloro che continueranno a fare domande, a rifiutare di entrare nei ranghi o di sacrificarsi per quelli che sono considerati doveri sacri e capi supremi. Sia! C’è sempre una prima volta…
E oggi, vedendo queste immagini devo confessare che per quanto amaro sia non riesco a impedirmi un sorriso…
E almeno questa volta so perché.
23 aprile 2012
Trad. G. Ansaldo
 Perché è un racconto di Yiğit Bener pubblicato con il titolo Neden nella raccolta Öteki Düşler (Altri Sogni) pubblicata dalla casa editrice Can nel 2017. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2019 (su concessione dell’autore).
Perché è un racconto di Yiğit Bener pubblicato con il titolo Neden nella raccolta Öteki Düşler (Altri Sogni) pubblicata dalla casa editrice Can nel 2017. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2019 (su concessione dell’autore).
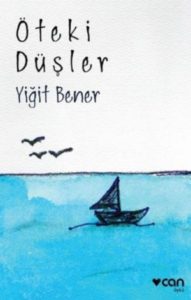
Scrittore, traduttore e interprete, Yiğit Bener è nato nel 1958, ha trascorso la sua infanzia e gioventù tra Parigi, Ankara e Bruxelles, e dal 1990 vive a Istanbul. Ha pubblicato il primo romanzo nel 2001 Eksik Taşlar (Le pietre mancanti). L’ultimo romanzo del 2011 Heyulanın Dönüşü (Il ritorno del fantasma), pubblicato in Francia per Actes Sud nel 2014, è stato insignito nel 2012 del premio per il romanzo Orhan Kemal. Nel 2010 ha pubblicato il primo libro di racconti Öteki Kâbuslar (Altri Incubi) a cui ha fatto seguito il libro da cui è tratto il racconto qui presentato e che raccoglie racconti scritti tra il 1991 e il 2016. Perché e altri racconti della raccolta sono stati scritti prima in francese e poi riscritti dallo stesso autore in turco. Öteki Düşler è stato insignito nel 2018 del premio per il racconto Yunus Nadi. Inoltre Yiğit Bener è stato curatore di diverse opere collettive tra cui İçimizdeki Ermeni (L’armeno che abbiamo dentro) pubblicato nel 2015. La sua traduzione di Viaggio al Termine della Notte di Louis-Ferdinand Céline è stata insignita nel 2002 del Dünya Kitap Yılın Çeviri Ödülü (Premio per la traduzione letteraria dell’anno).
Illustrazione di copertina di ©Gizem Malkoç per Kaleydoskop.