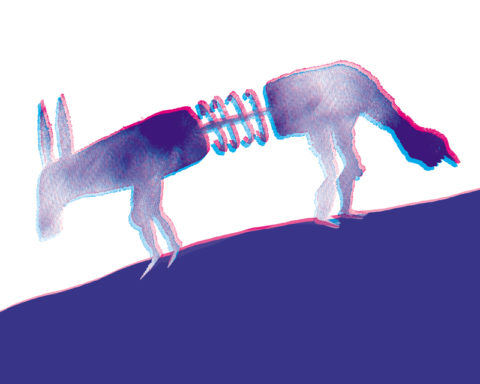2.9 secondi. Un racconto di Pelin Buzluk
Perdonatela.
Lei che di tanto in tanto
dimentica
il doloroso legame del suo corpo
con le acque stagnanti e le cavità vuote
e scioccamente crede
di avere il diritto di esistere. [1]
Forugh Farrokhzād
D’un tratto sono schizzato fuori dal letto. Credevo di correre, Ma ecco, proprio qui, d’un tratto mi sono fermato. La mia spalla ha sfiorato le tende. Ero solo. Una solitudine mortale. Mi sono appoggiato alla valvola del frigorifero. Tremavo. Senza toccare la tenda ho guardo fuori da uno spazio che si era creato da sé. Non potendo vedere nessuno, o meglio guardando fuori dal vetro invece di dormire a quell’ora di notte, temevo di accorgermi della mia solitudine. La luce della stanza era accesa e era facile essere visto. Mi sono voltato verso la stanza e ho guardato l’orologio: le quattro meno dieci. La mia immagine riflessa nello schermo senza vita del televisore mi ha spaventato. Pensavo non ci fosse nessuno. Da piccolo, quando mi guardavo allo specchio sobbalzavo temendo di vedere un altro volto che sorrideva perverso dietro la mia immagine. Adesso invece basta vedere me stesso per sussultare. So che quando morirò le persone vedranno questo volto. Ormai non è molto probabile che cambi. Persino morto… Se anche io non ci sono, se anche non vedo con questi occhi, guarderanno questo volto incuranti. Come adesso: nonostante non mi trovassi nella stanza la mia immagine si rifletteva eccome in quello schermo muto.
Sono solo e pauroso. Un codardo senza pari. Più di tutto ho paura di me stesso. In ogni momento, senza preavviso, posso dare un calcio a un mendicante lungo la strada o prendere sotto braccio un cieco come volessi aiutarlo e gettarlo in mezzo al traffico, oppure afferrare per il colletto un anziano tirandolo giù dal sedile dell’autobus e essere linciato sul momento. Non so dove nascondere la rabbia che ho dentro, né perché farlo. Sono solo. Ovvero non sento il bisogno di nessuno. Tutta questa folla appiccicosa con le sue maniere calcolate mi soffoca. È da molto che mi sono liberato delle persone che mi sono state distribuite solo in quanto miei consanguinei. Quelle di cui sento il bisogno non sono quelle che mi ha attribuito la natura. Quelli di cui sento il bisogno, i miei amici, se ne sono andati. Nel ricordarli adesso sulle mie labbra si impone un sorriso doloroso, sarcastico, incapace di trattenere il pianto che segue. Quelli che si sforzavano di farmi sentire che “non ero solo”, se ne sono andati senza neppure chiedere per pura cortesia “Puoi restare un po’ da solo?”
Dio mio, questo riflesso sullo schermo mi ucciderà. Deve essere coperto con un panno. Ho gettato via tutti gli specchi, ma sono oggetti questi, gli piace il tradimento. Ieri il vetro della libreria, oggi lo schermo del televisore… Nei momenti più inopportuni mi ricordano di me. Non voglio vedermi in nessuna superficie luminosa, in nessuna vetrina. O non è possibile che una persona si dimentichi del proprio volto? Deve essere possibile, altrimenti questa preoccupazione della morte, questa faccia pallida rubata a un cadavere mi ucciderà.
Invece una di quelli che se ne sono andati, un’amica, adorava gli specchi. Non potevo andare a casa sua, c’erano esattamente quattordici specchi. Nono riuscivo a trovare angolo in cui scappare. Preferivo incontrarla fuori. Apriva di frequente la borsa, dalla confusione tintinnante che c’era dentro tirava fuori quello specchietto, e con l’indice e il medio perlustrava sopracciglia, occhi, labbra. Dopo aver controllato di non avere niente tra i denti tornava a guardarmi, sicura di sé, sorrideva. Evren era davvero una bella donna. No, non si poteva dire attraente. Quando sorrideva aveva un’aria leggermente irritante che mi spaventava – così come mi spaventa la mia immagine – e dall’altra parte mi attirava. Evren aveva moltissimi amici e poteva parlare con tranquillità della morte. Nonostante tutte quelle persone attorno, era comunque sola. Non si lamentava. Per non rendere chiaro di tacere raccontava cose impossibili. Poi parlava con me di tutto quello che aveva accumulato. Mi manca, lo so. Avevo un posto stabile nella sua vita. Evren fuggiva da tutto quel rumore, da tutta quella confusione e veniva da me. A volte mentre raccontava piangeva così tanto che mi bagnava finanche la canottiera. La facevo sdraiare semisvenuta nel mio letto, io dormivo sul divano. La mattina si svegliava purificata da tutte le preoccupazioni, Evren.
L’ultima degli amici a abbandonarmi è stata lei. Mi voleva bene nonostante questa faccia morta. Come ho fatto a vivere fino a oggi con questa faccia? E Evren, con quel volto dal naso appuntito sopra i denti regolari, le ciglia che toccavano le sopracciglia, sempre pronto a sorridere, vivace, come ha fatto a morire?
Evren lo scorso mercoledì notte, insieme alle gocce di sangue che cadevano insieme a lei fuoriuscendo dai polsi che si era preventivamente tagliata, ha gettato il suo corpo dall’edificio più lontano dal centro. Ora ci penso, se l’edificio fosse di 40 metri… significa che è caduta in circa 2.9 secondi. Cosa pensa una persona in tutto questo tempo, sanguinando e sapendo che a breve le proprie ossa si schianteranno in mille pezzi? Tre secondi sono poco tempo, ma quanto durano mentre ci si avvia alla morte in maniera inequivocabile? La legge di caduta libera dice che quando Evren è sbattuta a terra si muoveva a una velocità di 28 metri al secondo. Caduta libera… Com’era libera Evren… Questo lo dice persino la solida legge della fisica. Aveva osservato l’edificio con occhi da architetto? Perché aveva scelto quel palazzo? Aveva scelto di portarsi la morte in quell’edificio. No, questo non è vero Evren l’aveva scelto solo perché era il palazzo più lontano. Perché la trovassero tardi. Altrimenti tutti gli edifici del centro sono identici.
Mercoledì notte io mi ero preparato un latte e miele e avevo zittito quella voce pusillanime che dentro di me gridava “Vita sana!”, poi mi ero addormentato presto. L’amicizia è una menzogna. Non ero riuscito a difendere la sua vita – fosse stato anche per me stesso. Di fronte alla morte ero un poveraccio schifoso, un rettile impotente che aveva smesso di fumare dopo i quarant’anni, che si sforzava di bere latte e dormire presto, che la mattina andava a correre, terrorizzato dalla morte sperando di poter avere una relazione con qualche altra donna prima dell’andropausa… Non avevo sentito che Evren sarebbe morta, ecco, né che lo era.
Il mattino successivo mi sono svegliato imprecando contro la suoneria del telefono. Avevo la faccia gonfia. In un primo momento non ho capito il significato delle voci che venivano dall’apparecchio: “Ieri notte Evren…” “Sì, è morta…” “No, non ha lasciato nessun biglietto…” Ricordarmi queste frasi dimostra che anch’io ho parlato ma non ricordo cosa ho detto. Quella notte io, proprio in quel momento, avevo represso la paura sperando di vivere ancora altri dieci anni almeno. E mentre mi addormentavo ascoltando preoccupato il mio respiro, Evren stava forse salendo le scale di quell’edificio. Un codardo di prima categoria. Mi venivano in mente gli insetti schiacciati sotto le ciabatte. Da quell’edificio Evren mi è caduta addosso.
Al funerale ho sentito la sua voce: “Ecco, è così che si muore!” diceva. Sono di quelle persone che per tutta la vita hanno un rapporto con la morte, che sono costrette a vivere per non morire. Ero rimasto appiccicato alla vita come un parassita. Non avevo amici degni di nota o uno status per ricordarmi. Non potevo creare né un’opera d’arte né qualcosa nel mondo della scienza. Non sarei neanche potuto essere un buon padre. L’unica cosa che potevo lasciare, un suicidio ambiguo che avrebbe potuto destare continuamente curiosità. Ma non morivo. Quando le raccontavo continuamente di voler morire e dell’insignificanza della vita, non ero onesto. Adesso mi sminuiva con la sua morte. È impossibile non emulare la vita finita e il futuro congelato di Evren. Quando viveva era molto lontana dalla morte. Doveva aver stabilito e pensato la morte solo quando le era vicina, non dopo. Altrimenti avrebbe lasciato almeno una nota, due righe almeno. Non le era passato per la mente il suicidio. Questo non significava non capire Evren. Forse lei non sapeva che sarebbe morta quel mercoledì notte.
Una notte mentre Evren era da me avevo provato a suicidarmi. Era stato un grido d’aiuto disgustoso. Una minaccia. Evren aveva trascorso tutta la notte con me al pronto soccorso. Non parlò a nessuno di quell’episodio. Eppure dentro di me avevo sempre voluto che lo raccontasse. Avevo sperato che i nostri comuni amici vedessero nei suoi occhi quella compassione, preoccupazione e paura. È stata la più grande azione della mia vita. Per questo doveva parlarne agli altri. Io invece, ignaro del fatto che se ne fosse parlato, dovevo nascondere le ragioni della mia tristezza sul volto con sincera innocenza e utilizzare gli esiti come minaccia. Le persone dovevano nutrire un misto di ammirazione e imbarazzo nei miei confronti. Dovevo trarre piacere da questo fatto. Ma Evren non disse una sola parola a nessuno. E adesso è morta. Il mio suicidio si è schiantato sull’asfalto alla stessa velocità di Evren, in 2.9 secondi. Adesso penso quasi che le mie idee – non avevo scritto niente a proposito – siano state rubate. Sto per piangere. Sono arrabbiato e ammirato al tempo stesso nei confronti di Evren per essere riuscita a morire… Non ha mai parlato del suo di suicidio! Chissà forse si è trattenuta con grande orgoglio per non scrivere niente. Non ha lasciato dietro di sé neppure una frase. A pensarci piango come un vitello. Dalla rabbia? Dal dolore? Chissà. Non ha scritto una sola riga. Lo sapeva, per quanto si parli, le parole sono impotenti per raccontare certi sentimenti. E soprattutto è inutile e impossibile far arrivare alle persone immerse nel brusio viziato della vita, i sentimenti di qualcuno che ha deciso di morire. E Evren dopo essere morta non sperava di continuare a vivere, ha sperato soltanto la morte. No, non è stato per orgoglio, non ha lasciato lettere perché non le importava.
Ah, com’ero debole in confronto a lei! Per quanto fossi rattristato, era tutto inutile… Al funerale le persone mi guardavano. La maggior parte non le conoscevo neppure. Ero rimasto bloccato, non riuscivo a piangere. Ero soltanto piantato lì nel mezzo quasi a chiedere scusa. Alla fine, di nascosto, mi sono infilato le unghie dei mignoli negli occhi. Volevo che fossero rossi sangue. E mi sono scese le lacrime. Ero rattristito più di tutti… Tutta quella folla, con i loro sguardi curiosi dietro le maschere di pianto, i loro stomachi affamanti nascosti nei corpi dolorosi che indirizzavano al cimitero, dovevano vederlo questo. “Evren non doveva morire!” Dovevano leggere in me questo pensiero, senza sapere perché.
Dopo che la folla si era allontanata ho toccato il terreno tiepido. Lei era subito sotto. Il corpo morto che a breve si sarebbe mescolato con una spietata indifferenza alla terra era superiore a me. Essere in vita era vergognoso. Immaginavo come poteva essere sdraiata sotto terra. Stranamente mi ricordai della Ragazza Morta di Schiele che avevamo visto insieme. Allora guardando il quadro avevo provato un formicolio allo stomaco. Voltandomi verso Evren le avevo detto “Com’è impressionante!” aspettando il suo consenso. E lei, con un sorriso insperato, nascosto aveva risposto “Mi somiglia”.
Quando ha cominciato a scurirsi mi sono messo a pestare il terreno piangendo. Un vivo non può abbassarsi così tanto di fronte a un morto. Evren – purtroppo – non ha sentito che stavo schiacciando la terra sotto i piedi. Proprio come io, per quanto passi a fianco di quell’edificio, per quanto guardi la macchia del corpo sull’asfalto, non posso sentire il dolore nel momento dello schianto…
Era salita più in alto che aveva potuto, aveva scelto l’ora più desolata della notte per non essere salvata e prima di saltare si era tagliata i polsi. Mentre io non ero morto neppure una volta, Evren era morta tre volte di seguito. Tutte le ossa si erano frantumate sull’asfalto, il cervello era scoppiato, la faccia su cui era stampato il sorriso riflesso nello specchio si era sgretolata, gli organi senza vita dovevano essersi contorti in uno strano modo. Poter morire era un’abilità.
Per quanto codardo, ero un vivo. Almeno dopo la morte l’avrei fatto sentire a Evren. Potevo salire su quell’edificio, spenzolarmi di sotto; rientrato a casa potevo scarabocchiare note e disegni. Se l’avessi fatta vivere con la sua morte forse mi sarei perdonato. Ma era Evren che non riuscivo a togliermi dalla testa oppure il fatto che avesse potuto morire? Pensavo a lei o al suo suicidio? La donna curata che nella mia mente tirava fuori lo specchietto dalla borsa ora non era più solo bella, era anche molto attraente.
Certe notti all’ora in cui si crede si sia gettatata la immagino mentre sale l’edificio. Il rasoio in mano, a breve si taglierà i polsi. Sale a passo sicuro. La sua ultima fatica.
Alla fine una notte mi sono trascinato in cima a quell’edificio. Arrivato nel punto in cui è saltata, ho provato disgusto per quella brutta creatura, increspata, tremante che cerca di nascondersi tra le mie gambe sudate. D’un tratto sono schizzato: Sul pavimento c’erano gocce di sangue, dovevano essere colate dai polsi. Ero scioccato, Evren era morta! Il sangue sgorgato dalla pelle delicata dei polsi tagliati dal rasoio mi colpiva in faccia. Come se qualcuno stesse picchiandomi. Ho sentito un calcio sui testicoli. Mi sono sdraiato con la schiena a terra. Il tremito non passava. Stavo per morire di dolore.
Ho fatto scorrere la mano senza forze e più delicata possibile sulle macchie di sangue. Mi sono riavuto un poco e ho guadato di sotto. Ho sentito un violento gemito uscire dalla mia bocca. Si stendeva svergognato sulla notte, non sapeva tacere. Mi sono messo le mani sulle labbra. Ero rimasto senza fiato. Non riuscivo a calmarmi. Ero sorpreso delle mie lacrime. E codardamente, speravo che qualcuno fosse testimone di quel mio stato.
Quando ho sentito delle mani sulle mie spalle la paura ha raggiunto il culmine. Ho aperto gli occhi a fatica: un ragazzino giovane, lo scuro volto preoccupato. Era il guardiano del complesso. Cioè l’uomo che aveva trovato Evren. Per spiegare la ragione per cui mi trovavo lì gli dissi che ero amico di Evren. Con le sue braccia forti mi ha abbracciato come fossi un bambino. “Non si muore con la morte, amico”,disse. “Lo so, è questo che mi fa male. Non riesco a morire e non so se ci sia qualcosa di più grave della morte.” Piangevo. Da un lato la mia coscienza lavorava lucidissima, mi forzava a conoscere quello che volevo sapere. Gli ho chiesto come aveva visto la morta. Mi ha raccontato: l’orologio brillava alla luce della luna. “Se l’avessi vista, il cuore non ti avrebbe retto. Perché la gente si fa una cosa simile? Per giorni le immagini che ho visto non mi sono andate via dagli occhi. Non sono riuscito a mangiare a lungo.” Evren era morta davvero. “Era innamorata?” ha chiesto il guardiano. Mi sono fermato. Questa era dura, non sono riuscito a deglutire. Gli sguardi densi erano su di me, aspettava una risposta. Potevo trovare il coraggio di rispondergli? Mi sono schiarito la gola. La risposta era rivolta a me. “Quando viveva, no” dissi. Aspettava il seguito in silenzio strizzando gli occhi. E la mente gli ha detto il resto. Mi ha guardato in faccia come se avesse trovato un secondo morto, con un terrore maggiore del primo. D’un tratto mi ha lasciato. Senza dire niente si è sollevato in fretta. Si è mescolato al buio ed è sparito. Era come se mi fossi, anche solo se poco, purificato. Ora non ero più così codardo. Mi sono asciugato le lacrime. Ho accarezzato di nuovo le macchie di sangue di Evren, come se accarezzassi la sua pelle. Dovevo aprire la tomba con quelle stesse dita, e toccare la sua pelle morta. A volerlo era la durezza in mezzo alle mie gambe.
[1] Trad. dall’originale persiano di G. Ansaldo. Una raccolta di poesie di F. Farrokhzad è disponibile nella traduzione di Fazeh Mardani, È solo la voce che resta. Canto di una donna ribelle del Novecento iraniano, Aliberti editore, 2009, Roma.
Traduzione di G. Ansaldo

2.9 secondi è un racconto di Pelin Buzluk pubblicato nella raccolta di racconti Deli Bal (Miele matto) edito dalla casa editrice Varlık nel 2010, successivamente riedito da Can e da Iletişim. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2020, su concessione della casa editrice.
 Pelin Buzluk (1984-) Con tre raccolte di racconti all’attivo è stata insignita dei principali premi letterari della Turchia tra cui lo Yaşar Nabi (2010), il Selçuk Baran (2012) e il prestigioso Sait Faik Hikaye Armağanı (2016). Scrive per diverse riviste e i suoi racconti sono presenti in molte opere collettive.
Pelin Buzluk (1984-) Con tre raccolte di racconti all’attivo è stata insignita dei principali premi letterari della Turchia tra cui lo Yaşar Nabi (2010), il Selçuk Baran (2012) e il prestigioso Sait Faik Hikaye Armağanı (2016). Scrive per diverse riviste e i suoi racconti sono presenti in molte opere collettive.
Illustrazione di copertina di @Martina Binosi