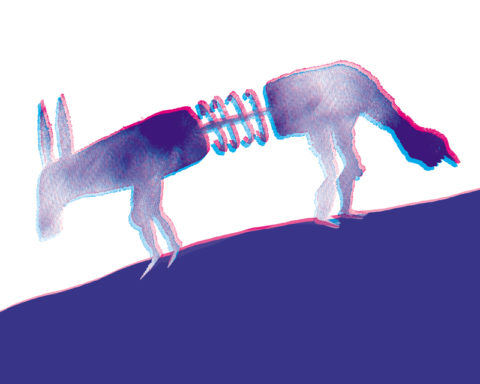Un racconto di Yavuz Ekinci
Perché i vivi vogliono che i morti tacciano?
Herman Melville
Chiamatemi Ismail! Sono disteso sotto un cielo blu screziato. Ai miei piedi e alla mia testa non sono stati messi neppure due pezzi di pietra grigi perché la mia tomba non sia dimenticata. Nessuna cerimonia è stata fatta per il mio cadavere. Né l’imam ha letto versetti del corano, né preti hanno pronunciato litanie. Il mio corpo non è stato lavato. E il mio cadavere non è stato esposto nella camera mortuaria. Padri e padrini non sono stati chiamati per testimoniare il proprio dolore. Il mio corpo non è stato lavato né messo in una bara accompagnato da litanie per essere portato in chiesa. Il mio funerale è rimasto lontano da cerimonie, rituali e tradizioni. Sono stato colpito in cima a una montagna e sono morto. Soldati come me sono colpiti a volte in una valle, a volte in una piana che si allunga all’infinito, e a volte in una trincea. Ed è molto probabile che il corpo rimanga lì dove è stato colpito. Sono morto. Prima ho sentito un bruciore nel petto, poi il sangue ritirarsi dalle vene. Le dita si sono allentate, l’arma mi è caduta dalle mani. Il rumore della pistola che colpisce la terra per un momento ha riempito l’intero universo. Poi non ho sentito più niente. Le ginocchia hanno ceduto. Mentre cercavo di calpestare la terra che mi scivolava sotto i piedi, sono caduto faccia a terra con il dolore che mi squartava il petto. Spine e schegge di pietra si sono infilzate nei miei palmi. Le rotule che hanno sbattuto contro le pietre si sono spezzate. Mentre mi dimenavo a terra in preda al dolore, i proiettili mi passavano sopra la testa con un fischio spaventoso. Mi sono portato la mano sul petto. La mano era fradicia di sangue. Ho guardato la roccia a qualche passo da me. I proiettili colpivano le pietre che mi stavano intorno. Ho cercato di trascinarmi dietro la roccia. Non mi era rimasta alcuna forza in corpo. Un percorso di due o tre passi sembrava infinito. Arrivato dietro la roccia ero un bagno di sangue e sudore. Appoggiate le spalle alla roccia ho cercato di prendere fiato profondamente. Ad ogni respiro, un grande bruciore nel petto… Mi girava la testa. Ho premuto la mano tremante sul petto. Con occhi semichiusi ho guardato il cielo. Il sole… Uccelli rapaci volteggiavano per aria. Ho pensato a mia madre che aspettava sperando di vedermi tornare. Mi avrebbe aspettato giorni e giorni. Non avrebbe creduto alla mia morte. Non avrà neppure una tomba dove piangermi. Che dolore per una madre… Ho cercato di scacciare questo pensiero ma il volto di mia madre non se ne è andato dai miei occhi. Ho guardato il cielo. E lì, sono morto. Mentre morivo in cima a quella montagna nessuno si è chinato su di me per dirmi: «Non morire», oppure «Vivrai». Con la mia solitudine, la mia sempre più ristretta speranza di vita si è cancellata completamente. La paura che il mio corpo sarebbe rimasto lì mi è calata addosso come brace.
Chiamatemi Ismail! Colpito, lontano da tutti in cima a una montagna. Il mio corpo è rimasto lì. Mia madre ha continuato a dire che non sono morto. Eppure io sono morto lì. I vestiti che ho addosso sono invecchiati. Il mio corpo si è decomposto poco a poco. Le bestie che hanno sentito l’odore della mia carne in decomposizione trascinato per monti e per valli sulla scia del vento, sono volate sul mio cadavere. Avvoltoi, volpi, sciacalli, lupi… Vermi bianchi hanno avvolto il mio corpo. Mangiando ogni giorno una parte di me, sono aumentati smisuratamente. Qui non c’è neppure l’oscurità densa di un cimitero. Ho visto tutto così com’era. Le mie pupille nere come il buio della notte si sono spalancate e bloccate. Spaventose mosche con occhi infiammati e ali nerissime. Sciami di mosche che si posavano e si allontanavano dal mio corpo. Ah, gli uccelli… Anche quelli si erano trasformati ognuno in una creatura selvaggia. Il sangue che gocciolava dal becco sporcava le piume. Ho potuto vedere la furia nei loro occhi mentre mi strappavano la carne col becco. Con le ali si pulivano il sangue sul becco. Gli artigli strappavano brandelli di carne dal corpo. In cima a questa montagna tutte le creature si sono trasformate in creature selvagge. Dopo essersi riempiti lo stomaco, mentre tornavano al loro nido, cominciava l’invasione dei predatori notturni.
Chiamatemi Ismail! Ho visto tutto. La più spaventosa oscurità della tomba era bella come il paradiso promesso in confronto a quello che ho visto. Mentre il mio corpo si disfaceva sotto il sole, aspiravo ai morti che giacevano sotto l’erba verde. I loro cari avrebbero almeno potuto dire “amato, figlio, madre, padre…” tra i fiori della tomba. Mi dispiaceva molto per mia madre. Del mio corpo esile e magro erano rimaste soltanto ossa. Formiche affamate hanno assalito anche quelle. Le foglie sono ingiallite, le piogge cominciate. L’odore di carne marcia è volato via. Mentre aspettavo pensando alla mia morte, d’un tratto è arrivato l’autunno. Nuvole nere hanno invaso il cielo azzurro. Un vento violento ha spaventato gli uccelli. Li ha trascinati lontano dietro alle ultime foglie. Ogni giorno che passava, spazzava via nel cielo ricordi di casa, di infanzia, di amori, come foglie autunnali nel vento. Sono rimaste soltanto ossa ripulite dalle vene e dalla carne. Ossa lavate dalla pioggia, brillanti sotto il sole… Ossa disseccate che danno l’impressione del nulla…
Chimatemi Ismail! Non è il nome che mi ha dato la mia famiglia. Nessuno mi ha mai chiamato così. Non è il nome con cui compaio nei registri del paese di cui sono cittadino. Probabilmente adesso la mia cartella è stata presa dagli scaffali dei vivi nell’archivio generale dell’anagrafe e messa tra le mensole dei morti abbandonate a marcire. Mentre osservavo i resti del mio corpo diventare terra sotto il cielo screziato di azzurro, d’un tratto mi è apparso Dio. Fino a quel giorno era come un deserto desolato ai miei occhi. Di tanto in tanto potevo sentire il camminamento delle formiche sulle mie ossa. Con l’apparizione dell’immagine di Dio, abbattute le mura davanti, un vento impietoso ha cominciato a soffiare da tutte le parti. L’avanzamento delle formiche è aumentato da far gemere cielo e terra. Nelle profondità del suolo si è levato un brusio spaventoso simile a un grido di terremoto. Tutto ciò che restava del mio corpo è trasalito. Non riuscivo a distinguere niente. Intorno era buio pesto. Una voce potente «Parla!» ha detto, «Parla in nome di tutti i tuoi simili, di tutte le vittime!». Il cielo scuro quanto un cuore umano mi è crollato addosso. Le mie ossa frustate dalla tempesta, bruciate dal sole, lavate dalla pioggia, sparse dal vento hanno cominciato a tremare. La mia mente stanca di dolore, noia, attesa, piena di incubi è caduta in un sonno profondo. Quando ho riaperto gli occhi tra il sonno e la veglia il cielo si stava illuminando. La faccia scura del cielo si trascinava dietro la luce pallida del mattino, verso le mie ossa. Ho chiuso gli occhi e sono sprofondato nei pensieri.
Chiamatemi Ismail! L’ho scelto io questo nome. Ho raccontato la mia storia in nome di tutti i miei simili. Le storie di chi ha sposato la morte si somigliano tutte. Io sono stato colpito in cima a una montagna. Un altro in una grotta… Un altro ancora è stato colpito tra gli arbusti. Alla fine o siamo morti o abbiamo ucciso. Questa è la nostra vita. Sono stato addestrato giorni per morire e per uccidere. Premendo il grilletto non ho pensato a altro che al mio bersaglio. Non ho neppure per un momento pensato alla famiglia o agli amici della persona che avrei ucciso. Sono certo che neanche chi mi ha colpito, premendo il grilletto, ha pensato a altro che a uccidermi. Ha mirato al petto e premuto forte sul grilletto. Tutto qui. Mentre urlavo disperato «Mi hanno colpito» ho sentito le grida di gioia del mio assassino che diceva «L’ho colpito, l’ho colpito!» La montagna mi girava intorno. Faticavo a respirare. L’arma mi è scivolata dalle mani ed è caduta a terra. Mi sono accasciato al suolo. I proiettili rimbalzavano sulle pietre spargendo scintille tutt’intorno. Attaccandomi a terra mi sono trascinato dietro la roccia. Rumori di spari, odore di sangue, odore di polvere da sparo… Ho sputato a terra. La mia salvia era sangue. Ho tirato fuori le fotografie dal portafoglio e le ho guardate. Ho pensato che non li avrei visti più. La paura della morte mi ha afferrato la coscienza piano piano. Ho pensato al primo giorno che avevo preso in mano una pistola. Mi sono venute in mente le parole dell’uomo di bassa statura, dalle sopracciglia folte che diceva: «In questo affare c’è la morte. Un soldato finisce all’altro mondo in un batter d’occhio senza trovare il tempo di capire cosa sia successo. Il minimo errore si paga con la vita.» Sono morto. Quando ho deciso di fare il soldato non mi erano ancora spuntati i baffi. Sul volto mi era appena comparsa una peluria dorata. Avevo molti piani per il futuro. Avevo persino pensato a cosa avrei fatto a quarant’anni. La notte in cui sarei partito sono salito in camera mia. Ho chiuso la porta. Mi sono spogliato il più lentamente possibile per far passare il tempo. Mi sono allungato sul letto sospirando forte. Ho cercato di dormire per ore. Ma non ho preso sonno neanche un minuto. Quando sono uscito di casa al mattino l’aria era cambiata. Al posto dell’aria trasparente e assolata c’era freddo, nebbia e nevischio. Tutto ciò che mi era stato detto mi sembrava banale. Non volevo ascoltare niente. Chi dava consigli, chi mostrava la via, chi si inorgogliva di uccidere e morire… Sono uscito senza neppure voltarmi a guardare il cancello del giardino della casa frustrata da anni di tempeste. Ho camminato per le strade, le vie della città. Nello zaino che avevo sulle spalle avevo infilato un paio di camicie, qualche pezzo di biancheria, l’occorrente per la barba e le calze. Il nevischio si è fermato d’un tratto. La nebbia si è dissolta velocemente. Di lì a poco il cielo si è rischiarato e i raggi del sole hanno nuovamente cominciato a illuminare i marciapiedi. Si udivano i suoni delle auto che avanzavano rade per le strade, le voci delle persone che camminavano gioiose, che ridevano allegre dalle finestre delle case sotto il sole brillante. Mi sono sentito male. Sono montato sull’auto per raggiungere la stazione. Sono salito sull’autobus. Ho osservato la folla che sollevava per aria il giovane che partiva per il militare. Forse poco dopo le stesse persone si sarebbero addossate sulle spalle il suo corpo morto per trasportarlo al cimitero. La folla che agita mani, fischia e distribuisce baci… E l’autobus si è lasciato alle spalle montagne, valli, città e paesi.
Sgusciando tra la folla della stazione ho cercato di trovare la mia destinazione. Ho atteso alla porta di una costruzione ingobbita. Dopo aver controllato i miei documenti mi hanno fatto entrare. Siamo andati in una stanza buia. Cinque o sei facce sedute a un tavolo mi hanno guardato. Come se l’assemblea dei dannati dell’inferno si fosse riunita intorno al tavolo. Chinando il capo, li ho ascoltati parlare. E così ho cominciato a fare il soldato.
Chiamatemi Ismail! Oh gente che dormite nei letti in nome dei quali siamo morti sulle montagne! Non avete accettato subito che siamo morti, eh? Come sempre nelle piazze avete detto che siamo immortali, non è vero? Eppure io sono morto. In cima a una montagna, lontano da tutto… Mi avete dimenticato. Come non fossi mai vissuto. Non abbiamo un nome. Tutta la nostra vita è ridotta a un numero. Il cielo che abbiamo guardato prima di morire ci ha bagnato gli occhi. Quel giorno ho pensato che sarei rimasto qui e il mio corpo si sarebbe dissolto poco a poco. Ho pianto. Prima a voce bassa, commosso. Ma poco dopo ho cominciato a singhiozzare sentendo molto più nel profondo. La mia faccia era torta di rabbia di fronte a quello che vedevo. Il mio sangue è colato a fiotti sulla terra. Non avete detto che la terra va innaffiata col sangue? Ecco, così è stato. Ah, queste terre. Di chi non sono state la tomba? Quanti loro abitanti hanno dissolto per sempre al loro interno? Il mio corpo si è sciolto pezzo per pezzo.
Non dimenticatemi.
Chiamatemi Ismail!
Traduzione G. Ansaldo
 Chiamatemi Ismail è un racconto di Yavuz Ekinci della raccolta omonima Bana Ismail Deyin pubblicata dalla casa editrice Doğan nel 2008. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2019 (su concessione dell’agenzia letteraria Ajans Letra).
Chiamatemi Ismail è un racconto di Yavuz Ekinci della raccolta omonima Bana Ismail Deyin pubblicata dalla casa editrice Doğan nel 2008. Diritti riservati per la traduzione italiana ©Kaleydoskop, 2019 (su concessione dell’agenzia letteraria Ajans Letra).

Yavuz Ekinci, nato a Batman nel 1979, ha studiato scienze dell’educazione all’Università Dicle di Siirt e letteratura turca all’università di Van.
I suoi racconti e i suoi cinque romanzi e una novella hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica. Le tre raccolte di racconti pubblicate tra il 2004 e il 2008 sono state insignite di numerosi premi, come il volume che dà il titolo al racconto qui presentato, insignito nel 2008 del prestigioso premio per il racconto Yunus Nadi. Molti suoi racconti sono già stati tradotti in inglese, tedesco, persiano, greco, giapponese e curdo e pubblicati su diverse riviste letterarie. In particolare l’ultimo romanzo “L’inquietudine del Profeta” pubblicato nel 2018 ha riscosso molto successo all’estero. Il racconto “Chiamatemi Ismail” presenta già le tracce della particolare ironia riferita al divino che sarà la chiave dei suoi lavori più recenti .
Illustrazione di copertina di Ignazio Liberto Brucato