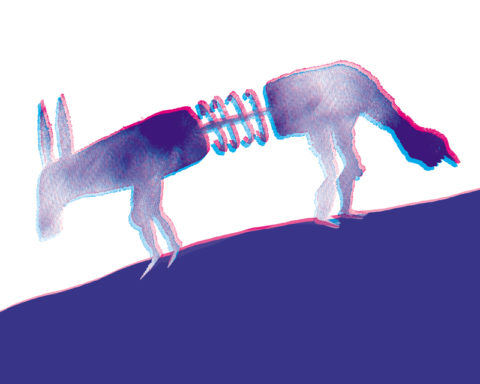Un racconto di Gönül Kıvılcım
Erano giorni che nevicava ininterrottamente. I rami spogli, dolenti, non avevano retto la neve accumulatasi e si erano piegati. Le automobili scivolavano come slitte sulle rampe ghiacciate, ma le loro fiancate trovavano subito il punto in cui sarebbero andare a sbattere.
E fu così che accadde il mio incontro con lui.
Era la mia giornata libera. Nessun programma preciso. Avrei camminato sulla neve, a lungo. Non avevo calcolato, però, che le strade si sarebbero trasformate in piste di ghiaccio. Dalla via che imboccai dopo Tünel svoltai a sinistra, poi subito a destra, passai davanti a un posto simile a un’officina e poi ecco un fruttivendolo. Una volta proseguito, lungo la discesa, avrei incontrato un edificio demolito, e da lì sarei andata avanti, fino alla torre di Galata. I miei stivali non me lo permisero. Non avevano la suola liscia, eppure scivolavano rovinosamente. Stavo giusto per tornare indietro, dopo un paio di tentativi, quando mi accorsi che qualcuno mi aveva presa a braccetto.
«Si fermi, l’aiuto io» irruppe lui.
Aveva un berretto nero. I ciuffi di capelli ricci che sbucavano fuori, imbiancati dalla neve. Fu istintivo: mi irrigidii. Ma stava nevicando, e la vita ci attrasse di colpo nel suo corso.
Dieci minuti dopo ci trovammo in una bettola buia a Galata. Hasan era il proprietario di questo locale poco frequentato, dove non sarei mai finita, neanche se avessi girato per giorni.
Giusto il tempo di un caffè e sarei scappata, così pensavo. Un cappuccino ricoperto di schiuma. Un discorso tira l’altro. Prima chiese in che quartiere abitavo. Kurtuluş, dissi.
«E tu?»
Viveva a Zeytinburnu, ovvero un rione che mi limitavo a lambire. Quanto a Kurtuluş, a lui ricordava solo il quartiere della taverna di Madame Despina. Non c’ero mai andata. Nonostante fossi un’istanbuliota stagionata, non ero nemmeno mai salita sulla Torre, il punto più alto delle mura di Galata, derelitte e diroccate.
«Lascia stare, tanto da lassù ognuno vede il luogo da cui proviene»
«Cioè?»
Ci allontanammo dal tavolo a cui eravamo seduti, come fossimo affacciati al balcone panoramico della Torre e col binocolo stessimo guardando l’orizzonte. Hasan, ora, indicava quella provincia così verde, fondata ai piedi di una terra montuosa, lontana centinaia di chilometri, a oriente.
Era nato nel cuore di Bisanzio, ma la sua anima era molto, molto distante. Può mai incidere sul destino di un uomo, il posto in cui quell’uomo non è nato?
Il mio soccorritore dai lucenti occhi verdi s’interruppe per accogliere gli avventori entrati in quel momento. Guardai la donna sfilarsi il berretto, l’uomo abbandonarsi sulla sedia, gli occhiali appannarsi.
Quando Hasan tornò da me, ogni cosa era ancora sotto terra. Parole, immagini, lacrime.
Di sua nonna, per esempio, deportata verso le montagne di Bursa, non aveva ancora pronunciato il nome. Zerya. Nel nuovo villaggio in cui era stata inviata per cinque anni, le montagne non le avrebbero restituito quel nome. Era un paese muto, che inghiottiva la storia, quello in cui giunse Zerya, dopo aver perduto casa, giardino, tombe. Con quella sua bella voce cantava lamenti al suo nome sparito, Zerya. «Noi diciamo lawike: lamento funebre; mia nonna la chiamano ancora ai funerali, a recitare quei canti. Per quello di suo nipote, morto in un incidente stradale, ha cantato per ben cinque ore di fila».
Zerya non era ancora andata a sussurrare il suo segreto a un pozzo. Quel segreto che sarebbe passato sotto terra, trovando la sua strada da un pozzo all’altro, fino a raggiungere l’orecchio di suo nipote Hasan. Tutta la famiglia veniva da altrove. Un altrove da cui tutto era andato via, perfino i venti che arieggiavano i forni di pietra.
Hasan era di Dersim.
E Zerya aveva quattro anni quando erano stati deportati: prima a Erzincan, da lì ad Ankara e poi a Bursa. Il suo cuore era così piccolo da non sapere se quello fosse l’est, l’ovest, il nord o il sud del proprio paese. Parlare con Hasan era come partecipare a uno scavo archeologico. Era verso il passato che si ridestava, Hasan. La sua anima vagava in quei luoghi, altri. Sapeva di essere di Dersim, nonostante fosse nato a Zeytinburnu, un quartiere di Istanbul. Lo sapeva perché non riusciva a spostarsi in nessun altro altrove. E nemmeno ad amare la cipolla.
«È casa mia, però quando ci vado non so starci. Resto dagli amici, a volte addirittura per strada. Anche per i miei zii è così».
Durante le deportazioni, Zerya aveva cominciato a detestare la cipolla. La povertà e l’istinto di sopravvivenza l’avevano spinta a mangiarne fino alla nausea. Una repulsione che avevano ereditato perfino i figli dei suoi figli.
Eppure anni prima la cipolla non era un boccone così amaro. E quando si erano messi in viaggio, lasciando tutto ciò a cui erano legati, Harşi non era ancora stato saccheggiato. Harşi, il loro villaggio.
Il passato a cui si rivolse Hasan non fu solamente un destino infausto. La mattina, al risveglio, come aveva visto fare a nonna Zerya, andava a baciare il punto lambito dai primi raggi di luce. Credeva anche lui nella prosperità donata dal sole. All’alba, poggiava le sue labbra ardite sul lembo di terra che il sole aveva illuminato per primo.
Sentivo freddo, ordinai un tè, stavolta. Il contatto col bicchiere mi scaldava i palmi. Mentre tenevo le mani incollate al mio bicchiere di tè, Hasan mi raccontò la storia della sua famiglia, che si estendeva prima fino a Bursa e poi a Isparta: la nonna, malata senza poter ricevere cure, essendo stato negato loro il permesso di lasciare il villaggio; il fratello, la madre, la propria infanzia a Zeytinburnu.
Hasan era ignaro del segreto sussurrato dalla nonna al pozzo. Ma i pozzi, profondi quanto i segreti, i pozzi vertiginosi, lo stavano chiamando. E come urlavano quei pozzi, che imprigionano le voci umane! Uno più profondo dell’altro, i pozzi dove si recava Zerya quando era sola per raccontare il suo abisso. «Ma dov’è che va, la nonna?» continuava a chiedersi curioso Hasan, rendendosi conto che la stava inseguendo. Più il dolore di Zerya si acuiva, più profondi diventavano i pozzi di cui andava in cerca. Così, il pozzo successivo era molto più profondo di quello precedente. Sulle orme della nonna, anche Hasan venne a scoprire i pozzi. Durante la sua infanzia a Zeytinburnu, c’erano dei magazzini appartenenti alle imprese di estrazione del carbone, e lì accanto una serie di pozzi. Con un amico, di Dersim come lui, giungevano attorno al pozzo, si sporgevano fino ai fianchi e puntando gli occhi sull’acqua, ne osservavano la profondità. Stando a guardare ancora un po’, lì dentro si formavano dei vortici lenti. Hasan non li dimenticò. Anni dopo, quando lesse la vita del virtuoso Ali, si recò anche lui a piangere su quei pozzi. Perché l’esilio non finiva, l’infanzia era conclusa, come la giovinezza, ma le deportazioni no. Oggi il mio verde vigneto è inaridito…
La madre intonava un türkü. Poi i canti curdi…
La volta in cui Hasan si fiondò per la strada senza aver dormito, il sole batteva dentro a un pozzo. Andò ad urlarvi la sua rabbia, ignaro del segreto della nonna. Proprio mentre stava gridando, accadde qualcosa che Hasan non si aspettava. Un uccello variopinto, di una razza sconosciuta, volteggiò per aria e andò a posarsi sul bordo del pozzo. Era un uccello molto strano, dal collo rosso. Ne arrivò un intero stormo. Ascoltavano Hasan immobili, senza aprire il becco. D’un tratto, come di comune accordo, sbatterono le ali, e raccolte le parole di Hasan, le sparsero nell’aria. Gli uccelli del pianto.
«Ero in seconda media» riprese Hasan «venne in classe la figlia di un militare. Dopo le lezioni andavamo insieme a giocare a pallacanestro. Ecco, così c’eravamo avvicinati. Erano di Balıkesir, me lo disse un giorno mentre andavamo in palestra e chiese di me, io risposi che ero di Dersim, provincia di Tunceli. Non la vidi più, mi tolse perfino il saluto».
«L’esilio è una crepa profonda» sento dire a me stessa. Sì, queste sono parole mie. Ma avrebbero potuto essere quelle di Hasan.
Hasan, il nipote di Zerya, spedita a Bursa e poi Isparta, che dopo i trent’anni aveva imparato a parlare turco e fare l’infermiera. Lo conosco un po’ meglio, col passare delle ore. Oppure credo che sia così. Quanto posso conoscerlo, con tutte le immagini e le lacrime ancora non scoperte dallo scavo?
Sono al bistrò. Guardo il volto di Hasan. Sua nonna crede nell’esistenza di Düzgün Baba.
Del quale si pensa protegga gli animali, e a lui si dedicano voti religiosi. Gli esseri viventi sono creature inestimabili nel suo credo.
Comprese le serpi, gli orsi. Compresi tutti.
Zerya si mette a chiacchierare con gli orsi che le tagliano la strada, quando si reca al villaggio, come gli altri infermieri di Pülümür. Perché gli orsi sono considerati sacri. Se non vi lasciano passare, vuol dire che siete stati voi a intralciargli la strada. Le succede spesso di aspettare fino all’imbrunire, in giornate simili.
Hale bere. Siamo preda del dolore. Adesso ho sulle labbra il canto preferito di Hasan. Imparo a memoria le strade del suo desolato cuore di Dersim.
Nel frattempo… Un nome dal passato, dal mio. Mi ricordo di Caner e rido. E mi rincuora saper ancora ridere, nonostante tutto. Caner, un amico segnato da altre ferite da deportazione, che aveva trascorso l’adolescenza ascoltando il Grup Yorum. Le canta ai concerti con i suoi amici, quelle strofe famose.
Lassù a Dersim in cima ai monti
A intonare i nostri canti
Caner ha un cuore sensibile verso gli esseri umani e le avventure audaci, però non conosce Dersim. C’è una strofa della canzone che confessa di storpiare così:
“Lassù a Mersin [1] in cima ai monti, a intonare i nostri canti”.
E, per giustificarsi, sottolinea che a quei tempi non c’era mica internet, e che in ogni caso non avrebbero potuto scrivere “Dersim”, talmente tutto era vietato…
Mentre glielo racconto, ridiamo insieme, per la prima volta, io e Hasan.
Molte cose sono ancora sommerse.
«Se solo potessi guardare anch’io, come gli altri, fermo sul Corno d’Oro, con serenità, verso Santa Sofia, la storica penisola rimasta sotto una cappa di aria inquinata…» riflette Hasan.
«Se tutto fosse un racconto. Questa città, questa storia, il passato, il sultano Selim “il Crudele”, le grandi spedizioni, tutti quei massacri ordinati dalle fetwa. Fino a…»
Fino a… Scavare e scoprire terre vere.
«Ho un altro fratello».
Il sole tocca dapprima le pareti giallo-ossido della mia stanza. Le bacio, con le labbra spaccate dai segreti che non posso confessare a nessuno. Sono una donna. Il mio nome è Nadya. Che sia Zerya, Hüma, o Nadya, rimango comunque una donna. Per ottenere il perdono, metto al mondo figli. Poi mi siedo e supplico gli altri, per la vita di quei miei figli.
Sono una donna e m’innamoro di uomini che non dovrei amare.
Si chiama Nadya, dice la famiglia dell’uomo. E ha pure un figlio. Che sia bella, interessante, il nome che porta è quello di una donna a te proibita. L’uomo è turco, il mio nome è Nadya, e quando sono nei guai, mi chiudo in cucina e faccio l’unica cosa di cui sia capace: parlo con Dio.
Come fa una persona a rimanere viva dopo tanto struggersi? – lo interrogo.
Una notte prima di incontrare Hasan, bevo senza riuscire a fermarmi; l’uomo che pensavo coraggioso vuole che lo perdoni, io bevo fino a vomitare, – non ha importanza – rifletto – che importanza vuoi che abbia – mi chiedo – non ti dimenticherò mai. Ma non posso distruggere la mia famiglia e andare avanti – non ha importanza – ripeto un’ultima volta.
Poi Hasan mi prende a braccetto… Seduti in quel bistrò dalle pareti che non si scaldano mai, scendiamo in riva al mare, giù per un percorso che mi è noto.
Conosco ciò che ha raccontato Hasan, questi gradini di pietra, lungo le scale vecchie case da demolire, gli alberi di fichi che aspettano taciturni il tempo dei loro frutti.
Prima di arrivare al mare, proprio dietro al fico, vecchi oggetti e vecchie poltrone abbandonate a destra e a manca, un giardino di cui non mi ero accorta prima e al centro del giardino solo un pozzo che non sapevo esistesse.
Sul bordo del pozzo, Hasan mi mormora il segreto della nonna.
Nonna Zerya non ha mai dimenticato Dersim. Il paese proibito.
Erano sei fratelli. Uno di loro scelse di non ricordare quei trasferimenti forzati. Di essere un’altra persona. Da Isparta scappò di nascosto a Smirne, abbandonando la famiglia. Mai pronunciata, “Dersim”. Finché…
«Un giorno, seduto su un pozzo dismesso, pensando alla mia infanzia, ai vortici della mia infanzia, arrivò un uccello bicolore, si posò sul ciglio del pozzo. “Ho ancora un altro fratello” sentii risuonare dal pozzo. Era la voce della nonna. Non potevo sbagliarmi, conoscevo la sua voce. Ma era impossibile: la nonna non aveva altri fratelli, che io sapessi. Allora mi ricordai dei dispersi di nonna Zerya. Il pozzo prosciugato restituiva un segreto che aveva inghiottito tanto tempo addietro. Andai a cercare nonna Zerya, come un forsennato. Quando la ritrovai, la presi per un braccio e la condussi al pozzo. Dapprima finse di non sentire la voce. Era stanca, la nonna. Ascoltava il suo segreto come fosse quello di qualcun altro. Non so quante volte sia riecheggiato, finalmente mi strinse la mano e d’un fiato confessò: “Sì, ho un altro fratello”.
Stavo su quel pozzo che aveva aspettato per così tanto tempo che io gli dessi ascolto. Il mio pianto scorreva assieme al pianto di mia nonna».
«Passarono sei mesi da quell’evento». Dal suo letto di morte, il fratello che si trovava a Smirne condivise la notizia: siamo venuti da Dersim. Ho un altro fratello.
Nell’aria ancora un lamento di uccelli.
Sì, era abbastanza aver ascoltato tutto ciò. Ormai potevo andarmene. Chiesi di pagare il conto. Alzandomi lo informai: «Tra poco me ne andrò di qui»
Non se l’aspettava, non riuscì a dire nulla.
«Il caos di Istanbul è troppo per me, ho deciso di trasferirmi in una piccola città»
Aspettava che fornissi altri chiarimenti. Ma come avrei potuto spiegargli tutto d’un fiato?
Abbi altrettanto coraggio per raccontare.
«Era una storia che attraversava il centro del paese» iniziai.
Imbarazzata, parlai del posto in cui l’avevo incontrato, delle sue lunghe dita, delle impronte che mi aveva lasciato addosso.
«Ora neanch’io riesco a trasferirmi altrove. Nella casa in cui vivevamo assieme, per esempio, non so metterci piede» aggiunsi. Tacevamo. Mi chiedevo a cosa stesse pensando. Scorrevano fiumi nell’oriente di questa nazione. L’Eufrate, il Tigri, il Munzur. Quelle acque in cui sua nonna si era lavata, forse. Forse vi aveva lavato la propria infanzia.
Ora la sentivo sul viso, la frescura di quelle acque.
Mentre stampavo dei baci di addio sulle guance barbute di Hasan, gli rivolsi la domanda che da ore mi occupava la mente.
«Quindi Hasan, se davvero un giorno ci andassimo, che cosa ne faremmo delle nostre tombe?» chiesi.
Hasan era scombussolato da quella frase che all’inizio della conversazione ero stata io ad ascoltare. Era giunto fin dentro a un bistrò, l’interrogativo di un’anziana donna di un villaggio sgomberato a Mardin. Mi accorsi del luccichio di quegli occhi verdi che probabilmente non avrei mai più rivisto.
Dentro rimaneva un solo avventore.
Mancava poco alla chiusura del locale.
«Non lo so – rispose Hasan – davvero non lo so».
[1] Mersin è una città dell’Anatolia sudorientale che affaccia sul Mediterraneo, completamente pianeggiante.
Traduzione dal turco di Fabrizia Vazzana


 Gönül Kıvılcım (7 aprile 1963) è una giornalista e autrice di racconti, romanzi e drammi teatrali.
Gönül Kıvılcım (7 aprile 1963) è una giornalista e autrice di racconti, romanzi e drammi teatrali.